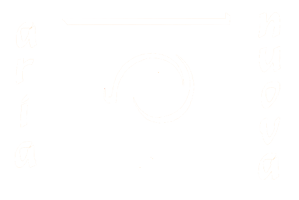Prima della scrittura
di Giacomo Colomba
Voltandosi indietro nel tempo qualsiasi civiltà propende a cercare (e spesso a trovare troppo forzatamente) la propria immagine nelle culture del passato.
È così che essendo abituati a ritenere la scrittura un segno distintivo della ‘civiltà’ e unico mezzo per perseverare nel tempo le testimonianze e i dati, siamo portati ha ritenere automaticamente le civiltà che non la utilizzavano o ne facevano uno scarso uso meno ‘civili’ di quelle alfabetizzate. Tant’è vero che l’aggettivo ‘analfabeta’ è universalmente sentito come un’offesa.
Eppure grandi civiltà di un passato non ancora ben definito (per adesso datato tra 9000 e 11000 anni fa) scelsero coscientemente di non utilizzare la scrittura e di fare pieno affidamento alla cultura orale. La civiltà dell’Indo-Saraswatî ad esempio, ha composto i Veda senza l’aiuto della scrittura (il solo Rig-Veda è composto da 10.589 versi!), facendo compiere delle prodigiose imprese mnemoniche a chi era tenuto ad apprenderli. Dall’estremo nord al profondo sud del subcontinente indiano i brahmini conoscono i testi verso per verso, senza la minima variazione di accento o di ritmo. Ad oggi, nonostante quasi tutti i cristiani abbiano una copia della Bibbia in casa, si contano sulle dita di una mano quelli che la conoscono a memoria (e quanti tra loro la leggono?).
Possiamo trovare nel Fedro di Platone alcune ragioni per le quali una civiltà può valutare la scrittura inutile, se non addirittura dannosa. Nel Fedro Platone fa riferire a Socrate che il dio Thot (colui che inventò il calcolo, i numeri, la geometria, il gioco dei dadi e l’alfabeto, ovvero il dio della ragione) avendo inventato la scrittura si era recato presso il dio Amon e lo aveva sollecitato a introdurla presso il popolo, con queste parole: «Questa scienza, o re, renderà gli egiziani più sapienti e arricchirà la loro memoria». Ma Amon rispose: «O ingegnosissimo Thot, una cosa è la potenza creatrice di arti nuove, altro è giudicare quale grado di danno e di utilità esse posseggano per coloro che le useranno. E così ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei inventore, hai esposto il contrario del suo vero effetto. Perché esso ingenererà oblio nelle anime di chi lo apprenderà: costoro cesseranno di esercitarsi la memoria perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente non più dall’interno di essi, ma dal di fuori, attraverso segni estranei: ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria, ma per richiamare alla mente. Né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l’apparenza perché, essi grazie a te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno di essere dottissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla».
In sostanza evinciamo che la scrittura elimina in gran parte l’esigenza della memoria.
Così come per i geroglifici delle prime dinastie egizie, i testi vedici sono shruti (verità udita e rivelata) e sono stati scritti in un’epoca in cui l’uomo aveva sviluppato una coscienza diversa da quella che impèra in quest’epoca. Percepivano la realtà attraverso l’intuizione e l’ispirazione, non usando ancora la speculazione o la riflessione. Lo sviluppo della speculazione e della riflessione ha atrofizzato le capacità intuitive tipiche dell’età vedica, creando un nuovo rapporto tra l’uomo e la realtà interiore ed esteriore. Per tentare di comprendere l’eredità dei rishi sarebbe necessario sviluppare in noi quelle facoltà che col susseguirsi delle ère si sono atrofizzate. Altrimenti non solo il significato dei loro simboli e della loro società rimarrà a noi precluso, ma ci saremo anche illusi di comprendere cosa vollero esprimere con il loro sublime e ispirato uso delle parole, che a quel tempo avevano un diverso rapporto con il loro significato.
L’idea stessa di religione vedica non sta in piedi. Sarebbe come se una società del futuro totalmente incentrata sul commercio e l’economia guardasse nel passato. Non potrebbe vedere in ogni museo, tempio, accademia, teatro e palestra altro che banche, mercati, piazze d’affari, magazzini e uffici.
La religione (nonché il sentimento religioso) è un approccio speculativo e razionale all’esperienza interiore o spirituale tipica dell’età moderna che ci stiamo lasciando alle spalle. Ma gli uomini dell’età vedica non avevano ancora abbandonato l’intuizione e l’ispirazione per sviluppare il raziocinio necessario allo sviluppo di una religione. Il loro rapporto con le esperienze interiori era libero e diretto. Non cercavano di formulare quello che ricevevano o sapevano, ma lo esprimevano in maniera ispirata per quello che era. Erano un popolo spirituale, non religioso. La spiritualità era il perno della loro esistenza e si ripercuoteva direttamente sulla loro vita esteriore senza diventare una regola o un’istituzione. L’incomprensibile linguaggio dei rishi, ricolmo di simboli e metafore perdute, assai semplice e ‘rurale’ (sempre nella sua bellezza e perfezione poetiche) contiene in nuce tutte le filosofie, le religioni e le scienze che si svilupperanno in seguito sul territorio indiano e si propagheranno negli altri territorî, tant’è vero che qualsiasi tradizione posteriore, per quanto vasta sia la sua ricchezza spirituale e filosofica, fa riferimento al Veda come la sorgente della ‘Conoscenza’.
Probabilmente sullo stesso principio dovevano basarsi altre civiltà che nello stesso periodo sorsero in altri continenti ma aventi (più o meno) le medesime caratteristiche di fondo, ovvero la civiltà dell’antico Egitto, quella mesopotamica, quella druidica che pur di non accettare la scrittura accordò un valore fonetico ai polpastrelli delle mani — lingua ogham inventata dal dio del sole —, e quelle ancor più sconosciute del Centroamerica che hanno lasciato in eredità idiomi molto simili (su tutti il naguatl) a quelli del subcontinente indiano. Probabilmente la civiltà dell’Indo-Saraswatî è stata l’unica che è riuscita a vivere il passaggio dall’èra dell’intuizione all’età della ragione facendo nel momento giusto ricorso alla scrittura (senza mai smettere di usare la memoria e la parola) e a lasciarci non solo in contatto con quell’èra dell’intuizione, ma anche con quella dei ‘progenitori’ — altro elemento comune a tutte le civiltà della stressa epoca — e delle loro conquiste spirituali che protessero dal diluvio e tramandarono direttamente ai rishi di ogni cultura.
Questi ‘avi immortali’ compagni degli dèi, con le loro conquiste spirituali (in Mesopotamia i sette saggi Ankallu o Apkallu che portarono la civiltà e la spiritualità dal mare, dove ogni tanto tornavano; in Egitto i sette provenienti dalla terra nativa degli esseri primordiali, uomini divini al pari degli dèi che portarono la civiltà e la spiritualità; in Centroamerica i Quetzacoatl — nome di un personaggio talvolta riferito a una categoria di civilizzatori che insegnarono agli uomini la civiltà, il senso della fratellanza e il culto del sole; e presso la civiltà precolombiana i Viracocha — personaggio pressoché identico a Quetzacoatl) portarono ai rishi, oltre che il Veda, la suggestione di un’antica civiltà vittima delle acque, dalla quale fuggirono per salvare la conoscenza (veda, appunto). Significativo è che questi sapienti viaggiassero nella nave (la parola vedica che significa barca — nau — significa anche ‘parola’ o ‘parola divina’, e quella che significa vascello — dhi — significa anche ‘pensiero’) di Manu durante il diluvio. Alla luce dei doppi sensi tanto familiari ai rishi potremmo tradurre il terminenaubandhana (dal Mahâbhârata) non tanto come “il luogo di ormeggio della nave”, quanto “il luogo di protezione della divina parola rivelata” — il Veda.
Novembre 2003