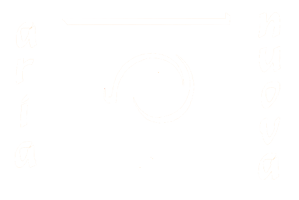I POETI VEGGENTI
POSSONO SALVARE IL MONDO?
di Marilde Longeri
È noto che siano i grandi libri a cercarci e non viceversa. Spesso quando ci ritroviamo in una libreria capita che un romanzo, una silloge, un saggio, in qualche modo si ergano fuori dagli scaffali per farsi notare. Così viene la tentazione di sfogliarli subito e il gioco è fatto. Usciremo con quel dato libro in tasca. Accade anche in casa propria. Magari da anni abbiamo riposto un certo saggio in un anfratto della libreria e un giorno lo vediamo con occhi particolari. Allora ci accostiamo incuriositi e più consapevoli lo rileggiamo. È il caso de Il tempo degli assassini di Henry Miller, un piccolo saggio che l’autore dedica all’immensa poesia e alla vita fuori contesto di Arthur Rimbaud. Miller disvela molte affinità fra la propria esistenza e quella del poeta-veggente. Praticamente fa suo il messaggio ancora vivo e eversivo di Rimbaud e lo scruta fino alle estreme conseguenze.
Stiamo parlando di un secolo molto lontano. Arthur Rimbaud nacque nel 1854 a Charleville (Ardenne) e morì nel 1891 a soli trentasette anni. Aveva però una tale lungimiranza dentro di sé, un tale fuoco esplosivo da risultare sempre attuale. Oggi potrebbe essere un no-global, un disobbediente, un anarchico, un poeta talmente al di là di ogni definizione da venire di nuovo rigettato dalla cultura dominante. Non si piegò infatti mai agli schemi stabiliti dal potere, derise gli accademici del tempo, si ribellò in ogni circostanza.
Peccato che in generale la scuola non permetta ai giovani di vivere la poesia come azione deflagrante in grado di rivoluzionare l’assetto dell’umano. Di solito si rende odiosa la poesia con affrettati riassunti, lunghi versi da imparare a memoria senza l’afflato della reale essenza. Il linguaggio appare giustamente lontano e indecifrabile a chi si nutre di internet e televisione e gli insegnanti non riescono a immetterlo nella vita ordinaria. La poesia rimane così aliena e criptica ad uso esclusivo di pochi eletti.
Arthur Rimbaud può invece rivelarsi, se compreso in tutta la sua sconcertante modernità, un mito per i giovani così come lo sono Che Guevara, i Rolling Stones, Jim Morrison (per citarne solo alcuni…)
Ecco le parole di Henry Miller: «[…] Chiamo poeta l’uomo in grado di mutare dal di dentro il mondo … Se il compito della poesia è di risvegliare, noi da molto tempo dovremmo essere stati risvegliati… Certuni lo sono stati. Ma ora tutti debbono essere risvegliati, altrimenti si perisce […]».
Può un poeta possedere i segreti dell’alchimia per mutare il corso della nostra esistenza?
Rispondiamo sì, se la poesia uscisse dalle biblioteche e venisse letta, decriptata, vissuta, approfondita in ogni dove come realtà del quotidiano. Poesia interpretata, assimilata dentro di sé e espletata poi in una ragnatela dorata di incentivi, di domande… di ritmi che si insinuano nella materia e con essa convivono.
Le migliaia di persone che affollano i Concerti Rock potrebbero subirne il fascino e con un sottofondo di musica che avvolga i vari versi, entrare nel vivo del significato e del suono. Poesia come appartenenza e identità.
Poesia come manifesto per l’esplorazione dell’Ignoto. Poesia che costruisce e non distrugge, che ripudia quindi le inutili e disumane guerre, la violenza frutto di atavica e perniciosa ignoranza, le stantie ideologie che balbettano nel vuoto.
Va però sottolineato che assai raramente l’esistenza dei poeti coincide con il loro mirabile versificare. Siamo ancora dentro i limiti dell’umano e quindi dobbiamo accettare il fatto che gli artisti della parola introducano il meglio di sé nella loro poesia. Lunghe ore di perfezione che non coincidono sempre con la realtà degli usuali comportamenti. Basta leggere le loro biografie. Si rimane spesso frastornati dalle dissonanze fra versi altissimi e vite carenti o disperate. Auspichiamo che un giorno arte e vita coincidano. Per arrivare a codesto traguardo, il lavoro da fare su se stessi è immane. Occorrerebbe non essere divisi. I fortunati momenti di estrema visione al di là delle apparenze e del mondo conosciuto dovrebbero infiltrarsi nei meandri del proprio subconscio e del proprio conscio.
Si può anche affermare che tutti – se abbiamo vista allargata e poniamo la sete di conoscenza al primo posto – possiamo divenire poeti. Magari non scriveremo versi ma adatteremo i vari ritmi e la magia del verbo al quotidiano. Una rivoluzione interiore senza armi.
Forse, dopo una cavalcata dentro il nostro mistero, capiremo il suono dell’albero, del fiore e della pietra, scruteremo chi ci cammina accanto con una sorta di identificazione, berremo a fonti sconosciute con i piedi ben affrancati al pianeta terra.
Pare finita l’epoca degli iniziati.
Dovremmo aprire le porte della poesia a tutti quelli che vivono il disagio del presente e chiedono Altro.
Ci viene incontro Henry Miller: «[…] Rimbaud non tentava di instaurare una nuova scuola artistica, allo scopo di dare un altro indirizzo ai rammolliti filatori di parole; indicava l’unione fra l’arte e la vita, componeva lo scisma, risanava la ferita mortale… All’inizio di Una stagione all’Inferno aveva urlato: ‘… di recente, sul punto di fare l’ultimo crac! ho pensato di cercare la chiave dell’antico festino, nel quale forse potrei riprendere appetito. Questa chiave è la carità – Questa aspirazione dimostra che ho sognato […]’ Sognato nell’Inferno, si capisce. Lui che si era chiamato mago e angelo, lui che si era liberato da ogni legame… lui che aveva creato ‘tutte le feste, tutti i trionfi, tutti i drammi’ ora è rigettato sulla terra… forzato ad abbracciare la cruda realtà […]».
Appare più che mai opportuno in questo oscuro periodo storico così intriso di violenza, di prevaricazione, di falsità e per contro dentro la retorica e l’ovvio di sacre famiglie, di perbenismo, di chiese subdole e intolleranti, di rigidità diffusa, risuscitare Rimbaud una figura visionaria, controcorrente, legata al volo dello spirito e alla pesantezza del materico. Al di là della nostra totale ammirazione per il poeta che ha “colorato le vocali” e degli incentivi forniti dal saggio di Henry Miller, i suoi versi visualizzano in forma sconcertante gli iniqui tormenti del nostro bagaglio esistenziale e aprono frammenti di bagliori verso la salvezza.
All’età di soli diciannove anni dopo aver creato una poesia strabiliante che oltrepassava di secoli il suo tempo, Rimbaud decide di non scrivere più e di buttarsi nell’azione. E l’azione, spesso distruttiva, diviene la sua poesia.
Percorre a piedi l’Europa, si imbarca su una nave dopo l’altra, giunge fino in Africa. Viene più volte rimpatriato, malato e senza soldi. L’avventura è il suo scopo, la sua passione. Si tuffa in mille lavori. Invece di creare assonanze con i versi, privilegia il commercio di avorio, fucili, spezie…
Impara molte lingue ma il vuoto è sempre in agguato… Il suo bellissimo volto aristocratico convive con un corpo forte e muscoloso di ceppo contadino e forse questa dicotomia di anima e corpo spiega in minima parte il suo lungo cammino nell’inferno.
Rimbaud voleva catturare a ogni costo la gioia e quando scoprì che per lui il tempo dello scrivere era finito la cercò con una sorta di eterna ansia in qualcosa che non capiva del tutto ma che sperava gli fornisse una rivelazione.
La seconda parte della sua esistenza ci appare così solo in apparenza contraddittoria.
Anticonformista nel vero senso della parola instaurò una burrascosa relazione omosessuale con Paul Verlaine sposato con Mathilde Mauté. Per Rimbaud, Verlaine lascerà la moglie. Memorabili le loro fughe.
A Parigi, sorseggiando assenzio, nei bistros discettano di poesia e della loro vita insieme, tessono arabescati progetti, sognano un mondo che si abbevera al daimon della creatività. I litigi però si susseguono in forma esponenziale. A Londra Verlaine, esasperato dal rifiuto dell’amico a rimanere con lui, gli tira due colpi di rivoltella. Rimbaud rimane leggermente ferito a un polso. Uscito dall’ospedale riprenderà la lunga strada dei suoi incredibili viaggi.
Verlaine forse non seppe arginare la bellezza e la forza di un ragazzo indomabile che era sempre molti passi avanti agli altri. Il nuovo spaventa e Rimbaud era troppo intriso di futuro per essere contenuto dal più conformista Verlaine.
Certamente riconobbe la genialità dell’amico perché gli dedicò un famoso saggio che rese famoso Rimbaud in tutta la Francia. Ne riportiamo un piccolo brano:
«[…] Noi abbiamo avuto la gioia di conoscere Arthur Rimbaud… Oggi certe faccende ci separano da lui senza che, al suo genio e al suo carattere sia mai mancata la nostra profondissima ammirazione… Il suo verso solidamente costruito ricorre molto di rado agli artifici… Sempre squisita la scelta delle parole… La lingua è netta e limpida. La Musa di Arthur prende tutti i toni, pizzica ogni corda dell’arpa, gratta tutte quelle della chitarra e carezza la ribeca con un archetto agile al sommo grado […]».
Risulta chiaro che l’immenso poeta francese si negò anche l’amore per inseguire l’ignoto e capire se stesso. Avendo respirato l’aria di vette inesplorate, essendosi immerso in un mondo di stranieri che parlavano la lingua dell’odioso buon senso, comprese che bisognava superare le colonne d’Ercole per carpire spezzoni di verità. E talvolta, anche nell’inferno africano gustò incredibili e inusitati splendori. Ma probabilmente non riuscì o non gli fu consentito guardare davvero oltre per affrancarsi all’indicibile.
Sempre in Una stagione all’Inferno, Rimbaud esplora il suo strazio e il suo scollamento dai contemporanei e per contro, con l’arte di un irrispettoso musicista, inneggia ancora e sempre alla vita:
«[…] Da molto tempo mi vantavo di possedere tutti i paesaggi possibili e trovavo da burla le celebrità della pittura e della poesia moderna… Sognavo crociate, viaggi di scoperte… repubbliche senza storia, guerre di religioni represse, rivoluzione del costume,
migrazioni di razze e continenti. Credevo a tutti gli incantamenti…
Inventai il colore delle vocali A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu… E… mi lusingai d’inventare un verbo poetico, accessibile, un giorno o l’altro a tutti i sensi… Scrivevo silenzi, notti, notavo l’inesprimibile. Fissavo vertigini… Dalla gioia assumevo una espressione il più possibile buffonesca e balzana:
È ritrovata!
Che? l’eternità. È il mare sciolto
nel sole […]
La Gioia era la mia fatalità, il mio rimorso, il mio verme; sempre la mia vita sarebbe stata troppo immensa per dedicarsi alla forza e alla bellezza […]».
La totale identificazione di Henry Miller con Rimbaud permette di scrutare gli occulti significati dei poeti-veggenti, di coloro che fuori dal tempo, dallo spazio e dal sogno, hanno lasciato impronte aliene sulle strade della terra.
«[…] Rimbaud — annota Miller — come lo vedo io fu un tipo evolutivo… L’evoluzione da lui compiuta nella prima parte della sua esistenza non riesce più sorprendente di quella della seconda. Siamo noi forse a non renderci conto della fase gloriosa in cui si prepara a entrare. Egli cala sotto al nostro orizzonte alla vigilia di un altro grande cambiamento, all’aprirsi del fruttuoso periodo in cui il poeta e l’uomo d’azione erano sul punto di fondersi… Fin dall’infanzia era stato un “fantastico”, un tipo a cui toccava andare in fondo o morire. In ciò consiste la sua purezza. Ritrovo in tutto questo le mie stesse difficoltà. Non ho mai abbandonato la lotta ma come mi è costata cara!... Il vero problema come Rimbaud ha scritto è … ‘di rendere mostruosa l’anima’ nel senso di portentosa […]».
Il “portentoso” di solito crea soggezione e paura. Siamo abituati a vite chiuse con sbarre di ferro alle finestre. Ognuno tenta di affermarsi, spesso vociando e prevaricando, nel proprio campo. Impossibile interagire, espandersi. Siamo seppelliti sotto macerie di ipocriti buoni sentimenti. Gli stessi sentimenti che una volta usciti da zone protette ci fanno abbracciare armi proprie e improprie per bombardare il vicino, torturarlo, trattarlo come insetto. In generale siamo fatalmente attratti da richiami futili che portano a diversificati livelli di inaridimento. Abbracciamo la sofferenza perché solo in essa ci riconosciamo. Dichiariamo di volere la gioia ma la ricerchiamo dove non la troveremo mai. Non crediamo certo ai poeti-veggenti. E’ più comodo aderire alle pressioni allucinanti dei poteri in carica. Imbelli, non abbiamo coraggio, non vogliamo fare alcun salto evolutivo. Rincorriamo l’effimero. Ancora una volta se incontrassimo il tipo Rimbaud lo lasceremmo perire in solitudine perché ci metterebbe troppo a nudo e avremmo timore della sua radicale rivolta e del suo desiderio di cambiare tutto in questo assurdo pianeta.
Nella lettera all’amico Paul Demeny, Rimbaud narra il pathos delle sue scorribande in zone sconosciute e descrive il vero significato di una vista allargata senza fingimenti: «[…] Dico che bisogna essere veggente, farsi veggente… Il Poeta diviene veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi… Mediante tutte le forme d’amore, di sofferenza, di follia, egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, per non conservarne che l’essenza… ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, nelle quali diviene il grande malato, il sommo criminale, il grande maledetto, e l’immenso sapiente… Egli raggiunge infatti l’ignoto… Allora il poeta è veramente il ladro di fuoco. Trovare una lingua… Questa lingua sarà dell’anima per l’anima, ingloberà tutto: profumi, suoni, colori, pensiero… La poesia non ritmerà l’azione… sarà sempre più avanti […]».
La veggenza dei poeti si perde nella notte dei tempi — basti pensare ai rishi vedici — e porta sempre dentro di sé una musica straordinaria che sembra non amalgamarsi con il nostro vissuto. Percepiamo a tratti che alcune verità potrebbero farci uscire dalla melma vischiosa, dalle fosse scavate dai poteri forti e dalla nostra negligenza verso l’essere libero, ma poi ci accontentiamo dello stato delle cose. Rimbaud ebbe il pregio di non accontentarsi mai, di percorrere la meraviglia e l’orrore con la medesima forza. Lui camminava a piedi perlustrando il globo. Era il suo modo per buttare alle ortiche le pestilenze esistenziali, i suoi impulsi più primitivi, l’angoscia e l’ombra. Usciva dalle sue passeggiate rinfrancato, pronto alla prossima sfida. “Il ladro di fuoco” buttava tizzoni ardenti prima di tutto su se stesso e poi sull’apparato costituito che gli sembrava già morto. Si narra che fosse d’animo estremamente gentile e che in Africa, nonostante certe zone grigie, seppe comprendere l’altro da sé e si entusiasmò di quella cultura tanto diversa dalla sua. Non era certo uomo afflitto da pregiudizi come tanti nostri contemporanei che parlano a vanvera (nel… migliore dei casi) o credono che l’Occidente sia il faro della civiltà globale.
I versi finali di Mattino d’Ebbrezza paiono il grido visionario di una intera umanità dolente, colma di veleni interiori e esteriori, che chiede alla vita d’essere “vissuta”: «[…] Piccola veglia d’ebbrezza, santa! Non foss’altro per la maschera che ci donasti. Ti afferriamo metodo! Non dimentichiamo che ieri hai glorificato ognuna delle nostre età. Abbiamo fede nel veleno.
Noi sappiamo ogni giorno donare la nostra vita intera.
Ecco il tempo degli ‘assassini’ […]».
Nessuno di noi, sotto uno stato d’ebbrezza o meno, sa donare la propria vita interamente. Troppo difficile anche identificarsi con tale azione. Aspettiamo sempre che siano altri nel bene e nel male a dare un senso al nostro personale cammino. E’ più rassicurante, più accettabile, scovare dipendenze apparentemente benevole o lupi mannari fuori dal piccolo nucleo. Non ci aggrappiamo alla consapevolezza, alla coscienza. Troviamo una giustificazione per tutto. Non vogliamo, salvo rare eccezioni, metterci in gioco. Ciechi come le talpe, abitiamo nelle loro stesse grotte. E nelle grotte edifichiamo i robusti castelli del non senso che continua a perseguitarci in un eterno ritorno.
Se potessimo visionare l’esistenza attraverso il montaggio di diverse sequenze come in un film renderemmo palesi le molteplici piccole e grandi azioni che hanno lasciato buchi neri, stridenti fascinazioni, disfacimenti in atto legati alla mancata evoluzione, a disastri esterni e privati… Non ci siamo ribellati, non abbiamo partecipato ai sottili richiami di altre sinfonie. Siamo figli di cattivi maestri che strisciano sulla terra con volti solo apparentemente umani… Henry Miller, attraverso Rimbaud, ci incita al cambiamento radicale: «[…] ‘Tutto quanto ci è stato insegnato è falso…’ proclamava Rimbaud… Aveva perfettamente ragione. Di fatto la nostra missione sulla terra è di contrastare i falsi insegnamenti, rivelando la verità che è in noi… Ma il miracolo più grande è quello di unificare gli esseri umani… Le bugie, le falsità, gli inganni… devono essere vissuti e superati mediante l’integrazione… Il processo va sotto il nome di sacrificio nel senso di sacrum facere […]».
Con il suo battello ebbro, Rimbaud, seppure dentro le contraddizioni dell’umano, spiccò il volo di angelo maledetto e scandagliò molti enigmi. Percepì che il cielo e la terra avrebbero potuto apparirgli in tutta la loro verità e mostrare quei segreti impossibili che andava ricercando fino all’annientamento. Seppe alzare la testa ma anche abbassarla. Aveva la consapevolezza della sua genialità ma non trovò una causa, un maestro di vita, che gli indicassero come contenere la sua “lucida follia” per poi farla procedere in fiumi rivelatori di luce. Solo, in un mondo impietoso che rifiuta chi non può comprendere si rivolse alle suggestioni del dionisiaco. Con i suoi versi creò allucinazioni per concentrarsi su molte verità in atto. Non si sentì mai a posto in nessun luogo della terra. Era assillato da domande che lo facevano bruciare dentro e non fu possibile la condivisione. La sua favolosa energia di corpo e anima richiedeva a ogni istante alleanze d’altri mondi, oasi, blasfemi contatti. Fino al suo ultimo respiro, consumato, senza una gamba ridotta in cancrena, non rinunciò alla lotta. Creava ancora utopie e il calvario al quale volutamente si sottopose amplifica forse la sua potenza… Al di là delle cadute egli rimane “il fiero Principe delle Ardenne” come lo definisce Henry Miller. Non resta che cavalcare il drago della fantasia e farsi trascinare dalle sue incredibili invocazioni poetiche.
La vita, la natura, l’evoluzione in atto non fanno sconti. O ci addestriamo a abbandonare l’obsoleto bagaglio dell’homo sapiens oppure continueremo a intossicarci, a fare del male, a non prendere nelle nostre mani i frutti rigogliosi che una esistenza autenticamente vissuta ci offre. Altri poeti hanno scritto versi intramontabili ma ci siamo soffermati per ora su Rimbaud perché la sua innocenza e giovinezza giungono come un grido infinito nel deserto che vale la pena di ascoltare, interpretare, fare proprio: «[…] Chi smuoverà il turbinio di furibondo fuoco
se non noi e quelli che percepiamo fratelli?
A noi! Amici romanzeschi: ci piacerà
mai noi lavoreremo
o flutti di fuoco! […]»
(da Il battello ebbro).
Dicembre 2006