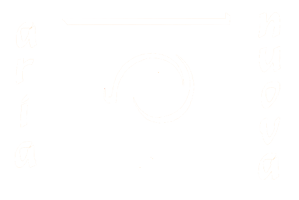Cineteca shakespeariana
a cura della redazione del sito arianuova.org
Nella sezione inglese del sito, abbiamo inserito una lista di films ispirati alle opere drammaturgiche del più grande teatrante di tutti i tempi: William Shakespeare (1564-1616). Qui vorremmo offrire le ragioni delle nostre scelte e commentare brevemente ogni singola pellicola, soprattutto in relazione al punteggio che abbiamo voluto dare a ciascun film selezionato (vai a Shakespearean Movies). Abbiamo infatti adottato un criterio di valutazione che va da uno a cinque pallini per indicare, in senso crescente, la nostra valutazione del film. In linea generale, diciamo che molti sono i fattori determinanti il punteggio finale; deve anzitutto esserci una intelligente e puntuale fedeltà al testo shakespeariano, con ottimi attori, preferibilmente inglesi (meglio se di teatro) o comunque con una padronanza dell’inglese tale da permettere di rispettare e valorizzare il pentametro giambico inglese (cosa che, per loro stessa ammissione, gli statunitensi, con quel loro americano biascicato, difficilmente riescono a produrre). Dopodiché, intervengono giudizi di merito più strettamente legati al linguaggio espressivo proprio del cinema: le scelte registiche, la fotografia, gli effetti visivi e la colonna sonora, il montaggio, l’impianto scenografico, fino ad arrivare a costumi, trucco e cura dei particolari più minuti. Inutile sottolineare l’ovvia soggettività e opinabilità di tutte le nostre scelte.
I films basati su drammaturgie di Shakespeare sono molti (circa 700), ma — come si vedrà — noi finora ne abbiamo scelti diciassette. Tra quelli che abbiamo scartato, vi sono realizzazioni illustri che però riteniamo nel complesso poco convincenti. Un esempio tra i più alti è rappresentato da ‘sir’ Laurence Olivier, grande attore teatrale inglese che si cimentò spesso come attore cinematografico, il quale realizzò alcuni films su testi shakespeariani, curandone anche la regia, come nel caso dell’Enrico V, nel 1944, in cui Olivier si è avvalso di una scenografia ispirata al cosiddetto arazzo di Bayeux e alle illustrazioni delle Très riches Heures du duc de Berry. Film di grande cura e bene interpretato, con scene memorabili, come la sequenza della carica di cavalleria nella battaglia di Azincourt, se viene tuttavia messo a confronto con la versione più tarda realizzata dall’attore e regista Kenneth Branagh, tutta l’inadeguatezza diventa palese, per non parlare del ‘taglio’ interpretativo (la prima, realizzata mentre stava per scoppiare la seconda guerra mondiale, appare un’esortazione alla guerra, mentre la seconda ricalca più fedelmente il testo shakespeariano nella sua lucida e amara riflessione sulla drammaticità della guerra quale male tristemente necessario). Laurence Olivier realizzò pure una versione dell’opera che vanta forse il maggior numero di realizzazioni cinematografiche (a partire da Georges Meliès, nel 1907): Amleto. Ma la riduzione di Olivier è pedante e noiosa, oltre che parziale. Di un certo interesse è poi il film realizzato nel 1952 da Joseph Mankiewicz sul Giulio Cesare, con Marlon Brando (Antonio), James Mason (Bruto), John Gieguld (Cassio); e tuttavia, si tratta di una versione nell’insieme faticosa e poco credibile. Citiamo infine, tra le pellicole che abbiamo scartato, Prospero’s Book di Peter Greenaway (basato su La Tempesta), del 1991, per la sua indubbia (a parer nostro eccessivamente barocca) originalità.
1. [••••] Il primo adattamento filmico di Shakespeare che abbiamo selezionato è il bellissimo Othello di Orson Welles, del 1951. La recitazione di Welles è calibrata e intensa, selvaggia e disinvolta, e la parte di Iago è felicemente affidata all’ottimo Michael MacLiammoir, perfetto nel ruolo (molto brave anche Suzanne Cloutier nel ruolo di Desdemona e Fay Compton nel ruolo di Emilia). La realizzazione — sofferta e frazionata nel tempo (occorsero tre anni per completarlo) — fu auto-finanziata, a causa dell’impossibilità da parte dell’autore di trovare un produttore. Girato in minima parte a Venezia e per la maggior parte nel nord-Africa, ebbe notevoli difficoltà e disavventure, talune che però si risolsero a vantaggio del film, come quando i costumi della scena del tentativo di assassinio di Cassio da parte di Roderigo e la successiva uccisione di questi da parte di Iago (Atto V, scena 1) tardarono a arrivare, motivo che costrinse Orson Welles (che, per il budget ridotto di cui disponeva, non poteva attendere oltre) a ripiegare verso un espediente che si rivelò poi felicissimo: ambientare l’intera scena in un bagno turco. Interpretazione coraggiosa, sanguigna e terrestre della tragedia shakespeariana, il film si distingue per la proteiformità della macchina da presa, per la forza visiva delle scene (l’influsso di Ejzenstejn è forte) e, come si diceva, per l’ottima recitazione. Il testo di Shakespeare risalirebbe al 1604 ed è una delle sue più intense creazioni quanto a ricchezza e varietà del linguaggio, acume psicologico e inventiva scenica, che trova il suo apice nell’immagine della sposa strangolata nei recessi di una fortezza militare, tanto più tetra quanto più fulgida si dimostra la sua innocenza. Ben risolte dalla sceneggiatura di Welles le difficoltà del testo shakespeariano, come per esempio il tempo dell’azione, in origine compresso oltre il credibile, mentre qui dilatato al punto giusto, lasciando cioè pieno spazio alla meditazione sulla caducità del tempo. Al di là di una facile e scontata interpretazione nel senso di una ‘tragedia della gelosia’, il testo nasce e si sviluppa dall’intima coesione di forze benefiche e disgregatrici, dall’amore di Otello e Desdemona che trionfa sulle differenze di razza e di cultura, ma anche dall’inerme candore e dall’irrisolto senso d’inferiorità di Otello in cui abile e spietata s’insinua la perfida gelosia di Iago. Tutto questo è ottimamente rappresentato nel film che, con un ritmo incalzante, e con una cura estrema per ogni più piccolo dettaglio. La versione restaurata rende ulteriore giustizia a questo capolavoro, calibrato con estrema precisione e pienamente riuscito in tutte le sue parti. La bellezza di alcune inquadrature ne fa una delle più belle produzioni cinematografiche in assoluto. Volendo a tutti i costi trovarvi un neo, possiamo dire che ci dispiace l’assenza del clown che Shakespeare aveva posto al seguito di Otello; nelle sue tragedie più riuscite, sempre il Bardo inserisce un clown, proprio per ribadire l’assoluta interdipendenza esistente fra tragedia e commedia.
Teniamo infine a citare un altro Othello cinematografico, realizzato in tempi più recenti da Oliver Parker. Per quanto complessivamente riuscito, con uno Iago del calibro di Kenneth Branagh e un Otello finalmente di colore (l’affascinante Laurence Fishburne), non regge il confronto con la pellicola di Orson Welles.
2. [••••] Quindici anni dopo, nel 1966, Orson Welles realizza anche Falstaff. Il film non si ispira a un solo testo teatrale di Shakespeare, ma ne prende in esame diversi (Enrico IV, Enrico V, Riccardo III, Le allegre comari di Windsor), allo scopo di porre in rilievo il personaggio meraviglioso di Jack Falstaff, la cui vitalità sovrabbondante è magistralmente interpretata da Orson Welles in quella che è forse la sua migliore prova d’attore (rendendo il personaggio perfettamente credibile perfino nell’aspetto fisico, attraverso un sapiente lavoro di immedesimazione in cui il trucco svolge una parte importante ma non centrale). Shakespeare è come soggiogato da questo personaggio e dalla sua bassa ma copiosissima umanità, e lo insegue, di dramma in dramma, fino a raccontarne la morte. «Perché Shakespeare ha ucciso Falstaff?», ebbe a domandarsi un critico come sir Arthur Quiller Couch. Ma Shakespeare non poteva non farlo: una volta ferito dal re nei sentimenti, non gli restava che morire. Falstaff rappresenta l’apogeo della carnalità, della rottura d’ogni freno morale; e Shakespeare voleva approfondire questo slancio vitale in tutta la sua grandezza fascinosa e fortemente eversiva, facendo apparire il personaggio non meno eroico e temerario di un sovrano. E il fatto che il Bardo ponga Falstaff proprio accanto a dei regnanti, ne accentua ulteriormente la valenza psicologica: il vigore umano di un Enrico V si è sviluppato nello stesso fecondo suolo di una profonda esperienza umana quale fu quella di Falstaff, come due volti di una medesima energia vitale. Il film mette in rilievo tutto questo, e altro ancora. Orson Welles sembra riversare per intero la propria passione registica e attoriale, oltre al proprio amore per Shakespeare, in questo film perlopiù sconosciuto ma meraviglioso. La scena della battaglia è davvero memorabile, e ha ispirato più d’un regista. La copia in nostro possesso, ancorché considerata una delle migliori esistenti, evidenzia la necessità di un quanto mai necessario lavoro di restauro. Forse l’utilizzo del bianco e nero — che Orson Welles prediligeva al colore — frena una sia pur dovuta rivalutazione di questo capolavoro.
3. [••] Con The Taming of the Shrew (‘La bisbetica domata’) di Franco Zeffirelli (datato 1966), scendiamo decisamente più in basso quanto a capacità di tradurre i testi di Shakespeare (questo risale al 1594) in linguaggio filmico, e tuttavia la coppia Elizabeth Taylor e Richard Burton (i quali hanno voluto perfino produrre questo film) è estremamente convincente (pur con qualche difetto nella dizione del blank verse) e riesce a sanare le pecche tipiche del cinema di Zeffirelli (eccessivo sentimentalismo, tendenza al melodramma, esasperazione gratuita del comico o del drammatico ai danni della sottigliezza di entrambi e della loro continua commistione, nella vita come nelle opere del Bardo). Purtroppo Zeffirelli, pur essendo uno dei pochi registi non inglesi a essere stato più volte acclamato nei teatri londinesi, nel cinema non riesce a contenere quell’atteggiamento — che nel teatro può avere una sua giustificazione — di esasperare le situazioni per dare maggiore forza di contrasto ai personaggi. Nel complesso, tuttavia, abbiamo deciso di non buttare giù dalla torre questa pellicola, che ha comunque una sua dignità e un suo valore. Lo stesso finale mette giustamente in rilievo l’ambiguità del messaggio di Shakespeare, che in apparenza sembra un manifesto a favore dello sciovinismo maschile (l’opera è ambientata nel XVI secolo), mentre in realtà ne mette in rilievo tutte le contraddizioni e lascia trapelare in filigrana una effettiva riscossa della donna grazie all’astuzia: sottomettendosi a Pertuccio, Caterina in realtà ha trovato un modo intelligente e sottile — quindi marcatamente femminile — per domare il proprio compagno. La trama originale (derivata in parte da I supposti di Ludovico Ariosto e in parte dalla novellistica medievale), è stata seguita con una certa fedeltà nella sceneggiatura realizzata da Suso Cecchi d’Amico e dallo stesso Zeffirelli, seppure epurando il Prologo, che poteva invece dare adito a spunti cinematografici interessanti. Le belle musiche di Nino Rota incorniciano le immagini.
4. [•••] Sempre di Franco Zeffirelli la versione da noi scelta (del 1968) della celebre tragedia di Romeo and Juliet (‘Romeo e Giulietta’), che ha conosciuto numerose trasposizioni cinematografiche più o meno fedeli; il romantico e tragico conflitto fra l’amore luminoso dei giovani protagonisti e i ciechi impedimenti del caso e dell’egoismo ha ispirato opere musicali, balletti e versioni cinematografiche sulle quali si riverbera la grande suggestione del dramma (basti pensare al musical West Side Story, con musiche di Leonard Bernstein e coreografie di Jerome Robbins). Suggestione di un amore innocente, indenne dal tocco gelido dell’esperienza, eccitato suo malgrado e alla fine distrutto dalla corsa contro il tempo, contro questo volto mutevole della fatalità. Celebre sia per l’acceso lirismo del linguaggio sia per l’abile tessitura dell’intreccio, è uno dei drammi di Shakespeare più popolari (la cui datazione viene fatta risalire al 1596). Il poeta e il drammaturgo coesistono in un equilibrio davvero unico, tanto da fornire, in uno degli intrecci più avvincenti e in scene fra le più famose del teatro di ogni tempo, un vero e proprio campionario di forme poetiche, ora drammatiche, ora argute, ora appassionate, volte comunque a rendere immortale la “dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo”. Tutte queste motivazioni rendono l’opera, per virtù di paradosso, molto ardua da rendere efficacemente al cinema. Molto facile, infatti, scivolare nel banalissimo melodramma sentimentale, oppure offrire più o meno inefficaci versioni ‘moderne’ dell’antica tragedia (originariamente ambientata nella Verona medioevale), trasportandola ai giorni nostri (come il Romeo+Juliet di Baz Luhrmann, con Leonardo Di Caprio). Franco Zeffirelli aveva rappresentato più volte in teatro il testo shakespeariano, dalla celebre messinscena all’Old Vic di Londra nel 1960 fino a quella che gli valse il premio del Festival del Teatro delle Nazioni, a Parigi. La sua versione cinematografica, pur con tutti i suoi limiti, si staglia molto al di sopra delle altre realizzate prima e dopo di questa. I dialoghi tra Romeo e Giulietta sono freschi e accattivanti, e gli attori, anche quelli giovanissimi (a partire dai due protagonisti, interpretati da Olivia Hussey e da Leonard Whiting), si mostrano all’altezza della situazione, pur senza particolari prove di bravura. Con un’unica eccezione, costituita dalla generosa caratterizzazione di John McEnery nei panni di Mercuzio, capace di calcare con disinvolta bravura il proprio personaggio senza mai eccedere in una recitazione ‘sopra le righe’.
5. [•••] Le più mature produzioni cinematografiche shakesperiane (e non solo) iniziano dagli anni Ottanta; e Henry V (‘Enrico V’) di Kenneth Branagh è stato realizzato nel 1989. Shakespeare, con quest’opera — del 1599 o giù di lì — chiude in bellezza la successione dei propri drammi storici. Il regista e attore irlandese Kenneth Branagh realizza questa pellicola altamente spettacolare all’età di 28 anni: è il suo primo film, e rivela immediatamente le doti di grande cineasta (come attore era già da alcuni anni altamente riconosciuto nei teatri inglesi). Per questa produzione egli dispone di un cast prestigioso, formato da Paul Scofield nel ruolo del sovrano francese, Judi Dench come Mistress Quickly, Ian Holm che interpreta Fluellen, Robbie Coltrane nei panni di Falstaff, Derek Jacobi a fare il coro, e poi Emma Thompson, Christian Bale e altri ancora. Con una suggestiva fotografia che riprende le tonalità dei pittori fiamminghi, Branagh ricostruisce nelle meravigliose scene di massa la battaglia di Azincurt tra Francia e Inghilterra in un’ampia e fedele ricostruzione storica, offrendo un affresco indimenticabile della Guerra dei Cent’anni. Ma, varcato il limite del carattere dichiaratamente nazionale del dramma (che rappresenta un limite anche da un punto di vista squisitamente poetico), l’opera appare nel film in tutto il suo splendore, dando il giusto rilievo alle figure di genere, che Shakespeare utilizza per darci la sua visione di studioso delle caratteristiche (e delle caratterizzazioni poetico-teatrali) dell’umanità nella sua variegata diversità, assumendo ognuna una determinata fisionomia che ne illumini e rilevi i contrasti drammatici (non altrettanto si può dire dei personaggi storici, la maggior parte dei quali pare abbiano una semplice funzione corale). Branagh interpreta con convinzione la figura del sovrano inglese, visto da Shakespeare come colui che nell’azione e nella parola, in pace e in guerra, esprime l’anima di un popolo e con essa un senso dell’ordine non formale, bensì organico e creatore. Le scene comiche del dramma contribuiscono, da parte loro, a alimentare il quadro della serie di tipi psicologici al seguito di re Enrico, dal flemmatico scozzese, all’iracondo irlandese, al gallese che si picca d’onore. Branagh pare invece non interessato a approfondire quella folla di figure secondarie presenti nel testo originale e che, per la verità, sono perlopiù ignorati anche dai più attenti registri teatrali shakespeariani. Abbiamo infine già accennato, in apertura dell’articolo, al taglio particolare del film nei confronti della guerra: le imponenti scene di massa mettono a nudo il sudore, il fango, il sangue, la sofferenza e la morte — non solo degli esseri umani, ma anche dei cavalli che prendono parte allo scontro. Fino al culmine, in cui la barbara uccisione dei giovanissimi araldi raggiunge l’apice della riflessione sulla fondamentale insensatezza della guerra.
6. [•••] È nuovamente Kenneth Branagh a portare Shakespeare sullo schermo, nel 1993, con un brillantissimo Much Ado About Nothing (‘Molto rumore per nulla’). Anche in questo caso, il cast è prestigioso: oltre allo stesso regista, figurano l’ottimo Denzel Washington, Richard Briers, Michael Keaton, Emma Thompson, Robert Sean Leonard, Keanu Reeves. Giovani attori, per la maggior parte, poiché l’opera è anzitutto un mirabile esempio della commedia come “mito della giovinezza” — i giovani, infatti, sono vere creature della mutabilità (gran tema elisabettiano): gli entusiasmi facili e la facilità all’eccesso, gli errori e gli egoismi, le arroganze e le crudeltà, i giochi e gli scherzi, le pretese di originalità che sono magari nuovi convenzionalismi, le sventatezze e la fragilità dei propositi ma anche la disponibilità al sacrificio o alla dedizione, l’avidità lupesca di possesso nella caccia alla dea bendata che, femmina, li adesca e fugge per i labirinti del Caso. Con tutta la sua ricca codificazione e la sua intessitura strutturale, Much Ado è una commedia breve e briosa, che scorre svelta nel suo dialogo velocissimo (nella valorizzazione del quale Branagh è un vero maestro), nella sua scrittura parlata (per quanto poetica), nell’alternarsi dei suoi motivi, nessuno dei quali è isolabile o ridondante o preponderante, con buona pace di chi ha pensato a lungo che la parte da privilegiare fosse la vicenda di Benedetto (qui interpretato dallo stesso Branagh) e Beatrice. La maestria tecnica dell’insieme è ammirevole, e in realtà anche gli elementi più secondari, anche le allusioni senza seguito appaiono funzionali, e il tutto è una delle più compatte, dinamiche e variegate opere di Shakespeare (scritta intorno al 1598): davvero una quintessenza della vita, resa con una macchina cinematografica di grande efficacia e di sorprendente naturalezza. Nella bellissima cornice di una villa immersa nelle colline della Toscana, Branagh offre la propria luminosa e scoppiettante versione di questa commedia che, oltre a descrivere con delicata poesia gli effetti estatici dell’innamoramento, è anche una trattazione critica e sferzante della fenomenologia dell’amore, visto come la trappola della Natura (secondo Ero), la danza della vita (aggiunge Beatrice), ed esso è anche (lo sa bene Benedetto) una irresistibile malattia della volontà e del sentimento, che pure offre all’essere umano motivo di grande gioia e, quando a lieto fine, di immensa serenità. Il livello farsesco — sviluppo del tema popolare che in tutti i custodi dell’ordine costituito vede degli sciocchi — della ronda notturna si rivela altamente efficace grazie alla irresistibile interpretazione di Michael Keaton; ma la sua funzione non si esaurisce nel riso suscitato dalla stoltezza e dagli svarioni di un gruppo di deficienti: la ronda partecipa al ‘gran rumore per nulla’ della recita inscenata dalla Fortuna, portatrice del tema dell’Elogio alla Follia di Erasmo e di Montaigne: «nostre sagesse est moins sage de la folie». Non è un caso che Shakespeare, al pari di Montaigne, non ci parla mai dell’essere ma del passaggio — il perenne divenire nel quale l’essere umano è un burattino nelle mani della Natura.
7. [••••] Il primo tentativo cinematografico davvero riuscito di trasporre un testo teatrale di Shakespeare ambientandolo nel XX secolo (nella fattispecie, nell’Inghilterra degli anni trenta) è rappresentato da Richard III (‘Riccardo III’) di Richard Loncraine, realizzato nel 1996. Uno dei punti di forza del film è certamente la presenza di un Ian McKellen in stato di grazia che, oltre a ricoprire il personaggio principale, è anche il curatore della sceneggiatura. Circondato da truppe in uniforme e esaltato da cerimoniali del terzo Reich, il duca di Gloucester costringe i nobili a incoronarlo, diventando così Riccardo III. L’intero cast in realtà è superlativo, e contribuisce al successo di questo film travolgente e ricco. La figura di Riccardo nel dramma di Shakespeare (risalente all’incirca al 1591) si presenta come coerente sviluppo e approfondimento del personaggio stigmatic, cioè segnato dal demonio, che già s’affaccia nella seconda e nella terza parte dell’Enrico VI. La fulminea, macbethiana rapidità di decisione e d’azione, di cui Riccardo rivela i piani e le trame micidiali agli spettatori, nei frequenti monologhi autoanalitici (e qui sovente McKellen guarda la cinepresa), scaturisce dalla sua febbrile brama di sovranità e da una sfavillante, demoniaca intelligenza. È questa a consentirgli di intuire i punti deboli dei suoi potenziali avversari (Lady Anne, Hastings, Buckingham, la regina Elisabetta) e di sfruttarli nella propria infernale strategia. Le due grandi scene di seduzione (di Lady Anne, per guadagnarsi il cuore e la mano, e della regina-madre per indurla a concedergli la figlia in moglie) sono le pause principali nel frenetico attivismo di Riccardo. Il mondo in cui si disfrena la nuda volontà di potenza di Riccardo non ha più nulla dell’atmosfera cavalleresca, eroica e araldica che ancora avvolge alcuni personaggi e situazioni nella trilogia dell’Enrico VI. È un mondo governato dagli appetiti, dalla ragion di stato, dalla violenza, la frode, il delirio e la febbre di dominio. Ecco perché ci sembra particolarmente azzeccata l’ambientazione storica del film. L’accordo voluttuoso del liuto che Gloucester evoca sdegnosamente nel primo monologo del dramma per dileggiarne le associazioni cortesi e languide, è posto in acuto contrasto con la scena di apertura, in cui un carro armato penetra sventrando la stanza del quartier generale; e, in seguito, con le aspre note del cupo stridulio delle porte della Torre che s’aprono e chiudono su Hastings, Clarence, e sui principi ereditari della corona regia; fino agli strepiti degli ordigni da guerra della battaglia finale: aerei, mitragliatori, esplosioni. Riccardo, dall’inizio alla fine, appare monolitico (seppure tutt’altro che statico) nella sua radicale malvagità. Un solo momento di “codarda coscienza”, risvegliata dopo un incubo avuto alla vigilia del fatale scontro, sembra fargli riconoscere la propria natura scellerata: senza rallegrarsene come negli altri monologhi, anzi sfiorando la disperazione e il terrore. Ma da ciò non nasce alcun ravvedimento, ed egli avanza deciso e diabolico verso la propria disfatta.
8. [••••] Considerata universalmente come esempio perfetto di commedia rinascimentale, Twelfth Night (‘La dodicesima notte’) è stata magistralmente trasformata in film nel 1996 da Trevor Nunn, che ha saputo mantenere la freschezza e l’inesauribile inventiva dell’azione e dei caratteri della materia comica anche grazie alla bravura corale degli attori; è sempre una bella esperienza osservare un gruppo di ottimi attori che cercano di dare ognuno il meglio di sé senza cercare di primeggiare (non è un caso che la commedia sia una delle preferite tra gli attori di teatro). D’altra parte, leggendo il testo originale (risalente al 1601, ma senza alcun dubbio posteriore all’Amleto — e l’accoppiamento è piuttosto significativo, per contrasto ma anche per affinità), è difficile individuare un personaggio principale: Malvolio, Olivia, Orsino, Sir Toby, Viola, Sir Andrew, sono tutti ugualmente importanti nel dare efficacia e forza all’azione. E che dire del Clown che, al pari di Amleto, è un finto pazzo che nutre assai poca fiducia nelle possibilità di ripristinare l’ordine là dove il caos ha dissociata l’armonia degli elementi? Il titolo della commedia shakespeariana allude all’atmosfera di spensieratezza e di gaia relatività di ogni valore che caratterizza il periodo fra Natale e lo scoccare della ‘dodicesima notte’, cioè la veglia dell’Epifania. Era questo, al tempo di Shakespeare, il periodo delle feste di corte in cui rivivevano tenui bagliori delle antiche festività ‘pagane’. Non a caso la commedia si snoda attraverso un doppio intreccio: l’uno romanzesco e sentimentale, l’altro farsesco e satirico. Perché gli elementi comici e parodistici hanno la funzione di mettere in risalto quelli sentimentali, di modo che la stessa materia amorosa vi appare esaltata e sottilmente derisa allo stesso tempo. Raramente infatti nella commedia i valori sono assoluti. Opera esemplare del genio comico di Shakespeare, anticipa anche sotto il profilo scenico il migliore Molière, lasciando trasparire nelle celebri arie musicali condiscendenza e lirica simpatia per le stravaganze e le ingenue follie degli uomini. Il sottotitolo dato da Shakespeare alla commedia, What you Will (‘Quel che volete’), è una sorta di invito allo spettatore a trovare un titolo da per sé, ove quello della dodicesima notte non lo soddisfi (l’anno prima, sulla medesima linea, Shakespeare aveva scritto la commedia intitolata As You Like It, ‘Come vi piace’), e ricorre piuttosto di frequente, nel Bardo, l’abitudine a dare dei titoli che pare non dicano nulla ma che, in realtà, spesso lasciano trapelare l’atmosfera dell’opera; nel titolo La dodicesima notte, infatti, per quel ricorrervi d’un numero pari e di un’ombra notturna, traspare una indicazione di equilibrio (è considerata la commedia più sapientemente bilanciata di Shakespeare) e di pacato distacco. E il film riesce a restituirne con rara sensibilità e maestria tutta la compostezza e la bellezza.
9. [•••••] La cinematografia shakespeariana arriva a un suo apogeo con il sublime Hamlet (‘Amleto’) di Kenneth Branagh, realizzato nel 1997. Shakespeare, giunto (nel 1601) sulla soglia della fase più intensa della propria ricerca poetica e umana, realizza questa grande tragedia sperimentale che possiede ancora il grato e fresco sapore di un frutto lievemente acerbo. Dietro i segni luttuosi che da sempre rendono emblematico il personaggio di Amleto — il pallore, la calzamaglia nera, il teschio della celebre scena del cimitero e, nel film, pur essendo a colori, l’avvincente gioco di contrasti tra bianco e nero, come l’impiantito dell’immenso salone reale —, dietro il proprio rifiuto alla vita, mette in atto una sua ambigua follia che costringe gli altri a scoprire la propria essenza, ad accettare il peso dell’espiazione (come la madre), a regredire in una immemore fanciullezza (come Ofelia), o a rifluire nel passato barbarico come accade a tutta la corte. Branagh, seguendo Shakespeare, ambienta il film in Danimarca, nel fantastico palazzo di Elsinore, ma sposta l’asse temporale sensibilmente (ed efficacemente) in avanti, verso la metà dell’Ottocento. E soprattutto ce ne offre, per la prima volta nel cinema, la versione integrale, offrendoci tuttavia un film di straordinaria fruibilità, pur avendo una durata di quattro ore. Girato in 70 mm da un direttore della fotografia del calibro di Alex Thompson, questo grandioso evento cinematografico si avvale di un prestigiosissimo cast internazionale, tra cui spiccano Charlton Heston, Julie Christie, Jack Lemmon, Billy Crystal, Kate Winslet, Derek Jacobi, Rufuss Sewell, e dove compaiono quasi di sfuggita (difficile però non notarli!) Gerard Depardieu, Robin Williams, e perfino sir John Gieguld nel ruolo-cammeo di Priamo evocato dal capocomico della compagnia degli attori che Amleto accoglie a Palazzo. Kenneth Branagh, nel ruolo principale, mostra con sorprendente disinvoltura e con una bravura che sfiora il sublime gli ampi registri espressivi di Amleto (in cui il comico e il drammatico si fondono in una unità inestricabile, esattamente come accade nella vita), le sue intramontabili riflessioni esistenziali, i suoi sdegni e le sue rivolte. Fiumi d’inchiostro sono stati versati per dare una interpretazione di questo meraviglioso personaggio shakesperiano, ma la grandezza intramontabile di quest’opera è data proprio dal fatto che ogni interpretazione, ancorché legittima, risulta alla fin fine parziale, e forse non c’è in assoluto nessuna altra opera che, al pari di questa, abbia saputo parlare a tutte le epoche, abbia sollecitato le analisi più diverse e sofisticate e, in ciò facendo, si sia continuamente rinnovata senza mai esaurirsi — come accade a ogni vera, grande opera d’arte. Kenneth Branagh è riuscito a risolvere al meglio tutte le insidie che una trasposizione cinematografica poteva presentare, consegnandoci un film coinvolgente, ricchissimo ma mai eccessivo, dove la cura meticolosa dei costumi, delle scenografie sfavillati, delle musiche (di Patrick Doyle), dell’agilità della macchina da presa e tutto il resto viene sempre messo al servizio della poesia, e mai utilizzato come fine a se stesso. Insomma, un lavoro superbo.
10. [••] Avvincente, pur se troppo smaccatamente spettacolare (con il rischio di sconfinare talvolta nel pacchiano), è il Titus (‘Tito Andronico’) che Julie Taymor realizza nel 1999. Si tratta di un dramma giovanile di Shakespeare, del 1593, improntato sullo stile delle tragedie di sangue e orrori senechiane (ma, a differenza di Seneca, Shakespeare mostra clamorosamente sulla scena gli orrori, anziché farli recitare a un Coro), temperata da una sensuosa liricità ovidiana (ma anche qui, a differenza di Ovidio, essa non viene trasmessa da una voce narrante, bensì innestata negli scambi drammatici). E in questa ardua commistione, e trasformazione, di modi teatrali e letterari sta forse la principale scommessa del giovane Shakespeare quando decise di cimentarsi in questa impresa (seguendo comunque un certo gusto elisabettiano, particolarmente evidente nella figura di Aaron). Siamo ai tempi del tardo Impero Romano, quando la coesione politica, e soprattutto i valori dell’onore e della pietas a essa connessi, tendono a sfaldarsi, sia per la pressione esterna (in questo caso, i Goti) che per la crisi interna delle istituzioni che conoscono una irreversibile decadenza. Tuttavia, malgrado i molti riferimenti specifici a luoghi e usanze romane, la collocazione storica dell’opera resta come sospesa, perché l’azione tragica esorbita ben presto a livello politico, ideologico, pubblico, configurandosi piuttosto come azione di vendetta in una faida di più ampio rilievo antropologico. Julie Taymor profitta di questa vaghezza per collocare l’opera in epoca tardo-impero ma, al tempo stesso, per condirla con costanti irruzioni di contemporaneità; così, assieme ai cavalli, alle bighe, alle toghe, irrompono autovetture, motociclette, vestiti moderni. Si vuole ribadire, infatti, che il senso della tragedia non è, se non in apertura e in chiusura del dramma, politico o ideologico. Il rapporto di forza tra romani e barbari è solo un pretesto; qui, piuttosto, il potere pare porsi su un piano tribale: potere di sopraffare, stuprare, mutilare, uccidere. Il conflitto non riguarda, in profondità, né le culture né i valori, ma viene giocato tutto a livello dei rapporti di sangue, in una essenzialità antropologica, che trova il suo paradigma centrale nella coesione familiare e nel suo opposto, la mutilazione, in quanto taglio del corpo tribale e del corpo individuale, recisione del legame essenziale della parte con il tutto: quindi, anzitutto, il legame tra figli e genitori, tra arti e la totalità corporea. Il taglio è sempre taglio di ‘rami’ di un intero, in una concezione cosmologica assolutamente organicistica. È una forma del tragico, quindi, che recupera antiche evidenze simboliche, e che, nello stesso tempo, tende a misurare l’azione in chiave catastrofica, sul fondo dell’immenso palcoscenico cosmico in cui è inscritta e da cui è generata la storia violenta degli uomini, sul cui senso viene chiesto di riflettere.
11. [•] Discontinuo ma nel complesso gradevole ci appare il A Midsummer’ Nights Dream (‘Sogno di una notte di mezza estate’) che Michael Hoffman realizzò nel 1999. Favola magica, “magnifica e misteriosa” (che Shakespeare scrisse intorno al 1596 e che ci è giunta in forma corretta, come purtroppo raramente accade per le sue opere) in cui i destini degli uomini si intrecciano in modo suggestivo e imprevedibile con quelli di divinità, fate ed elfi dei boschi, è resa qui in modo non del tutto convincente, principalmente perché nel suo tentativo di trasmettere a tutti i costi vitalità, manca proprio di vita genuina, di spontaneità, di potere di convinzione. In una limpida notte d’estate, il capriccio degli dèi scompagina il destino di due giovani coppie destinate a sposarsi il giorno dopo. Il film riprende tutta la lunga avventura dei boschi (che copre per intero il terzo e il quarto atto del testo drammaturgico) a volte in modo avvincente, ma con uno scarso senso dell’inventiva nel rappresentare adeguatamente gli elfi e il loro re (le fate, invece, risultano più credibili). E mentre un gruppo di attori improvvisati prepara lo spettacolo con cui allietare la grande festa (che è poi uno dei momenti più riusciti del film), la febbre d’amore si allarga a macchia d’olio su tutti quanti, per incantesimo. Come ci è già capitato di osservare in altre realizzazioni cinematografiche di questa serie shakespeariana, il film viene ambientato, anziché nell’antica Atene, in modo un po’ arbitrario (più per risolvere alla spicciola evidenti problemi scenici, crediamo, che per una qualche motivazione stilistico-espressiva) in tutt’altro luogo e epoca, ovvero tra le ridenti colline toscane alla fine del XIX secolo. Tutto sommato, comunque, il film si regge in piedi e ha una sua dignità. La cosa spiacevole è, semmai, constatare come con un identico dispendio di risorse e di attori si sarebbe potuto realizzare qualcosa di assai più incisivo. Il difetto del film, infatti, ci sembra risieda principalmente nell’incapacità del regista di dirigere in modo unitario i bravi attori di cui dispone. È un po’ come assistere a una grande opera sinfonica, dove il direttore d’orchestra si fida ciecamente dell’indiscussa bravura degli esecutori, e non si cura di lavorare pazientemente e metodicamente su di essi al fine di ottenere un risultato che egli crede già di per sé scontato, ottenuto mediante la semplice somma matematica di musicisti di riconosciuto valore. Purtroppo non è così, e questo film ne è la dimostrazione. Nel complesso il film si regge in piedi e ci pare accettabile (altrimenti, ovviamente, non l’avremmo inserito nelle nostre scelte), anche se non gli riesce di trasmettere appieno la bellezza del testo poetico, il cui lirismo è uno dei vertici del genio shakespeariano.
12. [••] La sfida di trasformare Love’s Labour’s Lost (‘Pene d’amor perdute’) in un musical sembrava destinata a fallire fin dal principio, e invece Kenneth Branagh riesce almeno parzialmente nell’intento. Dopo riflessioni e ripensamenti vari, nei quali cercò dapprima di mettere in musica i versi stessi di Shakespeare, animato ovviamente dal proposito di trasporre l’opera il più fedelmente possibile, si convinse alla fine a utilizzare canzoni già esistenti (alcune piuttosto note, tutte quante reinterpretate dagli attori del film in modo convincente), in una commistione che forse infastidisce il rigoroso critico shakespeariano ma che nel complesso funziona piuttosto bene (la realizzazione filmica è del 2000). In realtà, lo stesso testo (la cui datazione si aggira intorno al 1595) è stato condannato da alcuni critici, per il suo traboccare di bisticci verbali, frizzi e lazzi non sempre puliti e spesso barocchi. Ma è proprio nell’esuberanza verbale, generativa di un’azione che è in gran parte azione linguistica, che Branagh ha tratto il punto di forza del film, ponendo nel giusto risalto la tensione iperbolica dei modi di parlare e di essere dei personaggi che compongono la commedia. Il regista-attore pone in evidenza, su questa stessa linea interpretativa (anche grazie all’utilizzo di attori comici di grande levatura, come Nathan Lane nel ruolo del furbo Costard e Timothy Spall nel ridicolo don Adriano de Armado), il gustosissimo intreccio di alcuni subplots che si riallacciano alla commedia dell’arte e usano il bombastic speech per una precisa esigenza di idealizzamento della propria vita, nel tentativo disperato (comico e drammatico al tempo stesso) di trovare un’uscita dalle loro squallide esistenze per creare un mondo fittizio, per vivere almeno nelle parole e nella fantasia una vita meno insignificante e neutra. Tutto questo avviene con misurato equilibrio, giacché una eccessiva attenzione agli aspetti linguistici avrebbe fatto torto alla bella e semplice fabula della commedia: il giovane principe di Navarra e i suoi amici, per amore della filosofia, fanno voto di castità per tre anni, ma sono subito costretti a rimangiarsi la parola data, travolti dalla passione per la principessa di Francia e le sue damigelle, le quali spingeranno i tre più giovani pretendenti a una considerazione meno seriosa e rampante della vita, e quindi più matura e meno avventata. Non si capisce perché si sia voluto ambientare l’azione in epoca diversa (ovvero nella prima metà del XX secolo) da quella in cui i personaggi della commedia appartengono (alcuni sono infatti personaggi storici, per quanto deformati), se non per farceli apparire più vicini a noi nei loro sentimenti e nelle loro azioni (e il finale, in cui vengono sottilmente rievocati gli orrori della seconda guerra mondiale, è molto efficace in tal senso); resta il fatto che il musical appare nel complesso brillante e raffinato, ben recitato, ben cantato, e ben danzato (Matthew Lillard, quando danza, emerge suo malgrado al di sopra degli altri attori).
13. [••] «Forse sarò io la ragione per cui la gente accorrerà nelle sale, ma spero che quando le lasceranno, penseranno a Shakespeare» — così Al Pacino commenta quella che è senza dubbio una delle sue migliori prove d’attore cinematografico in The Merchant of Venice (‘Il mercante di Venezia’) di Michael Radford, realizzato nel 2004. E la scelta dell’attore nel ruolo dell’ebreo Shylock venne caldeggiata da Marlon Brando che, vistosi proporgli il ruolo, declinò l’offerta e disse: «La sola persona alla quale posso pensare, e che raccomanderei sinceramente, è Al Pacino». La sceneggiatura è fedelissima al testo originale (del 1597), seguendo atto per atto lo schema e i dialoghi del Bardo, mantenendo l’azione nello stesso periodo in cui originariamente venne ambientato il dramma, ovvero alle soglie del Seicento. Lo sceneggiatore riesce a volgere in positivo la possibile controversia che potrebbe venire generata dalla figura di Shylock — uno dei personaggi shakespeariani più discussi, in quanto propone un’immagine poco politically correct dell’usuraio ebreo —, proponendone una lettura che mostra la difficoltà di integrazione tra due etnie che non si capiscono. Shylock appare così una vittima del suo tempo, una persona che, per la sua diversità, la Venezia cattolica di allora aveva costretto a vivere nel ghetto (non dimentichiamoci infatti che i più grandi antisemiti della storia, ben prima del nazismo, furono proprio i cristiani, i quali spesso mandarono gli ebrei sul rogo dell’Inquisizione), e alla quale non era permesso possedere terre (da qui la scelta forzata a fare uno dei pochi lavori che al tempo era concesso agli ebrei: prestare denaro a usura). Già all’inizio dell’Ottocento, in realtà, il grande attore Edmund Kean diede al personaggio una interpretazione di questo taglio, facendolo apparire certo malevolo, ma anche discriminato e maltrattato, e quindi oggetto di repulsione come di pietà. E, a voler leggere attentamente il testo shakespeariano, il razzismo e il disprezzo di Antonio lasciano emergere un meccanismo proiettivo — così, colui che vorrebbe proporsi come l’eroe positivo, non è che il primo dei personaggi ipocriti e ambigui che si muovono in questo dramma (e, più in generale, nel palcoscenico del mondo). Nei secoli, si è a lungo discusso se quest’opera fosse una commedia oppure una tragedia. Attori comici e attori drammatici si sono alternati sulla scena per rivestire i panni dell’ebreo ma, alla fine, la scelta più giusta sembra quella operata dallo stesso Radford, che lo fa apparire come una figura maestosa e tragica.
14. [••••] Kenneth Branagh è ormai una garanzia di fedeltà e bellezza nelle versioni cinematografiche shakespeariane. E nel 2006 traspone la commedia As You Like It (‘Come vi piace’) in modo superlativo. Considerata dai critici “la più romantica delle commedie romantiche di Shakespeare”, essa intreccia sullo sfondo della foresta di Arden (luogo interiore, immaginata proiezione di un desiderio di purezza, vagheggiamento di una mitica età aurea e di ritorno alla matrice — non a caso Shakespeare utilizza il cognome della propria madre per connotare questo luogo dell’anima) trame sovrapposte, equivoci, intrighi e passioni inconsapevolmente ambigue, mostrando tutte le possibili sfumature del sentimento d’amore. Il tutto in aperta contrapposizione con l’aspra realtà di sopraffazioni e violenze della corte dell’usurpatore Frederick. Dominata da un costante ritmo binario, la commedia si snoda in un gioco continuo e sapiente di contrasti che giungono a capovolgere l’apparente, fiabesca ‘felicità’ della trama con la creazione di personaggi capaci di dare vita a riflessioni sulle età della vita e sull’umana esistenza. Branagh — qui unicamente in veste di regista e non di attore — ambienta con rara efficacia la commedia in Giappone, sottolineando in questo modo il valore della deliberata ironia del titolo: infatti, solo la drammaturgia orientale potrebbe totalmente specchiarsi in questa commedia, dove il lieto fine abbraccia tutti quanti i personaggi, compresi quelli più malvagi e perversi; ognuno qui trova un proprio riscatto, una propria felicità o redenzione. Shakespeare ben sapeva che in questo modo si soddisfano più i desideri del pubblico (As you like it: come piace a voi) che non una reale aderenza alla realtà delle cose, ove purtroppo il lieto fine non è così diffuso e equo. L’ambientazione permette di risolvere nel modo migliore anche i più minuti dettagli (come nella seconda scena del primo atto, in cui il wrestler viene trasformato da Branagh in un lottatore di sumo). Bella la fotografia, ammirevoli le ricostruzioni d’interni, preziosi i costumi, ottima la recitazione di tutti quanti gli attori, alcuni dei quali sono grossi nomi di fama internazionale (Adrian Lester, Kevin Kline), altri non meno talentuosi ma di fama ristretta all’ambito teatrale inglese. Di particolare rilievo la figura del nobile re esiliato (interpretato da Brian Blessed), che mostra la rara saggezza di chi, avendo conosciuto e apprezzato a fondo i fasti di corte, costretto a vivere in una foresta, sa apprezzare e godere altrettanto bene la vita pastorale, trasformando l’indigenza in una sorta di Arcadia.
15. [••] L’attore inglese Ralph Fiennes esordisce dietro la macchina da presa nel 2010 con la tragedia Coriolanus (‘Coriolano’), oltre a rivestire i panni del protagonista. Nella versione originale (datata 1608), Coriolano è un condottiero romano che tenta la scalata verso il potere poco dopo la cacciata dei re etruschi della dinastia dei Tarquini, mentre nel film di Fiennes si tratta di un regime militare ambientato ai nostri giorni. La trama dell’opera è ispirata alla vita di Caio Marzio Coriolano, così come descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell’Ab Urbe condita di Tito Livio. La città è in preda a una sommossa dopo che le scorte di grano sono state negate al popolo; i rivoltosi sono arrabbiati con Caio Marzio, che incolpano della sparizione delle scorte alimentari. Incontrano dapprima il patrizio Menenio Agrippa, quindi Caio Marzio stesso. Menenio tenta di placare i rivoltosi, mentre Coriolano si mostra sprezzante e dice che i plebei non meritano il grano perché non hanno servito l’esercito. Due tribuni della plebe, Bruto e Sicinio, denunciano personalmente Caio Marzio che lascia Roma quando giunge la notizia che l’esercito dei Volsci è pronto a dare battaglia. Il capo dell’esercito dei Volsci, Tullo Aufidio (interpretato da Gerald Butler), si è varie volte scontrato con Caio Marzio e lo considera un nemico giurato. Caio Marzio si distingue in battaglia per il suo incredibile valore, perciò Comino, il generale dell’esercito romano, concede a Marzio il soprannome onorifico di ‘Coriolanus’. Quando tornano a Roma Volumnia, la madre di Coriolano, incoraggia il figlio a candidarsi alla carica di console. Grazie al sostegno del Senato vince senza difficoltà e sulle prime sembra avere la meglio anche sugli oppositori della fazione popolare. Tuttavia Bruto e Sicinio tramano per distruggerlo e aizzano una rivolta contro la sua elezione a console. Di fronte di tutto ciò Coriolano si infuria e critica duramente il concetto di governo del popolo. Per queste parole i due tribuni lo condannano come traditore e ordinano che sia mandato in esilio.
Dopo essere stato esiliato da Roma, Coriolano si reca da Aufidio nella capitale dei Volsci e gli propone di guidare il suo esercito alla vittoria contro Roma. Aufidio e i nobili Volsci abbracciano Coriolano e gli concedono di condurre un nuovo assalto contro la città. Roma, in preda al panico, cerca disperatamente di convincere Coriolano di abbandonare i suoi propositi di vendetta, ma né Cominio né Menenio riescono nell’intento. A questo punto viene mandata a incontrare il figlio Volumnia, insieme alla moglie e al figlio di Coriolano: la donna riesce a dissuadere il figlio dal distruggere Roma. Invece di muovere battaglia conclude un trattato di pace tra i Volsci e i Romani. Quando però Coriolano torna nella capitale dei Volsci, dei congiurati guidati da Aufidio lo uccidono per il suo tradimento.
16. [••] In un nuovo adattamento cinematografico che celebra il 400° anniversario del capolavoro shakespeariano (del 1612), The Tempest (“La Tempesta”), ripropone una delle più amate opere del Bardo in una trasposizione della regista Julie Taymor, decisamente più convincente della stravagante versione realizzata nel 2001 da Peter Greenaway (con John Gieguld nei panni del protagonista). La regista ha cambiato sesso al mago Prospero, trasformato in Prospera (magistralmente interpretata da Helen Mirren). Tradizionalmente ritenuta la penultima opera di William Shakespeare, pare fosse quella che segnò l’addio alle scene del celebre drammaturgo (almeno come attore). Il racconto della commedia inizia quando gran parte degli eventi sono già accaduti. Il mago Prospero, legittimo Duca di Milano, e sua figlia Miranda sono stati esiliati per circa dodici anni in un’isola dopo che il geloso fratello di Prospero, Antonio, aiutato dal re di Napoli, lo aveva deposto e fatto allontanare con la figlia di tre anni. In possesso di arti magiche dovute alla sua grande conoscenza e alla sua prodigiosa biblioteca, Prospero è servito da uno spirito, Ariel, che egli ha liberato dall’albero dentro il quale era intrappolato (dalla strega africana Sicorace, esiliata nell’isola e morta prima dell’arrivo di Prospero). Il figlio della strega, Calibano, un mostro deforme, è l’unico abitante mortale dell’isola all’arrivo di Prospero. Provocato dall’avvenenza di Miranda, le propone di unirsi con lui per creare una nuova razza che popoli l’isola. A questo punto inizia la commedia shakespeariana. Prospero, avendo previsto che il fratello Antonio sarebbe passato nei pressi dell’isola con una nave, scatena una tempesta che causa il naufragio. Sulla nave c’è anche il re Alonso e il di lui figlio Ferdinando. Prospero, con i suoi incantesimi, riesce a separare tutti i superstiti del naufragio cosicché Alonso e Ferdinando credono ognuno che l’altro sia morto. La narrazione è tutta incentrata sulla figura di Prospero, il quale, con la sua arte magica, tesse delle trame in cui costringe gli altri personaggi a muoversi. La commedia ha quindi una struttura divergente e, poi, convergente, in quanto i percorsi dei vari naufraghi si ricongiungono alla grotta di Prospero. Calibano incappa in Stefano e Trinculo, due ubriaconi della ciurma, che crede esseri divini discesi dalla luna, e cercano di mettere insieme una ribellione contro Prospero, che però fallisce. Nel frattempo, nasce una relazione romantica tra Ferdinando e Miranda. I due si innamorano immediatamente. Infatti il loro matrimonio sarà la causa della riconciliazione di Prospero con suo fratello Antonio. In conclusione, Prospero rinuncia alla magia e getta in mare i libri di occultismo.
17. [•••] Dopo una ventina di tentativi — per citare i tre più interessanti: quello di Orson Welles (nel 1948, con un budget ridottissimo), di Akira Kurosawa (“Il trono di sangue”, 1957) e di Roman Polanski (1971) — di realizzare un film sulla tragedia di Macbeth (la cui drammaturgia risale al 1606 ed è basata su un’antica leggenda celtica), il regista Justin Kurzel (al suo secondo lungometraggio) centra il bersaglio in questa versione realizzata nel 2015. Dal punto di vista strettamente drammaturgico, si tratta di un testo ricco di ambiguità (come diverse altre opere del corpus shakespeariano, peraltro), atta a fornire una varietà pressoché infinita di letture. La vicenda è, tutto sommato, lineare: Macbeth, incitato dall’ambiziosa moglie e dal responso di una profezia di tre streghe (nel film sono quattro, coprenti diverse fasce di età — espediente che, purtroppo, indebolisce un poco la loro forza iconografica e simbolica quali agenti del caos, forze misteriose che fanno precipitare le umane vicende: il fatto che fossero un terzetto era importante in Shakespeare, anche per via dell'abbondanza di triadi femminili nei miti classici) che lo prevede incoronato re, uccide brutalmente il re Duncan di Scozia. Per assicurarsi il trono, fa assassinare poi il suo fedele compagno e amico Banquo, al quale le streghe avevano promesso di diventare padre di una stirpe di re. La scia di violenza prosegue; Lady Macbeth, che ha incitato il marito nel compiere tali azioni di sangue, ha un crollo mentale e, poco dopo, muore. E Macbeth, alla fine, schiavo delle predizioni delle streghe, viene ucciso dai rivoltosi che riportano sul trono il legittimo erede Malcolm. Kurzel realizza la messinscena in una Scozia assai suggestiva, che ricalca la psicologia dei personaggi principali, utilizzando costumi essenziali, come si addice a un film in costume ambientato in una antichità pre-classica, ma avendo cura di realizzare un prodotto esteticamente ammirevole, anche in virtù delle atmosfere ovattate e oniriche, con immagini di grande potenza (predominano gli esterni, sfruttando la luce naturale e la bellezza dei paesaggi scozzesi, mentre gli interni sono illuminati dalle luci delle candele), fra le nebbie della brughiera intrisa di pioggia, e paesaggi aspri punteggiati di laghi e di neve, dai colori sempre più saturi, fino al rosso finale del fuoco e del tramonto. L’adattamento è sufficientemente fedele al testo di Shakespeare; tra i tagli effettuati, il più imperdonabile è quello che riguarda quasi per intero la mirabile scena — la seconda del secondo atto — che, in un crescendo di tensione, giunge al suo apice quando il protagonista dice che gli è parso di udire una voce gridare: «Macbeth does murder Sleep, — the innocent Sleep», producendo una delle più intense espressioni poetiche della letteratura universale e, insieme, uno dei momenti più puramente drammatici (privo di enfasi e di retorica, tanto asciutto quanto potentemente veridico) del teatro mondiale. A ogni modo, l’interpretazione di Michael Fassbender è magistrale, capace di comunicare con la sola forza dello sguardo le mille sfumature della metamorfosi del protagonista. Marion Cotillard è una Lady Macbeth dal viso angelico e l’animo corrotto, una potenza nera di gelida crudeltà, che manovra il coniuge come un pupazzo, fino a essere travolta dalle forze brutali che ha evocato (troppo sbrigativamente viene trattata la sua morte, purtroppo). Un’ultima osservazione riguarda l’impianto generale, e il discorso si può facilmente allargare a qualunque adattamento shakespeariano: i registi cinematografici dovrebbero evitare di incasellare le drammaturgie di Shakespeare in interpretazioni psicoanalitiche più o meno inadeguate... Da troppi decenni ci si stupisce di come Shakespeare, diversi secoli prima di Freud, abbia potuto gettare lumi su aspetti caratteriali e comportamentali implicanti precise conoscenze psicoanalitiche. Bisognerebbe, piuttosto, cominciare a stupirsi di quanto Shakespeare fosse ben oltre la psicoanalisi, freudiana o contemporanea. Questa tendenza a voler costringere un’opera teatrale entro la limitata cornice delle conoscenze scientifiche del proprio tempo, rende la resa molto à la page (il che, per una regia teatrale, può avere una sua giustificazione, se motivata da intenti sinceri e non da volgari ambizioni commerciali), ma drammaticamente soggetta a un rapido invecchiamento (gli adattamenti filmici delle opere del Bardo destinati a perdurare, sono proprio quelli che evitano accuratamente di cadere in simili trappole). Shakespeare si spiega da sé, non abbisogna di grucce interpretative intessute su “disturbi post-traumatici da stress” e “complessi psicanalitici” di sorta.