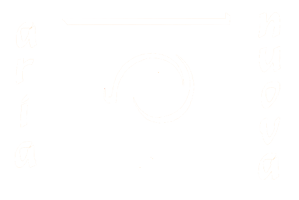IL MANTRA,
SUONO COSMICO PRIMORDIALE
di Mario Gregori
(Da “Occidente buddista”, Anno I, n. 9 — Novembre 1996)
Sulla pratica del mantra, elemento di indubbio fascino per coloro che si avvicinano allo studio e alla pratica delle discipline orientali, non si può proprio dire che manchi della letteratura: per non parlare dei testi specifici in merito, i vari studi o trattati filosofici e religiosi, o anche i più elementari manuali di Yoga, le dedicano almeno un capitolo. Eppure, nonostante molto sia stato detto, ritengo che non sia ancora abbastanza, e che molto resti da dire, soprattutto per rimuovere quel certo scetticismo, basato sul persistere dell’errata convinzione, ancora molto diffusa, che il “borbottare parole o frasi senza senso” debba essere poco pragmatico, oltre che estraneo alle tradizioni culturali dell’occidente. Una simile convinzione sembrerebbe parzialmente avvalorata se leggiamo descrizioni come quella compendiosa di B. Bhattacharya, secondo il quale «I Mantra o sillabe mistiche costituiscono la spina dorsale dell’esoterismo tantrico e del Vajrayàna. Sono di innumerevoli varietà, come Bija (seme), Hridaya (cuore)...; questi Mantra sono per lo più una serie di parole prive di senso [sic], ma qualche volta rivelano chiaramente l’influenza di un linguaggio non sconosciuto». Una simile descrizione, pur non mancando di verità, ovviamente, può dare solo una lontana idea di cosa sia un mantra, ma non ne dà una definizione esauriente, né offre una significativa spiegazione.
È anche vero che dare una precisa definizione non è certo impresa di poco conto. Molti autori, tra i quali M. Eliade, Lama A. Govinda, H.V. Guenter e A. Avalon hanno dato una loro interpretazione, ma la definizione — peraltro squisitamente tecnica — che trovo più calzante è quella suggerita da A. Bharati: «Un Mantra è un quasi-morfema o una serie di quasi-morfemi o una serie mista di morfemi puri e quasi-morfemi, disposti in schemi convenzionali basati su tradizioni esoteriche codificate, e trasmessi da un maestro a un discepolo nel corso di un rito di iniziazione prescritto». Se, infatti, esaminiamo i mantra da un punto di vista linguistico, potremo constatare che sono costituiti da singole sillabe, o da serie sillabe, non dotate di senso specifico in sé, o da una o più parole o frasi dal preciso significato, ma apparentemente prive di senso compiuto (se rapportate al rispettivo contesto), oppure ancora da brani di testi canonici, utilizzati in base a determinati criteri, diversi dal significato apparente. In ogni caso, al di là dell’apparente comprensibilità o incomprensibilità del testo, la vera interpretazione è quella esoterica, trasmessa in sede iniziatica dal maestro all’adepto.
Da un punto di vista strettamente linguistico, è indubbio che il termine unisca l’antica radice vedica (e indoeuropea) *man ‘pensare’ e -tra , cioè il suffisso strumentale krt (leggasi krit); il significato di base sarebbe dunque, letteralmente, strumento di pensiero, quindi linguaggio, ma vi sono anche diversi altri significati, che purtroppo non rendono bene il concetto di mantra, così come viene inteso nell’Induismo, nel Giainismo, nel Buddhismo e soprattutto nei rispettivi Tantra. Questa origine etimologica e la relativa traduzione del termine mantra non sono dunque univoche e non di rado i vari pandit ne danno una loro personale versione, spesso basandosi sulle somiglianze fonetiche con i rispettivi dialetti regionali.
Al di là di ogni considerazione prettamente filologica, il mantra resta sempre uno degli elementi basilari della maggioranza delle pratiche spirituali e non solo induiste o buddhiste, come vedremo più avanti. Sarà dunque opportuno prendere in debita considerazione l’etimologia proposta solitamente dai Maestri (sia buddisti che induisti); per citare un illustre esempio, il Mahasiddha Nàropa (1016-1100 d.C.) così enuncia: «È denominato mantra, perché dà gioia a tutte le creature per mezzo di tutti i suoni... e perché è la protezione (tràna) della mente (manasah)». Questa versione etimologica sembra verosimilmente derivare da un passo del Guhyasamàjatantra, ove si può leggere che «Ciò che viene a formarsi in relazione a organi di senso e ad oggetti di senso è la struttura mentale, questa struttura mentale è lavorìo mentale ed ha funzione protettiva. La disciplina dell’affidarsi (al supremo) chiamata la liberazione dallo stato terreno, che è (protezione) a causa della sua indistruttibilità totale, è chiamata Mantracharyà (disciplina mantrica)» (1). La versione etimologica “che libera / che protegge la mente” è dunque quella che sembra esprimere maggiormente il ruolo del mantra nella disciplina spirituale, ed è la versione preferita, in sede didattica, dai maestri — soprattutto quelli tantrici.
Esaminato da un punto di vista formale, come dice A. Avalon, «il Mantra è composto di determinate lettere disposte in una successione definita di suoni di cui le lettere sono i segni rappresentativi». Quindi le due componenti essenziali sono il grafèma, vale a dire il segno grafico e il fonèma, cioè il suono che dal grafema è espresso e codificato in forma visiva. In altri termini, abbiamo il suono e il segno grafico: entrambi questi elementi sono antichissimi e, come avremo modo di vedere, strettamente connessi con la sfera religiosa e quindi esprimenti la sacralità per eccellenza.
Cronologicamente parlando, il suono ha una posizione prioritaria: esiste metafisicamente come elemento archetipico, componente della divinità, prima della manifestazione cosmica. La stessa manifestazione cosmica è un risultato di una estrinsecazione sonora.
Questa tradizione, ovviamente, non è esclusivo retaggio della tradizione vedica. Per citare un esempio più vicino alla cultura occidentale, l’evangelista Giovanni, apre la stesura del suo Vangelo con —

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Per mezzo di Lui tutto ha avuto origine e senza di Lui neppure una delle cose create ha avuto origine».
Questo passo evangelico, a causa dello stile prettamente esoterico, ha dato luogo a molteplici e non di rado controverse interpretazioni, soprattutto con riferimento al Lòghos; questo termine, dalla molteplice interpretazione concettuale (quindi non facilmente traducibile), inclusa quella relativa al linguaggio, è reso nella versione latina con Verbum, Parola, Verbo e con egual significato viene reso in altre versioni come quelle slava, armena, e via dicendo. L’interpretazione essoterica, riportata di solito nei commentari ecclesiastici, si limita a mettere in relazione l’uso di questo termine con il riferimento alla Sapienza divina — origine del linguaggio, quale strumento espressivo degli insegnamenti contenuti nei testi sacri — che si manifesta nella persona del Cristo storico. Senza nulla voler contestare a questa esegesi, trovo che una analisi più approfondita giovi non poco alla miglior comprensione del testo evangelico. L’uso del termine Lòghos è chiaramente intenzionale e riassume in sè le precedenti esperienze filosofiche — da Eraclito a Filone alessandrino — in base alle quali si desume che il Lòghos sia la ragione cosmica, la sorgente creativa dell’ordine e dell’intelligibilità del mondo, lo strumento metafisico, talora personale, per mezzo del quale si esercita l’attività creativa della divinità trascendente (2). Non a caso Lòghos, derivato da legw (Lègho: dire, parlare), l’espressione verbale relativa al linguaggio, denota la ragione o una delle sue espressioni e sta ad indicare parola, discorso, definizione, principio, e via dicendo. Viene spontaneo, a questo punto, il parallelo con i termini sanscriti Vàch (o anche Vak, latino Vox), Voce, Parola e Shabda, Suono, Parola, che nella tradizione vedica e nelle sue derivazioni stanno ad indicare il suono cosmico, la parola divina, mezzo di conoscenza (Jñàna), ma anche espressione della Divina Saggezza (Pràjña). Risulta evidente, di conseguenza, anche il parallelo tra la sintesi cosmogonica espressa dall’evangelista Giovanni e altre cosmogonie che, dichiaratamente, espongono il principio dell’originazione cosmica da una vibrazione sonora. Secondo quanto riporta un trattato teologico induista, lo Shatapatha-Bràhmana (11,16), Prajàpati (Signore delle Creature), dopo essere uscito dall’uovo cosmico e avere galleggiato per un anno sulle acque di un oceano sconfinato, portato dai resti del guscio, non trovando dove fermarsi, pronunciò «bhuh» e questa parola divenne la terra; «bhuvaha» e questa divenne l’ètere; «svaha» e questa divenne il cielo: in questa narrazione troviamo anche l’origine delle prime tre parole con le quali inizia la strofa Gàyatrì, la strofa per eccellenza, conosciuta anche come Gàyatrì-mantra o Vedamata, Madre dei Veda: Vishnu stesso, nella persona di Krishna, dichiara ad Arjuna di identificarvisi (3). Nella stessa genesi, così come esposta dall’omonimo libro biblico, il Creatore — con i ben noti simbolici ordini — dà luogo alla manifestazione cosmica mediante estrinsecazione sonora (4).
È d’uopo specificare che l’associazione dell’elemento sonoro alla manifestazione cosmica non è frutto di fervida fantasia o di pura elucubrazione filosofica, ma di una attenta analisi, condotta sia a livello fisico che metafisico. La moderna scienza — pur con i suoi limiti (che non sono poi così pochi!) — ha dimostrato, con la scoperta degli ultrasuoni e degli infrasuoni, l’esistenza di emissioni sonore al di là della soglia dell’udito umano: emissioni che, pur non decodificate direttamente dall’apparato uditivo, vengono ugualmente recepite dagli organismi viventi (animali, vegetali e finanche minerali) (5). Possiamo perciò dedurre che la stessa vibrazione sonora che è alla base della manifestazione cosmica la tiene attiva e, alla fine sarà la causa della sua distruzione (6).
Secondo le tradizioni induiste una simile attività, basata sulla vibrazione sonora, è retaggio di Shiva. Questi “mette in moto” la manifestazione cosmica — altrimenti statica — con l’estrinsecazione sonora e la danza (7), che continua ininterrottamente; sempre danzando provocherà la fine della manifestazione (donde il ben noto epiteto — spesso frainteso — di Distruttore). Non a caso un’importante scuola esoterica shàiva sorta dopo il VII secolo d.C., il Trika (Triade) (8) prende in particolare considerazione l’ipòstasi di Shiva nota come Bhairàva, che letteralmente significa il Tremendo, il Terrifico; è opportuno ricordare l’etimologia tradizionale che vuole la derivazione da Bhri-, portare, sostenere, nutrire e ru-, gridare: Shiva è dunque colui che sostiene mediante l’emissione vocale, colui che alimenta tutte le cose e, nel contempo, il principio fonico, il linguaggio, colui che pensa, parla, fa suo e quindi riassorbe e dissolve il tutto da lui in principio creato e sostenuto (9).
Alla luce di quanto finora esposto risulta evidente la ragione della sacralità attribuita a tutto ciò che abbia a che vedere con il suono, e questo non solo nelle tradizioni vedica, tantrica e buddhista, ma anche nelle altre tradizioni religiose, dalle più primitive alle più evolute, e, come vedremo, finanche in quelle che attualmente escludono categoricamente di aver mai avuto simili tradizioni, avversando pervicacemente ogni forma di esoterismo.
Che dire infatti della musica, il linguaggio universale per eccellenza? A prescindere dal vilipendio a cui è stata sottoposta da certi autori contemporanei, animati — a loro dire — da “spirito di trasgressione” (espressione quanto mai appropriata, in questo caso), questa nobile espressione artistica è in grado di far vibrare le corde più profonde dell’animo, anche del più insensibile. Il nome stesso, derivato da Ars Musica, Arte delle Muse (10), denota l’origine divina ascritta a questa forma espressiva. Sappiamo infatti che la prosodia e la metrica dei testi epici o tragici, erano finalizzate al canto degli stessi o, almeno, ad una recitazione intonata (11). Le tragedie greche, espressione tipica del culto dionisiaco, erano un alternarsi di recitativi e arie, proprio come nelle opere liriche di epoche posteriori. Anche i poemi epici e le liriche erano in effetti delle canzoni. Quindi la musica, nel mondo greco come in quello latino, era sacra ad Apollo e a Diòniso, così come nella tradizione vedica lo è a Vishnu e a Shiva e il parallelo non è affatto casuale o arbitrario, considerando le affinità esistenti tra le due coppie di divinità. Nel mondo germanico una delle tre dee del destino, la Norna Skuld (la futura) (12), era considerata la “Musa” ispiratrice dei poeti — soprattutto vaticinanti — e dei cantori epici che da lei prendevano nome di Skuldi o Skaldi; è interessante ricordare che le Norne, figlie di Erda, la Dea Madre, erano considerate entità primordiali e atemporali: Skuld, come la Mira (latino Parca) Átropos (l’Inesorabile), essendo quella che recideva il filo del destino umano, quindi avendo attinenza con il mondo delle tenebre, dell’oltretomba, può far ravvisare un aspetto dionisiaco, presente anche nella tradizione druidica tipica dell’area culturale celto-germanica. Un ruolo simile di ispiratrice di poeti e cantori, ritornando alla tradizione vedica, è ascritto alla consorte di Brahma, l’ipostasi dell’energia divina (Shakti) conosciuta come Sarasvati (Eloquente), che viene raffigurata mentre suona la Vìna (13), mentre con una delle altre due mani regge un rosario, simbolo della perfetta recitazione del mantra, e con l’altra un libro; con le stesse caratteristiche viene raffigurata e venerata dai seguaci del Vajrayàna come Vajra-Sarasvatì, consorte tantrica di Mañjushrì, personificazione della Saggezza adamantina. Volendo estendere l’analisi comparativa, vi sarebbe di che dilettarsi in più approfondite ed estese dimostrazioni, ma penso che gli esempi appena forniti dimostrino sufficientemente che la musica, come elemento sacro, non sia per niente avulsa dalla storia delle tradizioni religiose del mondo occidentale. Non è dunque frutto di pura fantasia il mito greco di Orfeo che, con il suo canto e il suono della lira, ammansiva le belve e si può affermare con certezza che abbia un suo riscontro nella realtà: serie osservazioni scientifiche hanno riscontrato gli effetti benefici della musica sull’organismo, non solo umano, ma anche di altri animali, e addirittura di piante; le spiegazioni sono, com’è ovvio, da ricercare oltre la sfera puramente fisica, e possiamo affermare di trovarci ad effetti simili a quelli prodotti dai mantra.
Ogni tradizione religiosa, dunque — almeno nel suo periodo delle origini — ha considerato la musica come espressione diretta della divinità, quindi come un modo per entrare in diretta sintonia con la sfera del divino e ripristinare quell’armonia interiore, perduta a causa di uno stile di vita troppo estraneo ai canoni naturali. Considerando queste particolari caratteristiche, non c’è da meravigliarsi se per ogni religione la musica sia stata da sempre considerata non solo il migliore complemento della preghiera, ma addirittura un suo elemento potenziatore: a ragion veduta Sant’Agostino diceva che Chi canta, prega due volte.
Anche la lingua parlata, in quanto evoluzione delle vibrazioni sonore primordiali, ha il suo bravo carattere di sacralità; tale carattere interessa, di conseguenza, anche i segni grafici necessari per la codificazione e trasmissione nel tempo del messaggio orale. E così anche i grafemi, ideografici o sillabici che siano, diventano latori di un messaggio ben più complesso e significativo della semplice annotazione fonetica: diventano — come per il devanàgari — i semi (Bija), le matrici dell’epifania divina, anzi, è frequente la tradizione che attribuisce l’origine dell’alfabeto ad una divinità o ad una ispirazione divina. L’alfabeto diviene perciò parte integrante della rivelazione del messaggio divino, come gli esempi seguenti dimostrano.
L’alfabeto devanàgari, usato dal sanscrito e dalle varie lingue derivate, come dice il nome “Città della divinità”, è considerato la lingua ideale per esprimere il messaggio divino, come un luogo dove la parola divina abbia degna dimora; infatti, al di là della terminologia specifica, molto ricca ed appropriata, i grafemi fanno del sanscrito una lingua foneticamente precisa (14): secondo la tradizione essi furono trasmessi dalla divinità, insieme alla Conoscenza trascendentale, ai sette grandi Rishi, i santi poeti che effettuarono la stesura dei primi testi canonici: una scienza superiore aveva bisogno anche di una forma espressiva adatta, e i caratteri devanagarici dovevano essere i più adatti ad esprimere il sacro Verbo. L’origine sacra del segno grafico alfabetico è un elemento che il devanàgari ha in comune con molti altri alfabeti; a titolo di esempio, citerò i caratteri runici — dell’area celto germanica — la cui creazione è attribuita al dio Odino, oppure l’alfabeto armeno, elaborato — nel V secolo d.C. — dal santo predicatore Mesròb, dopo una visione onirica: dopo una simile visione ebbe origine anche l’alfabeto giapponese Hiragana, elaborato dal ven. Kobo Daishi (15).
Se, come si è appena visto, la sacralità del binomio fonema-grafema non è un’esclusiva dell’ambito culturale induista e buddhista, anche per l’uso di formule mistiche e del japa (la loro recitazione ripetitiva), troviamo riscontri presso altre tradizioni. Per quel che riguarda il nostro ambiente occidentale, bisogna innanzi tutto sfatare la convinzione, abbastanza diffusa, che l’aspetto esoterico-iniziatico sia completamente estraneo alla tradizione cristiana; una simile convinzione ha preso piede, adducendo la motivazione che, poiché tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, il Cristianesimo sia una religione aperta a tutti, né vi siano insegnamenti dedicati ad alcuni ed esclusi ad altri. A titolo contraddittorio, la sola proverbiale frase di Cristo: «Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» dovrebbe dirla lunga a tal proposito, come pure la celebre esortazione a non dare le cose sante ai cani e a non gettare le perle innanzi ai porci (16) sembra eloquente nel significare di non divulgare i sacri misteri — i sacramenti — ai non iniziati, perché nella loro ignoranza non ne facciano scempio. Il termine stesso sacramento o mistero, che dir si voglia, tuttora in uso in ambito catechistico e liturgico presso le chiese cristiane (17), sembra sufficiente a testimoniare l’esistenza di alcune verità ineffabili, comprensibili solo dopo un’iniziazione e un lungo cammino interiore. Per quanto concerne le formule mistiche, le Sacre Scritture forniscono prove inconfutabili, laddove è testimoniata l’istituzione del sacramento della comunione (18). Si può ragionevolmente sostenere che la parola eucaristhsaV (efcharistìsas), cioè rese grazie, benedisse (donde anche il nome di eucaristia, attribuito al sacramento), nella stesura evangelica, riassuma un rituale esoterico, non tanto dissimile da altre tradizioni — Vajrayàna incluso —, con formule consacratorie specifiche (19), contenenti verosimilmente anche mantra (20).
A giudicare dalle varie forme liturgiche — in uso da secoli sia presso la chiesa romana che presso quelle orientali — si ha però l’impressione che l’uso di dette formule, non essendo menzionato nel Nuovo Testamento, sia stato considerato superfluo e quindi escluso dai rituali in genere (21); per quel che riguarda la consacrazione delle specie, in particolare, tutto sembra ridursi a un rituale rievocativo, probabilmente considerando che il semplice ripetere le sole parole testuali di Cristo, abbia già un valore sufficientemente consacratorio e che non ci sia bisogno di ulteriori formule: anche questo, se vogliamo postulare un’ipotesi, in ossequio al principio che, se il linguaggio di per sè è mantra, a maggior ragione lo sono le parole pronunciate dalla manifestazione della divinità, o comunque da un santo. In base a questo criterio il celebre Padre Nostro, la preghiera suggerita dallo stesso Gesù Cristo, per il suo contenuto squisitamente esoterico, potrebbe essere equiparato a quella che nel buddhismo è chiamata Dhàranì e, per il fatto di contenere le parole testuali del Maestro, che è della stessa essenza della divinità, assume il valore di mantra e, come tale recitato — non solo nelle varie forme liturgiche, ma anche nelle pratiche meditative o di preghiera, individuali o collettive — in un vero e proprio japa, significativamente affine ai modelli orientali. Lo stesso vale anche per la celeberrima Ave Maria, la cui prima parte riporta le parole di un angelo (quindi di uno spirito eletto), emissario della divinità. Similmente al Padre Nostro, nell’ambito del buddhismo tibetano, troviamo l’esempio della cosiddetta Mig.me tse.ma (22), conosciuta come Mantra di Lama Tsong Khapa (23), è una strofa da lui composta in omaggio al proprio maestro; quest’ultimo, riconoscendolo come manifestazione di Mañjushrì, il Bodhisattva personificante la Saggezza, e quindi unico degno oggetto di simile omaggio, reindirizzò al giovane discepolo la strofa, dopo aver sostituito il proprio nome con il suo. Quindi, pur non essendo propriamente un mantra, la strofa lo diventa sia per la sua funzione di omaggio, che per il fatto di essere stata creata dal grande pandit, conosciuto dall’agiografia tibetana come il Secondo Buddha; come ogni mantra, dunque è oggetto di vari livelli di esegesi esoterica.
Se, facendo eccezione per il Padre Nostro e l’Ave Maria, l’uso di formule sacre esoteriche — assimilabili o meno ai mantra — è caduta in disuso nella pratica cristiana in genere, qualche traccia di recitazione ripetitiva (Japa) la troviamo in una particolare tecnica meditativa, l’Esicàsmo; con origini in epoca bizantina e ancora in uso nel XXVIII secolo presso i monaci del Monte Athos: questo tipo di meditazione prevedeva tecniche respiratorie e posture particolari, sì da presentare affinità con alcune tecniche Yoga (24); durante le sedute meditative veniva ripetuta, a mo’ di mantra, l’invocazione: «Elèison me, K_rie Iisù Christè, o Yiòs tu Theù (25): Abbi misericordia di me, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio».
Un ulteriore importante riscontro dell’uso di formule estratte da testi sacri, ma usate con differente finalità, ci viene dalla tradizione islamica, in seno alla quale il Corano, per il fatto stesso di essere espressione diretta della rivelazione divina, viene ad assumere un ruolo affine a quello dei testi canonici induisti, giainisti e buddhisti, e quindi dei mantra da essi originati; infatti anche nella religione islamica troviamo l’uso di ripetere formule estratte dal Corano, come la basmala (Bismi llahi arRahmani arRahimi: in nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso), o la shahâda (Lâ ilâha illâ ‘llâh: non vi è altro Dio all’infuori di Dio), ripetute, non solo verbalmente, ma anche — sotto forma di elaborati calligrammi — apposte su preziosi codici manoscritti o sulle opere architettoniche, previste per le varie istituzioni islamiche, e non come semplice ornamento, contrariamente a quanto faccia pensare l’indubbia eleganza formale. L’esempio più significativo per questa trattazione è quello della recitazione dei nomi di Dio (26); questo tipo di recitazione ripetitiva, denominata Dhikr, paragonabile a quella induista dello Harinama (27), trova la sua più intensa applicazione nel Sufismo (28), che utilizza formule come la sunnominata shahâda o altre, scelte non in ragione del loro significato specifico, ma atte a ingenerare una significanza sul piano psichico (29); particolarmente importante la Ismu’z Zat (Nome dell’Essenza Divina) «Hu El-Haiy El-Quaiym» (Egli, il Vivente, l’Autosussistente) o «Huwa» (Egli è) oppure «Hu» (Egli); il Dhikr deve essere associato al controllo del respiro e la recitazione di Hu, alternata a Hi (30), per il metodo di associazione al ritmo respiratorio, induce ad una similitudine con alcune tecniche yoghiche di recitazione della sillaba sacra OM.
La sacralità della musica e l’uso di formule esoteriche a carattere mantrico, come è visto, è un elemento basilare di tutte le tradizioni religiose e non un’esclusiva delle tradizioni induista, giainista, buddhista e tantrica, anche se presso queste ultime ha trovato una più ampia ed articolata espressione, rimasta viva nel corso dei millenni, durante i quali è stata anche oggetto di approfonditi studi. La consapevolezza di questa sacralità ha portato a considerare l’equivalenza di musica e linguaggio come espressioni evolute del suono cosmico primordiale; quindi tutto ciò che è sonoro, linguaggio musicale o linguaggio parlato, è mantra: finanche il respiro è mantra come si è già visto (31).
Il Mantra per antonomasia, come elemento identificativo della divinità, è comunque l’elemento per eccellenza delle pratiche spirituali. Come suggerisce il Vijñànabhairava (32): «...proferendo di continuo il nome di Bhairava inteso [in questo senso], si invera Shiva»: vale a dire che, proferendo ripetutamente il nome (o uno dei nomi) di colui che con il suono emette, sostiene e riassorbe la manifestazione cosmica, si realizza la liberazione finale, identificata in questo caso con lo stato di Shiva, ma, volendo con qualsiasi altra ipòstasi divina, che in ogni caso rappresenta lo stato della Suprema Illuminazione; quindi l’enunciato del testo shàiva vale anche per vàishnava, jàina o buddhisti (33) e relativi tantrika. Oltre al raggiungimento dello Stato Supremo della divinità, vi sono sfere di azione del mantra come l’ottenimento, la propiziazione, la purificazione, l’esorcismo, l’offerta, e via dicendo; vi sono manifestazioni divine di vari livelli con attinenze specifiche con ognuna di queste sfere di azione. Ognuna di loro ha la propria sillaba seme (Bija) e uno o più mantra, quindi la specifica sàdhana, a seconda dello scopo perseguito dal devoto praticante. Nel Buddhismo troviamo dunque, oltre ai mantra protettivi (Paritta), riportati in vari testi pàli, anche una vasta gamma di mantra in uso presso le tradizioni Vajrayana (tibetana, cinese Mi-tsung, giapponese Shingon, ecc.).
Molti maestri insistono sull’esatto modo di recitare e sull’esatta pronuncia del mantra, mentre altri sostengono che la sincera fede nella pratica può compensare anche eventuali errori di pronuncia; talvolta il mantra, nonostante la pronuncia difettosa (dovuta a profonde differenze morfolinguistiche), viene considerato come variante consolidata, poiché pronunciato da un grande maestro, e comunque, anche in questo caso, il suo effetto è assicurato, purché sia recitato in accordo alle appropriate istruzioni. Bisogna infine confutare la convinzione — diffusa tra molti in Occidente — che la fede del praticante sia l’elemento indispensabile per l’effetto del mantra. Infatti, se è vero che la fede può caricare di valore mantrico determinate formule o preghiere (un po’ come succede per i placebo in medicina), per il mantra essa non è un elemento necessario. Infatti, se è vero che la massima attivazione dell’energia si ottiene solo dopo l’iniziazione e con il rituale appropriato, il mantra fa sentire comunque alcuni suoi effetti anche su chi lo reciti distrattamente o inavvertitamente, senza alcuna fede né comprensione del suo significato, talvolta addirittura senza ripetizione; è opportuno il paragone con la musica, che può indurre profonde variazioni degli stati emotivi in chi l’ascolta; non è necessario essere esperti di musica o capire il testo cantato: a seconda del genere musicale, l’ascoltatore può dunque provare sensazioni di benessere, euforia, distensione, commozione (talora anche tristezza), e via dicendo; penso sia ben noto il detto popolare Canta, che ti passa! Anche il mantra agisce in modo simile; quanto agli effetti, se qualcuno nutrisse delle perplessità, vi sono diversi mantra, come quello di Avalokitèshvara e quello di Tara, recitabili anche senza iniziazione: non resta dunque che provare e... SARVAMANGALAM, che ogni cosa possa essere di buon auspicio!
NOTE:
1) Cap. 18, p. 156, G.O.S. LIII - citato da A. Bharati, in La Tradizione tantrica, Ubaldini, Roma, 1977, p. 129n.
2) Anche nella filosofia di Plotino troveremo espressa, seppur elaborata, questa idea.
3) Bhagavad-Gìtà, 10, 35
4) Cfr. Genesi, I,6-10
5) Per quanto possa sembrare strano, anche il regno minerale ha una sua forma di vita: a titolo di esempio, sappiamo bene che, allorché cessa il calore, i vari movimenti e comunque un certo tipo di attività di movimento (che genera rumore), un pianeta, come qualsiasi altro organismo viene considerato morto, secondo gli stessi principi che portano a considerare morto un organismo degli altri regni.
6) Un esempio — in piccolo — può essere il bicchiere di cristallo, rotto per effetto dell’acuto di qualche cantante particolarmente dotato.
7) Donde l’ipòstasi Nataràja, Signore della danza, frequentemente raffigurata in dipinti e statue.
8) Così denominata a seguito della postulazione di tre piani dell’esistenza, denominati Para (Supremo), cioè Shiva, Paràpara (Supremo-infimo), cioè Shakti (energia) e Apara (Infimo), cioè Nara (uomo), concepiti come tre stadi della potenza di Shiva.
9) Cfr. «Egli suole sostenere il tutto, lo emette vocalmente, datore di tutte le cose, onnipervadente», Vijñànabhairava, 128, Adelphi, Milano 1989.
10) Può essere interessante ricordare che il nome, derivando etimologicamente da Mènos, quindi dalla radice indoeuropea *men, mndh (la stessa di manas, latino mens), con preciso riferimento alla mente, significa “(dee) del pensiero, della mente”; non a caso il nome della loro madre, Mnemosìne (Mnimos_ni) — di uguale derivazione — significa memoria, pensiero, ricordo.
11) Qualcosa di simile alla recitazione salmodiata dei testi vedici, del Corano, o di certi brani liturgici delle chiese cristiane d’oriente (greca, armena, copta, ecc.).
12) Le altre due Norne, Urd (la Passata) e Verdandi (la Presente) erano omologhe delle Mire (Moirai) Klothò e Làchesi.
13) Detta anche Liuto indiano (in alcune iconografie la Dea suona uno strumento effettivamente simile al liuto) e più antica del sitàr, assomiglia a quest’ultimo, con la differenza di avere una seconda cassa acustica sotto al manico, in corrispondenza del capotasto; il suono inoltre ha un timbro più grave rispetto al sitàr.
14) Perché ogni fonema ha un suo equivalente grafema, non dando quindi luogo ad equivoci sulla pronuncia, come succede invece in altre lingue, come ad esempio l’italiano, nel cui alfabeto vi sono grafemi (come la Z, ad esempio) ai quali corrispondono due fonemi.
15) detto Kukai (774-835), fondatore della scuola Shingon.
16) Matteo, 7/6.
17) Ad eccezione di quelle che escludono in toto o in parte i sacramenti.
18) Matteo, 26/ 26-28; Marco, 14/21-24; Luca, 22/19-20; anche Paolo, 1a Corinzi, 11/23-26. Tengo a ricordare che le stesure dei Vangeli furono eseguite indipendentemente l’una dall’altra, senza che i loro autori sapessero di non essere gli unici a redigere una cronaca degli stessi avvenimenti.
19) Cfr. Archimandrita Benèdictos Katsanevàkis, I Sacramenti nella Chiesa Ortodossa, Napoli, 1954, pagg. 131-138.
20) Da recitare con gli appropriati Mudra, il cui uso è attestato nell’iconografia.
21) Non sono attualmente in grado di dire se l’uso di formule mantriche o simili, risalenti all’epoca del Cristo storico, sia ancora in uso ancora presso qualche chiesa cristiana esoterica, né se esista ancora, in qualche luogo recondito del pianete, qualche ambito cristiano di immutata tradizione esoterica, né se le tracce di rituali misterici siano custodite in qualche “sancta sanctorum” bibliotecario, inaccessibile per motivi iniziatici o di comodo; sta di fatto che, nelle varie forme liturgiche che ho avuto modo di esaminare fino ad oggi, non ho trovato traccia alcuna di simili espressioni rituali.
22) Dalle prime tre sillabe iniziali della strofa, più il suffisso -ma.
23) Lobsang Dragpa - in sanscrito Sumati Kirti (1347-1419), famoso riformatore del buddhismo tibetano e fondatore della scuola Ghelupa.
24) Cfr. Mìrcea Eliade, Lo Yoga, immortalità e libertà, Rizzoli, Milano, 1995, pagg. 71-74.
25) Elehson me, Kurie Ihsou Criste, o UioV tou Qeou.
26) La basmala ne contiene due: il Clemente e il Misericordioso.
27) Giustappunto Nomi di Dio, il cui numero può variare da 108 a 1000, ed è applicata a diverse ipostasi di Vìshnu e Shiva, e relative consorti tantriche.
28) Indirizzo filosofico-mistico Islamico, nato tra i secoli VIII-X d.C., a seguito dell’influenza di elementi cristiani e neoplatonici, si è poi diffuso in tutta l’area di influenza islamica, Europa inclusa. La riscoperta delle opere di Aristotele, ad esempio, deve un grosso contributo alle traduzioni ed esegesi operate dai Sufi — a noi noti — Ibn Sina (Avicenna) e Ibn Rushd (Averroè): questo ha molto influenzato, dunque anche la visione dei filosofi occidentali, e non solo di quell’epoca. Può essere interessante dire anche che il metodo sufico presenta notevoli affinità con lo Zen; molti insegnamenti, al di là del contesto arabo, per il loro stile, potrebbero benissimo venire usati come autentici Mondô.
29) Cfr. Gabriele Mandel, Il sufismo, vertice della piramide esoterica, Sugarco, Milano, 1977, pag. 131-133.
30) Cfr. Nota precedente.
31) Cfr. La Pràjñapàramità, Madre di tutti i Buddha, Occ. Buddh. Nr. 2, ins. p. XX
32) Cfr. nota 190 - seconda parte del verso 128.
33) In quest’ottica è da considerare la pratica del Nien-fo (giapp. Nembutsu) presso il Ch’an e lo Zen o la recitazione del Daimoku (che molto ricorda la recitazione del mantra, quantunque ciò sia negato recisamente dai praticanti), secondo la tradizione del maestro giapponese Nichiren (1222-1282).