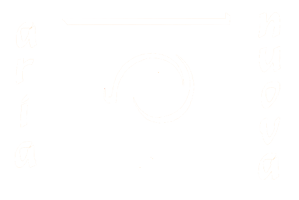ALLA RICERCA DEL MANTRA
NELLA POESIA ITALIANA
di Tommaso Iorco
(autore tutelato SIAE)

Proporre un filo conduttore univoco dell’intera poesia italiana, dai lontani primordi della scuola siciliana a oggi, e pretendere che esso costituisca l’unica vera chiave di lettura di un così fitto e articolato processo, sarebbe evidentemente un’eccessiva forzatura. Ma se ogni tentativo genuino di espressione poetica si esplica davvero in un atto di creazione che abbia alla sua base una sia pur frammentaria “presa di possesso” (o ispirazione, che dir si voglia) dell’uomo-poeta da parte di una superiore Musa o di una qualche Deità del linguaggio, in tal caso allora risulta oltremodo interessante rintracciare tale perfezione nel panorama della lingua italiana. Tale prospettiva, ispirataci dal magistrale saggio The Future Poetry di Sri Aurobindo, è peraltro assai più opportuna di quel che comunemente si crede; nella cultura italiana, infatti, esiste una forte consapevolezza della superiorità della poesia ispirata su quella di fattura più mentale o sentimentale — basta, per limitarci a fare un esempio, andare a quel glorioso Rinascimento che rappresentò, fra le altre cose, la rivalutazione del gusto ellenico (nella creazione del quale così grande importanza ebbe, illo tempore, quell’Italia meridionale non a caso insignita dalle stesse popolazioni attiche con il nome di Magna Grecia), ove ad esempio il grande neo-platonico Marsilio Ficino affermò che il poeta «è un essere leggero, alato, sacro, che non sa poetare se prima non sia stato ispirato dal dio, se prima non sia uscito di senno, e più non abbia in sé intelletto […]. Ecco perché il dio li priva dell’intelletto, e li usa come suoi tramiti, i poeti, i vati, i divinatori, sì che ascoltandoli si sappia che non essi sono coloro che dicono cose di sì alto valore, privi di ogni intelletto, ma è lo stesso dio che le dice, che a noi parla attraverso loro». Quindi, attraverso la voce dei poeti — quelli veri, ossia genuinamente ispirati — come già in quella di Omero, “canta la Dea”.
In tal senso, la poesia italiana, partita — nei suoi voli più belli e sinceri — nel tentativo di esprimere l’amor cortese, ossia l’umano sentimento d’amore in un certo qual modo sublimato e trasfigurato (pensiamo alla scuola siciliana formatasi attorno al “chierico grande”, ma più ancora agli stilnovisti e al Petrarca), o esperienze puramente mistiche (Francesco d’Assisi, Uguccione da Lodi, Jacopone da Todi), sembra poi avere compiuto un lungo e quanto mai fecondo periplo di mirabile cesellatura (culminante nell’Ariosto e nel Tasso) e di sperimentazione (e arriviamo al Novecento con il suo ‘frammentismo lirico’) che dovrebbe condurre — se il nostro postulato di base si rivela esatto — all’espressione di quegli stessi sentimenti di partenza, ma più chiaramente spirituali, o spiritualizzati, liberati cioè finalmente da tutte le pastoie di ordine sentimentalistico, religioso, ascetico, didascalico e moraleggiante, elementi che in una qualche misura stemperano sempre la purezza originaria dell’ispirazione, il quid divinum.
A ben vedere, in tutte le epoche storiche, e in tutti i paesi, ci sono stati dei “vati”, poeti-veggenti che hanno cercato di trattenere sulle loro alate penne qualcosa dei loro voli nei cieli della coscienza. Dai kavi vedici e vedantici, ai bardi caldei, ai mistici sorti nelle varie latitudini (per esempio, Lao-tze, Jallaladin Rumi e Juan de la Cruz, per citarne tre provenienti da culture assai diverse fra loro), fino ai più recenti Blake, Mallarmé, Yeats, Rilke, molti sono i poeti che hanno cercato di trasporre in parole ritmiche il loro “trasumanare” nell’ineffabile.
Sri Aurobindo ci mostra come in realtà ogni grande poetica sia un tentativo (più o meno consapevole) di tradurre in verbo mantrico qualcosa di quel Logos che anima l’intero esistente. Il poeta del futuro, in tal senso, dovrebbe riprodurre in se stesso l’operato dello Spirito cosmico, che crea le armonie universali tramite il potere del Verbo originale.
Da qui ha preso inizio il nostro viaggio verso le alte vette delle Muse, invocando i favori di Apollo, ma anche, contemporaneamente, i tini dell’ebbrezza dionisiaca!
Molto utile risulta in quest’ottica tentare di rintracciare un qualche grado di perfezione di tale processo nel patrimonio poetico di ciascuna cultura mondiale e quindi, nella fattispecie, traendo a piene mani dalla prodiga cornucopia della poesia italiana. Poiché Sri Aurobindo, nel saggio citato, si concentra particolarmente — e per ovvie ragioni — sulla poesia in lingua inglese, offrendo della poesia mondiale (soprattutto sanscrita, greca e latina, di cui come si sa era profondissimo conoscitore sin dalla prima giovinezza) una panoramica di mirabile genialità ma non certo esaustiva. In altri suoi scritti troviamo pure un meticoloso studio — e per ragioni altrettanto ovvie — della poesia sanscrita (sia vedica che classica, esaminando con grande scrupolo e con impareggiabile penetrazione i Veda e le Upanishad da una parte e i grandi poemi epici di Vyasa, Valmiki e Kalidasa dall’altra). Sovente cita pure, avendo approfondito sui testi originali la poesia italiana, francese, spagnola, tedesca (oltre che quella di alcune prakriti, lingue regionali indiane), i loro grandi momenti, ma lascia — com’è giusto — a ogni singola cultura il compito di condurre da sé il proprio approfondimento. Eccoci quindi approdati, in modo affatto naturale, alla nostra lingua italiana, che peraltro è unanimemente riconosciuta come una fra le più melodiose del mondo.
Da questa ricerca, sono nati alcuni recital teatrali (L’Opera d’inchiostro, Novecento, Il pentagramma poetico e altri ancora, con la collaborazione di artisti di fama internazionale come il musicista Marco Testori e la danzatrice Sabrina Camera), una registrazione in compact-disk in studio (Alla ricerca del mantra nella poesia italiana) e una dal vivo (Variazioni poetiche), incontri e dibattiti varî. Ed essendo un vero e proprio “work in progress”, contiamo di proporre ancora, e in vario modo (magari anche attraverso la realizzazione di un CD-ROM multimediale), i frutti delle nostre esplorazioni. Qui, per ovvie ragioni, ci limitiamo a fare il punto della situazione.
La prima tappa di questa nostra spedizione poetica, avvenuta in collaborazione con Bruno Petris, si è concentrata in particolare sulla ricerca del mantra nella poesia del sommo Dante. Scriveva lo stesso Bruno Petris in uno degli articoli che costituiscono il libretto introduttivo al nostro C.D.: «Disse il Buddha, paradossalmente, che il miglior punto per cominciare la scalata si trova sulla cima della montagna del dharma. Comunque, nel nostro caso, dove meglio, e più, che in Dante, e nella terza Cantica, trovare quei riscontri che oggi potrebbero rappresentare, oltre che un gioco letterario, e quindi un passatempo ameno, anche e soprattutto preziosi (per noi) punti di contatto tra civiltà diverse e discipline ancora alquanto estranee. Non quindi tanto in nome di un sincretismo più o meno erudito ci urge ravvicinare eventi e personaggi tanto distanti nel tempo e nello spazio, ma per meglio poter identificare quel libero spazio che oggi appunto deve appartenere a tutta l’umanità, ove germinò il mito ed anche il simbolo, e la visione cosmogonica, e la magia della parola. Spazio vasto, brihat, numinoso di altri mondi e altri esseri al di là dell’uomo… “di là da quella
che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”?
Ma forse proprio al di là delle “siepi” che delimitano le civiltà e circoscrivono le discipline, respira quell’altro io intravisto dal grande Friedrich nel delirio dell’Übermeinsch, incontrato nel Nostro, più gentilmente, nella dolce follia di quella “altra metà”
“quand’ella entrò nel foco ond’io sempr’ardo”» (B.Petris, Alla ricerca del mantra nella poesia del Paradiso).
La tappa successiva di questa ricerca, non poteva non consistere nell’allargarsi all’intera poesia italiana, nel tentativo di trovare qualche favilla mantrica. Compito assai arduo, per la verità, ma oltremodo stimolante, e zeppo di scoperte.
Infatti, accanto a poeti già ampiamente riconosciuti — Jacopone da Todi, Petrarca, Ariosto, Tasso, Leopardi, Campana, Comi, Betocchi, Ungaretti — e che comunque presentano non poche sorprese a una rilettura in senso mantrico, abbiamo trovato dei personaggi il cui verbo poetico è forse meno riconosciuto, ma non per questo meno interessante: ci riferiamo in particolare a Giordano Bruno e a tutta la poesia mistica nata dopo di lui, nel XVII secolo (Tommaso Campanella, Giacomo Lubrano, Vincenzo da Filicaia…) e, arrivando al XX secolo, ad Arturo Onofri. Giordano Bruno è uno dei personaggi più notevoli che siano esistiti, e dalla recente celebrazione (il 17 febbraio del 2000) del quarto centenario della sua morte sul rogo è in corso un riesame della propria ricerca mistico-filosofica, mentre la sua opera poetica resta ancora tutta da scoprire. Ciò che maggiormente colpisce, dell’intuizione bruniana, è una sorta di riabilitazione (rudimentale eppure vigorosa) della Materia, non più vista come ‘causa del peccato’, ma considerata immortale e divina, abitazione della Divinità, «genitura di Dio», così come la stessa Natura, finalmente non più antitetica dello Spirito. L’universo, per il Nolano, non è un atto di creazione ex-nihil ma, secondo la sua stessa terminologia, di «esplicazione» (“evoluzione”, diremmo noi oggi?): è la storia viva di Dio, tendente all’unità, ma a un’unità dinamica, in perpetuo divenire, tramata da infinite differenze, tutte vincolate da una comunicazione perenne e universale. E pur se tutto nell’universo pare vada eternamente di traverso, queste sono proprio le circostanze mediante le quali si compie il suo prodigioso sviluppo. Il grande processo avanza da una crisi all’altra; e questo è il meraviglioso e terrificante modo col quale si evolve l’intera creazione, per potere infine manifestare l’Essere eterno nell’eterno Divenire. Lo “Spirito del mondo” di Machiavelli, in Bruno si fa “Fabbro del mondo” e “Artefice interno”. Ognuno ha il Divino dentro di sé — ci dice egli in sostanza —, non è necessario cercarlo al di fuori; e addirittura deleterio sarebbe delegare una casta sacerdotale a fare da tramite tra Lui e noi; Egli è «più intimo che non sei tu a te stesso»; e, una volta trovatolo in sé, l’uomo diventa Dio stesso, «la vera essenza de l’essere de tutti»:
«Ed io, mercé d’amore,
Mi cangio in Dio da cosa inferiore».
È, questa, davvero, la più grande rivoluzione contro l’ascetismo del Medioevo, il dogmatismo, l’intolleranza, la superstizione, il pregiudizio, il farisaismo e l’oppressione (e quindi, contro lo strapotere della Chiesa, che punirà per l’appunto con il rogo l’arditezza del suo genio precursore). Per Bruno, l’amore per il Divino è proprio delle nature dette «insane», non perché non sanno, ma perché «soprasanno» — sanno cioè più dell’ordinario, e tendono alla conoscenza della Verità eterna e infinita. E se la sua filosofia è a tratti incerta, la sua poesia è al contrario intensa e ispirata, genuina e forte. Il vero merito di Bruno, in quest’ottica, non fu quello di creare una filosofia, né tanto meno d’inventare un sistema metafisico, ma di annunciare, con la forza del verbo, il ritorno di Dio tra gli uomini, la nascita dell’homo novus, l’inizio di quel nuovo spirito investigativo di cui la scienza moderna (da Galileo ai giorni nostri) fu soltanto uno degli esiti (e probabilmente, a ben guardare, nemmeno il più importante, nonostante le apparenze). La poesia, assai più della filosofia, era da lui vista come uno strumento atto a penetrare i misteri reconditi, fino a mostrarci la visione (sia pur nell’ombra) della Divinità ignuda. Ecco che la poesia riprende così il suo ruolo di rivelazione, e quasi per costrizione stessa delle Muse: «alfine — egli scrisse nella lettera introduttiva agli Eroici Furori (indirizzata al suo amico poeta Sir Philip Sidney) per spiegare le motivazioni che stanno alla base del suo poetare —, nel maggior fervore dei fastidi nelli quali incorse, è avvenuto che non avend’altronde da consolarsi, accettasse l’invito di costoro [le Muse], che son dette inebriarlo de tai furori, versi e rime, coi quali non si mostraro ad altri». Sono dunque le Muse che scelgono, non lui; è la poesia che lo “invita” e lo “inebria”; quello delle Muse è un atto di “grazia”, un “dono”.
Infine, la terza fase di questa nostra ricerca mantrica, quella in cui ci troviamo attualmente, cerca di guardare verso la poesia del futuro. Alle soglie del nuovo millennio, una più grande èra deve nascere per la poesia (come pure per l’uomo). L’idea moderna del progresso, inteso nella sua accezione più profonda come il formarsi di una coscienza sempre più chiara di sé, o, per dirla con altre parole, della progressiva manifestazione della Verità eterna, o ancora lo spiritualizzarsi dell’idea di hegeliana memoria, trova in realtà le sue radici in personaggi come lo stesso Giordano Bruno, come Tommaso Campanella (anch’egli peraltro poeta d’un certo rilievo), in Giambattista Vico (pure lui ci ha lasciato alcune poesie, di stampo lucreziano — ed è bello notare come tutti i più grandi filosofi italiani, e anche qualche scienziato, come lo stesso Galileo, abbiano avvertito il fascino del poetare, a ribadire la marcata propensione artistica dell’Italia quale nota dominante del suo genio creativo). Oggi, dopo un secolo come quello che ci siamo da poco lasciati alle spalle — uno dei più terribili e dei più fecondi al tempo stesso dell’intera storia dell’umanità —, assistiamo a una grande fermentazione di minacce (l’integralismo e la globalizzazione innanzi tutti, quest’ultima intesa come appiattimento su un unico modello), ma anche di ‘idee-forza’ che, sebbene ancora perlopiù invisibili, sotto terra, agiscono potentemente, e produrranno inevitabilmente i loro frutti. In questa prospettiva, la poesia potrebbe ricoprire un ruolo determinante.
«L’umanità, ormai sazia, sta volgendo sempre più il suo sguardo verso le altezze, e le voci poetiche che lo condurranno in questa direzione saranno considerate le voci dei veggenti. Poiché i grandi poeti interpretano il presente per l’uomo, o reinterpretano il passato, o addirittura possono indicargli il futuro e in tutti e tre questi movimenti rivelare all’uomo il volto dell’Eterno. […] Ma questa nuova visione non dovrà essere, come è avvenuto nei tempi antichi, qualcosa di remoto, mistico, oscuro, celato ai profani, quanto piuttosto una visione che possa condurre queste divinità in più stretta intimità con il nostro cuore, affinché possano essere incarnate non soltanto dalla religione e dalla filosofia, non soltanto nei più alti voli del pensiero e dell’arte, ma anche, per quanto possibile, nella vita e nelle umane attività. Nei tempi antichi queste cose erano dei misteri, riservati a pochi iniziati, e presto o tardi il loro significato veniva perduto, mentre lo sforzo della nuova tendenza è rivelare, rendere noti e portare più vicino alla nostra comprensione tutti i misteri — e anche se, inizialmente, questo processo produrrà una deformazione che toglierà molto dell’originale bellezza, della luce intrinseca e della profondità, tali difetti passeranno, per canalizzarsi in un’ampia realizzazione che potrà condurci in un’èra in cui l’umanità cercherà di vivere in una Verità più grande di quella che finora ha governato la nostra specie… In quest’ottica, la poesia potrà recuperare qualcosa del suo antico prestigio» (Sri Aurobindo, The Future Poetry).
Poeta, in fondo, significa “colui che crea”. E creare un mondo più vero sarà forse la reale occupazione del Vate del Duemila. Questo, perlomeno, è il nostro augurio, e il nostro impegno.
© Giugno 2002