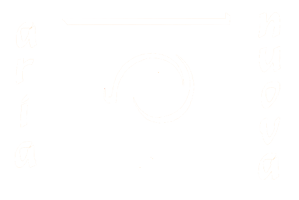ORIENTAMENTO
e
GLOCALE
di Giuseppe Stoppiglia
(ringraziamo il sito macondo.it, associazione per l’incontro
e la convivenza dei popoli, per averci permesso
di pubblicare un articolo del suo fondatore)

Premessa
Vorrei che il mio intervento fosse più una testimonianza modesta e limitata, che la spiegazione di una teoria educativa, sperimentata e riuscita, del lavoro sociale. La stessa parola “progetto” o il termine “progetto personale” che mi capiterà di usare, potrebbe ingenerare equivoci o incomprensioni, può richiamare alla mente mete volontaristiche od obiettivi freddamente e “scientificamente programmati”.
Progetto personale
Con il termine “progetto personale” vorrei indicare un impegno che uno nella vita si è dato, una prospettiva che più o meno chiaramente uno ha con costanza perseguito, una dimensione significativa per se e per gli altri, un punto di riferimento certo, anche se duro e faticoso da perseguire. Una vita, proprio in forza di questo progetto, radicata nell’essenzialità dei valori personali e della comunità locale dove opera, ma che, proprio per questa essenzialità, è aperta al territorio-mondo e tesa al dialogo con tutti i popoli dalla terra. A dimostrazione vivente che l’essenzialità è complementare (e non antitetica) all’universalità, la radicalità alla mondanità; che persona e comunità sono due facce della stessa medaglia; che il processo di riscoperta profonda dell’uomo va di pari passo con la capacità di interloquire con tutti gli altri uomini, che, in altre parole, la liberazione degli altri e la liberazione di se stessi hanno gli stessi tempi anche se processi e modalità distinti.
La sfida dell’associazione “Macondo”
Proporre questa via a fronte di una cultura che va in tutt’altra direzione dell’essenzialità e del radicamento in se stessi e nella comunità, ci è sembrato opportuno e utile. Una cultura, infatti, che non voglia essere né funzionale, né autoreferente, se non compie questo radicamento nel più intimo dell’intimo della coscienza personale (cioè in quello che è essenziale per ognuno di noi) è destinata a essere guidata da valori ad essa esterni (il potere, il prestigio, il denaro, ecc.) o è destinata a diventare gioco e rispecchiamento.
In tutti i casi non potrà che inseguire progetti illusori. Resterà cioè o senza alcun punto di riferimento, senza linfa di cui nutrirsi, incapace di autopropulsione, o docile strumento più o meno consapevole di progetti altrui.
Se il nostro tentativo è costruire un luogo dove produrre e sperimentare ragioni per vivere, l’educazione non può che essere la funzione prioritaria. È la concreta esperienza del noi, che rende possibile l’individualità.
Solo una cultura che sappia dar voce e parole alle grandi aspirazioni e alle profonde esigenze delle persone e dei popoli in quanto in queste esigenze essa è profondamente radicata, è una cultura degna di essere vissuta e proposta. In questo senso la cultura si fa comportamento, s’incarna, diventa vita reale.
Diversamente essa può essere look, moda, immagine, illusione, gioco, salotto, errore disperato, ricerca cieca di sensazioni e di esperienze diverse. In tutti i casi è scollegata dalla fonte vera della cultura: la coscienza.
La mondialità
La conseguenza feconda del fatto che la cultura affonda le proprie radici nella conoscenza personale, patrimonio comune perché proprio di ciascun uomo, è che tutti i progetti personali evidenziano un’omogeneità di fondo, pur conservando ciascuno la propria originalità.
Questo fatto è portatore verosimilmente di grandi possibilità, invero tutte da esplicitare e da analizzare: di costruire cioè dei rapporti tra gli uomini non basati sulla forza e dunque sullo scontro, ma invece sulla comunicazione e dunque sulla pace.
Compiuta questa premessa, doverosa, per acquisire e capire il codice di lettura della riflessione sulla relazione tra globale e locale, passo ai due punti principali del mio intervento:
a) Glocale, che è?
b) Una scelta di libertà oltre le fratture.
A) GLOCALE, CHE È?
Ieri determinante era il territorio con la sua mediazione locale/globale - la siepe è l’ultimo orientamento di leopardiana memoria — che stavano in opposizione — complementarietà.
Oggi tale mediazione è stata eliminata: non esiste più il locale e il globale: oggi esiste il glocale (neologismo coniato da sociologi inglesi). Le reti di sistemi ignorano i compiti, producono e distruggono a loro uso e consumo il glocale, mero contenitore o condensatore di risorse.
Globalizzazione: una sciagura o una risorsa?
Si sta andando verso l’evaporazione del territorio, piuttosto che verso un nuovo concetto di territorio. Ieri noi pensavamo ed organizzavamo il mondo a partire dal territorio. Ognuno riteneva il suo territorio come l’ombelico del mondo, con la stella polare sulla fronte, allo zenit, e il nadir ai suoi piedi. S’era creato unità tra Stato e territorio, tra geografia e diritto, tra luogo e norme (cfr. C. Schmitt).
Oggi invece del territorio abbiamo dei siti.
Nel nostro villaggio rimaniamo come indefiniti, socialmente crudi dentro il glocale. Non una persona tra persone, ma un numero nella moltitudine. Senza l’ancora del territorio rischiamo di incorrere nell’omogeneità e, paradossalmente, nell’egoicità, rimodellati continuamente, soprattutto dall’informazione che agisce sulla nostra soggettività: sull’intelligenza e la sensibilità, sugli affetti e i fantasmi. E l’individuo che non ha identità si fa sguardo. E l’individuo/sguardo ha perso la sua ombra; non riesce ad orientarsi... (quindi ha sempre più bisogno di mappe). Ma le conseguenze sono più ampie, investono il politico e il sociale, il biologico e il naturale. Investono sia la costruzione della soggettività, sia le forme della razionalità collettiva e le strutture del sapere.
Gli slums
Però la globalizzazione è una rete a maglie larghe, così ci possono essere pezzi di territorio che le sfuggono. Sono gli “slums” dove c'è la legge del più forte, del crimine, della violenza, della mafia. Sono certe periferie della metropoli, emarginate, condannate all'inedia, che sopravvivono di economia sommersa di sussistenza. Potrei dire provocatoriamente che il glocale non mi piace. Temo che disorienti non solo noi adulti, ma anche la nuova generazione, perciò la scuola non può non occuparsi di questo.
Se vuole assolvere al suo ruolo di educatrice, dovrà confrontarsi con il problema del territorio. Ritengo si debba muovere in tre direzioni:
1) Preparare i giovani a vivere il glocale con creatività
2) Essere luogo di resistenza del locale/globale contro il glocale
3) Recuperare concetti del territorio sviluppati da culture non europee
Preparare i giovani a vivere il glocale con creatività
Il glocale è forse ineluttabile, ma può essere trasfigurato per via mistica. In tempo di globalizzazione i veri educatori dovrebbero indicare agli educandi il cammino della sobrietà e dello sradicamento. Si tratta di sentirsi di passaggio come il rabbino Hofez Chaim. Al turista che gli diceva : “Rabbino, vedo solo un tavolo e uno sgabello, dove sono i tuoi mobili?” il rabbino ribatté: “E i tuoi dove sono?”.“Ma io sono di passaggio!”. “Anch’io sono di passaggio in questo mondo”, concluse Hofez Chaim.
Oppure si tratta di considerare l’annullamento delle distanze come fenomeno altamente positivo: “Mi hai fatto sedere in case che non erano la mia — diceva Tagore —, mi hai portato vicino il lontano e reso l’estraneo un fratello”.
Ma questa mistica pare sia possibile a un numero limitato di persone di forte spiritualità.
La scuola, luogo di resistenza del locale/globale contro il glocale
Locale/globale come complementari contro il glocale e la sua contaminazione. Anche perché il glocale suscita da una parte adesione incondizionata e dall’altra reazioni integriste e nazionaliste patologiche.
La scuola deve diventare, allora, cammino al bioregionalismo.
Scrive, infatti, Gianfranco Zavalloni: «Il bioregionalismo è un modo d’intendere il nostro vivere… significa vivere qui, nel nostro piccolo territorio con gli occhi, la mente e il cuore aperti al pianeta terra, anzi all’intero cosmo. Per questo quando parliamo di bioregionalismo noi abbiamo in testa l’idea di un localismo cosmopolita. La scuola deve dare la prova che è possibile essere Figli del Villaggio e Cittadini del Mondo».
Vale l’immagine di Martin L. King: “Abbiamo ereditato una grande casa che è il mondo, dove dobbiamo imparare a vivere come fratelli”.
Casa è diverso sia da albergo e metropoli, sia da kibbutz e baraccone. Casa richiama l’idea di famiglia non monocellulare, con molte stanze e molta relazione.
Umanesimo antropologico
Occorre elaborare un nuovo umanesimo antropologico, che gratta la pelle del nero, del giallo, del bianco… per scoprire un comune codice, una comune memoria, una comune umanità: «Il salto consiste — come diceva Ernesto Balducci — nel passaggio dall’uomo edito all’uomo inedito».
In ogni individuo possiamo distinguere due livelli: quello della sua identità elaborata all’interno di una cultura particolare e quella soggiacente delle sue possibilità che ancora non hanno trovato soluzione/attuazione. Il non ancora conscio, ciò che potremmo essere e che ancora non siamo.
Non si tratta di ribadire il mito, abusato, dell’uomo nuovo. Coloro che hanno cercato di costruirlo hanno finito per ucciderlo. È morto sotto i ferri del Grande Inquisitore, è spirato sotto la neve dei lager e dei gulag. Non è da costruire ex-nihilo, è solo da portare alla luce, perché è già presente dentro ciascuno di noi.
Recuperare concetti del territorio sviluppati da culture non europee
Come? Con il suo lavoro interdisciplinare e interculturale. Possiamo prevedere che la globalizzazione, così com’è teorizzata (direi così disumana) non potrà resistere a lungo, ma lascerà il mondo diverso da come l’ha trovato.
Nell’era post-glocale si renderà necessario ampliare l’idea occidentale di territorio.
Pensiamo alla cultura olistica degli indiani. Il territorio dove una popolazione indigena è nata e dove sono sepolti gli antenati è per gli indiani la patria sacra, inalienabile. Non si tratta solo di suolo; c'è pure l’appartenenza all’interno del cosmo: “Mi espando di continuo con la mia voce e il mio pensiero, oltre ogni spazio e ogni tempo, perché la mia anima è il mondo” (N.H.Russel, indiano cherokee).
È la riscoperta della cultura come cammino di liberazione personale e di popolo. La propria cultura si scopre entrando nell’animo del popolo, e si entra nell’animo del popolo confrontandosi con l’esperienza di altri popoli e di altre culture.
La cultura è una maniera di vivere che “apre” la persona ed è sempre difficile, e per il singolo impossibile, rendersi conto della malattia mortale dell’individualismo. È la grande realtà che isola l’individuo, la subcultura in cui sempre più vivono le masse. Si isola persona da persona, la si rende debole e impotente, incapace di responsabilità, allergica a ogni serio impegno, convinta che non può contare niente, né decidere niente. I messaggi che riceve sono sempre più numerosi e accrescono i bisogni superficiali, per cui ciascuno è costretto a darsi da fare come può per sopravvivere, per non aver bisogno degli altri, per avere più degli altri in modo da essere autosufficiente e isolarsi sempre più.
La cultura dell’accoglienza è il modello alternativo e la strada della liberazione
B) UNA SCELTA DI LIBERTA' OLTRE LE FRATTURE L'intolleranza: dal “Noi” agli “Altri”
Là dove un valore è negato sistematicamente, può nascere la sua più alta espressione. I luoghi dell’intolleranza diventano nel dolore, santuari di comunicabilità. (Vedi Sudafrica, l'insanguinata Algeria).
In linea con quanto detto sopra, dovremmo dire che in Italia la convivialità, essendo poco sfidata, è poco coltivata.
Noi italiani pensiamo di essere naturaliter ecumenici e tolleranti, ma la “prova” verrà adesso che dobbiamo confrontarci con altri “eredi” e altre etnie nel nostro territorio. Diciamo di più: la tolleranza è una conquista graduale. La vita di ciascuno di noi è un viaggio dall’Io al Tu e dal Noi agli Altri.
La mia crescita
Penso a me stesso. Ho cominciato il viaggio della mia vita completamente egocentrico. L’attenzione degli adulti nei miei confronti mi faceva credere di essere l’unico vero esistente. Solo a tre anni d'età ho ammesso l’esistenza degli altri.
Nella pre-adolescenza ho adottato il “branco” come rifugio. Nell’adolescenza ho scoperto il mondo con i suoi problemi, il corpo, l’altro sesso e un’anima gemella. Con la maturità è arrivata la certezza che avrei trovato la mia felicità solo sacrificandola per far felice chi amo.
Nella piena maturità ho capito che non è sufficiente amare coloro che amo. Vista così, la parabola della mia vita volge a lieto fine. Ma l’ho semplificata/idealizzata.
Purtroppo numerosi sono coloro che non crescono: si vedono narcisisticamente come una molecola leibniziana senza porte e finestre.
Dalla società alla comunità: un modo di educare
Molti adulti non giungono alla maturità: coppie confondono l'amore con un egoismo a due (la tranquillità del possesso).
Un po’ tutti riteniamo che i figli degli altri non siano nostri figli e, quindi, siamo ancora tribali, come diceva Barbara Ward.
Dentro di una etnia spesso il “noi” è marcato dallo spirito di gruppo che si afferma imponendosi e opponendosi agli altri, invece che dallo spirito di comunità con identità chiara e aperta al dialogo con gli altri.
Ma veniamo alla formazione, alla scuola. Possiamo dire, senza timore di smentita, che il vero esame finale della scuola è l’acquisizione del valore della tolleranza/reciprocità da parte degli alunni. Un esempio ancora più concreto? È bocciata quella scuola in cui gli alunni alla fine del curriculum in un sondaggio votano a favore della pena di morte (sarebbe bene, di tempo in tempo, ripetere il sondaggio).
CONCLUSIONE
Ritrovare le radici
Lasciarsi vivere dalla vita, tenere viva una dimora, senza porte, senza difese, in modo che tutti entrino con facilità e si trovino a casa propria, è per me il massimo della cultura e anche della modestia.
L’età mi aiuta a ricordare più che a prospettare, ma il “ricordare” è scoprire radici. Radici in molti sensi: togliere le erbe che nascono spontanee e indeboliscono le radici per conoscere sempre meglio la pianta, diventare radicale per non disperdere e confondere le radici in mezzo ad una selva che asporta nutrimento e dissipa vita.
Celebrare le differenze
Decolonizzarsi significa ripristinare una relazione fra differenti, ma alla pari. «Postula — come scrive Armando Guisci — la concezione di un nuovo umanesimo planetario e plurale, non più imposto dalla ragione universale della civiltà europea, ma composto dal colloquio, dal parlare insieme delle diverse culture del mondo».
Scoprire l’altro, vivere con lui, sentirlo, lasciarsi permeare dalla sua diffidenza non significa perdere la propria identità e rigettare i propri colori, ma concepire un’umanità non escludente, un’umanità al plurale.
Come si vede io non ho nessun progetto di tipo ingegneristico, né culturale, né personale, né sociale, ma solo il tentativo di vivere con la gente, scrutando i “segni” per coinvolgermi in essi, mettendomi in obbedienza a quella luce che porta verso la vita.
Mi pare che la cultura oggi per me abbia un senso di concretezza e di quotidiano sempre più reale e al tempo stesso mi solleciti allo sguardo universale, cosmico, come l’orizzonte che indica il cammino e attrae.
Avere il senso dell’attesa
Cultura per me più che un progetto è scelta di vita e cammino di liberazione ed è in questo senso che cerco il dialogo come unico metodo per crescere culturalmente, scambio nella parità e nella diversità.
Accogliere l’utopia come possibilità che un giorno diventi realtà, senza stancarsi perché “l'impazienza è la nebbia dell’anima”.
Roma, 7 Luglio 1998