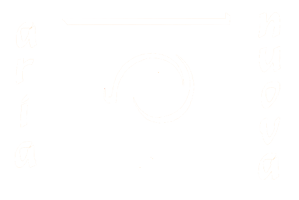Il ‘turbocapitalismo’
- a cura del CENTRO STUDI arya -
Siamo nel pieno di una grande trasformazione all’interno del mondo del lavoro: la terza finora avvenuta nella storia moderna.
La prima trasformazione avvenne agli inizi del XIX secolo con la rivoluzione industriale e fu caratterizzata dal sistema di fabbrica e dal lavoro alla macchina. A grandi ingegni come A. Ferguson, A. Smith, T. Carlyle, R. Owen, A. de Toqueville e tanti altri, quelle “officine del sudore” fecero presagire la frantumazione del lavoro e la degradazione del lavoratore.
La seconda trasformazione è avvenuta agli inizi del XX secolo con il ‘taylor-fordismo’ ed è stata caratterizzata dal lavoro seriale per la produzione di massa. La “catena di montaggio”, che nella celebre pellicola di Chaplin Modern Times arriva letteralmente a risucchiare il lavoratore negli ingranaggi, aveva fatto intravedere la dequalificazione del lavoro e l’alienazione del lavoratore a chi l’aveva conosciuta, come S. Weil, G. Navel, M. Burawoy, R. Linhart, H. Braveman, e a studiosi come G. Friedmann, C. Walker, R. Guest, R. Blauner.
Questa terza trasformazione che giunge ora, agli inizi del XXI secolo, è caratterizzata dalla produzione snella ‘just-in-time’ e dal lavoro flessibile; ciò fa temere una destrutturazione e una precarizzazione in cui Richard Sennett vede il rischio di una “corrosione della personalità”, come dice il titolo originale del libro che in traduzione italiana è conosciuto come L’uomo flessibile, che spinge l’Autore a proporre una domanda fondamentale: «Come può un essere umano sviluppare un’autonarrazione di identità e una storia della propria vita, in una società composta di episodi e frammenti?».
Ieri i sociologi studiavano la fatica, l’oppressione, la monotonia, l’estraniazione; oggi devono studiare la discontinuità, l’instabilità, l’insicurezza, la precarietà.
L’impresa oggi è spinta a operare in modo sempre più congestionato, convulso, quasi parossistico, assillata dalla variabilità della domanda, dalla volatilità dei mercati, da vorticose natimortalità aziendali, da ricorrenti rischi di scalata, dall’esigenza di alleanze strategiche, dalle insidie delle acquisizioni, dagli interrogativi della delocalizzazione, dall’obsolescenza dei prodotti, dalla comparsa della concorrenza asiatica.
Questo impazzimento è noto come ‘turbocapitalismo’.
In questo vertiginoso clima, in questi mercati perennemente nevrotizzati, non si ha più tempo da dedicare ai dipendenti e alla loro formazione. Magari di soldi sulla formazione se ne spendono anche (sebbene il più delle volte questo sia un mero escamotage privo di reali contenuti, fatto solo per poter attingere a sovvenzioni pubbliche), ma la fretta, la concitazione e la frenesia impediscono a queste imprese di valorizzare le risorse umane che, oltretutto, sono diverse da ieri anche in termini sociali, psicologici, forse persino antropologici.
La tendenza sempre più diffusa è anzi quella di creare figure pseudo-professionali, che si pretende siano già formate e soprattutto prive di tutele e di garanzie: è la fascia dei lavoratori a tempo determinato, che si estende vertiginosamente. Sono loro i ‘fuoricasta’ del sistema economico moderno, ed è una percentuale in preoccupante aumento. Accanto alle quattro caste tradizionali (intellettuali, soldati, imprenditori, dipendenti con contratto a tempo indeterminato) ecco profilarsi l’abisso della degenerazione sociale: disoccupati cronici e eterni precari. L’Occidente guarda il sistema delle caste in India con un disprezzo misto a un senso di superiorità, ma lo sta drammaticamente riproducendo con sorprendente rapidità — con, in più, l’ipocrisia di non volerlo ammettere.
Come se tutto ciò non bastasse, all’interno di un simile capitalismo turbinoso, sempre più selvaggio e forsennato, si sta verificando un ulteriore fenomeno, che alcuni hanno definito con il termine di “biocapitalismo” — vale a dire, la tendenza (in crescente diffusione) a trattare la vita (bios) dell'individuo come un semplice ingranaggio del sistema di produzione e di consumo, in tutti i momenti della sua vita e non più soltanto nei momenti in cui egli produce o acquista dei beni o dei servizi: anche quando si diverte, quando cerca di prendersi cura della salute e del benessere del proprio corpo, quando si dedica ai propri svaghi o passatempi, quando vive momenti intimi con i propri cari o con gli amici, quando coltiva interessi di qualunque tipo (ivi compresi quelli culturali), quando ozia e perfino mentre dorme. In pratica, l’essere umano è spinto sempre più a trasformarsi in una sorta di cavia volontaria di nuove tecnologie — compresa la chirurgia estetica e l’ingegneria genetica. Come recita il sottotitolo del libro Il biocapitalismo di Vanni Codeluppi, si sta procedendo “verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni”. Lo stesso computer e, ancor di più, alcuni gadget elettronici — primo fra tutti il telefonino cellulare, che ormai la stragrande maggioranza dei possessori tiene patologicamente acceso giorno e notte (non a caso è stata individuata una nuova patologia, la cosiddetta ‘nomofobia') — concorrono verso questo raccapricciante obbiettivo.
Da notare, in conclusione, che tutto questo era già stato preconizzato nel Novecento dal profondo e lungimirante filosofo Günther Anders, nei due tomi del suo notevolissimo saggio “L’UOMO È ANTIQUATO”. Come dice lo stesso Günther, l’uomo sta mostrando di essere cieco di fronte alla propria Apocalisse!