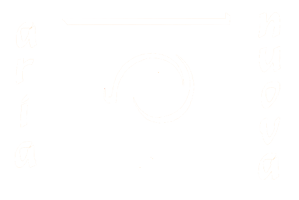IL POTERE CREATIVO DEI POETI
di Tommaso Iorco
(autore tutelato S.I.A.E.)

Si racconta che il rishi Madhucchandah Vaishvamitra, uno dei più poderosi poeti-veggenti dell’età vedica, creò — in un eccesso d’ira nei confronti del dio Indra — un vero e proprio universo antagonista. È questo il potere dei grandi poeti: dare forma vivente a ciò che si mostra innanzi alla loro visione interiore, esistente (forse da sempre e per sempre) nel puro regno dell’immaginazione creativa.
Sri Aurobindo, che può a giusto titolo considerare l’intera poesia mondiale (e non soltanto in virtù della sua profonda conoscenza di sanscrito, latino e greco da un lato, e dell’inglese e del francese dall’altro, e per la discreta conoscenza dell’italiano, del tedesco, dello spagnolo, del bengali, del tamil, dello hindi), in un carteggio privato indica quali egli considera essere stati i più grandi poeti del passato.
La grandezza di un poeta dipende ovviamente da un insieme armonico di molteplici fattori, quali l’originalità della sua immaginazione poetica, le capacità di potere espressivo che egli possiede, il genio artistico di cui è dotato (ovvero la sua capacità creativa di dare vita a un mondo vivo e vibrante, sorto dalla propria immaginazione) e, non da ultimo, le motivazioni poetiche, le tematiche a lui care, le profondità che riesce a portare alla luce, la vastità e l’universalità delle proprie singolari meditazioni poetiche, le altezze che riesce a trarre in basso con le proprie ‘opere d’inchiostro’, oltre naturalmente alla tipologia stessa di tali composizioni. Insomma, deve trattarsi di un vero creatore, similmente al Vaishvamitra vedico, capace di immergerci in un universo tutto suo.
Sri Aurobindo, nella lettera menzionata, indica tre gradi nei quali inserisce i massimi poeti del passato; nel primo grado, troviamo i quattro poeti più grandi in assoluto: Valmiki, Vyasa, Omero, Shakespeare; nel secondo figurano invece sei poeti leggermente inferiori: Dante,Kalidasa, Eschilo, Sofocle, Virgilio, Milton; nel terzo, pone Goethe, tutto solo, sebbene, secondo taluni estimatori di poesia, se Sri Aurobindo avesse conosciuto la lingua persiana, avrebbe certamente messo Firdusi (da lui letto solo in traduzione) a tener compagnia al genio tedesco. E arriviamo così al numero perfetto: dodici poeti, a costituire il vertice raggiunto dalla poesia nel passato più o meno antico. Ovviamente, data l’estrema soggettività della bellezza, e quindi di tutta quanta l’arte, ognuno sarà libero di creare il proprio Parnaso. Personalmente, condividiamo pienamente questa scelta, che facciamo nostra, poiché soddisfa a un tempo la nostra percezione intuitiva e la disamina più prettamente estetica.
L’uomo, dice un famoso coro di Sofocle, è di tutte le cose portentose la più portentosa (deinòs), un mistero per così dire ‘ambiguo’, sia nel senso che vive contemporaneamente su due dimensioni d’essere — quella naturale e quella sovrannaturale — altrettanto affascinanti e misteriose, sia nel senso che pare albergare in sé quanto di più divino e insieme di più demoniaco esiste in natura. Sicché, sintetizzando, potremmo concludere che il grande poeta è colui che riesce a esprimere con vivida energia e con straordinaria musicalità e forza di suggestione qualcosa dell’immenso mistero dell’uomo. Ove per uomo intendiamo il tagoriano ‘uomo universale’ (vaishva-manava), l’essere umano nella sua più ampia e più genuina realtà d’essere. Così come il compito del poeta del futuro — secondo le indicazioni che lo stesso Sri Aurobindo ci fornisce in The Future Poetry, e secondo quanto egli stesso realizza magistralmente nella sua impareggiabile opera poetica — dovrebbe essere quello di svelare il mistero del ‘dopo-uomo’ o, se vogliamo trovare anche in questo caso un’espressione sanscrita, del siddha-purusha.
Ma, soffermandoci per ora sulla lista dei Dodici del passato, può stupire di trovare, nel primo grado, accanto agli indiscutibili e titanici Vyasa, Valmiki e Omero, un poeta quale Shakespeare, che sotto certi aspetti può essere considerato a essi inferiore. Tuttavia, considerando l’insieme delle sue opere e la singolarissima genialità creatrice che da esse inconfondibilmente promana, la scelta pare appropriata. Certo, il linguaggio poetico di Shakespeare non è altrettanto elevato — la lingua inglese, di per sé, non possiede neppure lontanamente la melodiosa fluidità del greco né la vibrante sfericità musicale del sanscrito (poderosa e delicata al tempo stesso). I francesi, all’epoca, considerarono la poesia di Shakespeare rozza e barbara, a confronto della brillante e levigata raffinatezza di un Corneille e di un Racine, o della soave musicalità e bellezza della poesia italiana. Eppure, nel caso di Shakespeare, o meglio di ciò che egli esprime attraverso la propria poetica, il ritmo rude e sincopato e l’estrema compattezza della lingua anglosassone non costituiscono affatto un impedimento, bensì — paradosso del linguaggio poetico! — il suo mezzo più adeguato. Per motivi analoghi, spingendo il paradosso oltre ancora, lo stesso Sri Aurobindo è riuscito a rendere l’inglese la lingua moderna più appropriata per dare voce alla più alta espressione di poesia mistica mai conosciuta.
Shakespeare è senza alcun dubbio il più grande drammaturgo d’ogni epoca, mentre i tre più sublimi poeti indicati, Omero, Vyasa e Valmiki, come si sa, sono poeti epici. E gli altri drammaturghi presenti in questa rosa — Eschilo e Sofocle innanzi tutti — non posseggono una simile grandezza. È vero che appena sette sono le tragedie sopravvissute per ognuno dei due grandi tragici greci, nonostante ne abbiano scritte assai di più (novanta il primo, centotrenta il secondo, superando quindi largamente le trentasette opere attribuite al bardo di Avon); e tuttavia, anche se fosse disponibile l’intera drammaturgia dei tragici greci, difficilmente ciò potrebbe cambiare il verdetto. La quantità conta solo in parte, e relativamente.
Shakespeare — fra le altre cose — è riuscito a creare, attraverso le sue opere teatrali, una prodigiosa galleria di personaggi, altrettanto reali e credibili dei più importanti personaggi in carne e ossa che nel corso dei secoli hanno calcato il vasto palcoscenico del mondo (totus mundus agit histrionem, si trovava per l’appunto iscritto sopra i palcoscenici elisabettiani — mutuato probabilmente dal verso di Petronio mundus universus exercet histrionam). Dove possiamo trovare, in natura, qualcosa di più convincente e portentoso di un Amleto, un Re Lear, un Macbeth, un Falstaff, un Prospero, un Otello, un Coriolano? Dove trovare, altrove, tra gli altri autori drammatici, una simile sovrabbondanza di vitalità, un simile prorompente ribollio d’energie vitali, di autentica esuberanza creativa? Qui risiede tutta la grandiosa forza creativa (e i limiti, anche) di Shakespeare. Poeti artisticamente assai più raffinati di lui — un Lucrezio, per esempio, o un Euripide, o un Petrarca… per non parlare di Ovidio, che il nostro ‘Scuotiscene’ amava sopra ogni altro — non figurano nemmeno nell’elenco, proprio perché, nonostante tutto, è mancato loro quell’indicibile quid che egli invece possedeva in abbondanza, e che fa tutta la differenza.
Penetrando le opere di Shakespeare, non si può certo dire ciò che Michelangelo espresse in modo così appropriato a proposito del sommo bardo greco: «Quando leggo Omero, mi guardo per vedere se non sono cresciuto almeno venti piedi in altezza… Egli fa gli uomini di una statura più grande del naturale. Essi si scagliano contro macigni che dodici paia di buoi non potrebbero smuovere. Si ha in Omero la pittura esatta dell’umanità ottenuta per mezzo dell’ingrandimento». Ebbene, non l’ingrandimento, ma l’esame microscopico sembra il metodo principale di Shakespeare. A lui non interessa offrire alcuna sintesi; si sofferma anzi sul dettaglio, sul particolare, e lo esamina con la sua mirabile lente d’ingrandimento, con formidabile minuzia psicologica e, insieme, con prodigiosa naturalezza. E non lo fa alla maniera di un John Foxe, con severo cipiglio morale, né con intenti sociali, come avverrà mirabilmente nel caso di Bertold Brecht: il suo è uno sguardo che non emette giudizi e non intende elargire alcun ammaestramento (invano è stato cercato, nei secoli, il punto di vista dell’Autore: egli sembra assumere totalmente, volta per volta, il punto di vista di ciascuno dei suoi personaggi, come solo un dio saprebbe fare). Al tempo stesso, tuttavia, the Bard non si limita a essere un puro e semplice fotografo della natura: lui la natura la reinterpreta o, meglio ancora, la ricrea con formidabile e personalissima genialità. Omero possiede l’occhio candido ed eternamente meravigliato di un bambino; Shakespeare, invece, da buon teatrante, puzza meravigliosamente di zolfo, e ci offre uno stregonesco calderone verbale in cui buffoneria e follia sono condimenti essenziali quanto il gusto del tragico. In lui, peraltro, tragedia e commedia si fondono al punto che risulta difficile fissare precise linee di demarcazione fra l’una e l’altra — similmente a quanto avveniva negli antichi misteri dionisiaci, in cui il “canto del capro” (tragoidìa, da cui tragedia) e il “canto del festino” (komoidìa, da cui commedia), erano i due aspetti, sacrificale e conviviale, di un medesimo atto rituale.
Molti, soprattutto tra noi italiani, hanno la tendenza a considerare Dante superiore a Shakespeare. E, se esaminiamo esclusivamente l’altezza del livello d’ispirazione, non c’è dubbio che il Nostro attinga da piani assai più elevati di quelli ai quali il Bardo inglese ha comunemente accesso; tuttavia, considerando nell’insieme la loro poetica, è innegabile che le capacità espressive di Shakespeare siano notevolmente superiori. Non si tratta qui di mettere a confronto due poeti così diversi e così geniali, bensì di riconoscere che, pur essendo ambedue talmente grandi e talmente unici da rendere ozioso qualunque confronto, hanno manifestato poteri creativi in diversa misura. Parafrasando lo stesso Dante, potremmo dire che la gloria di Colui che tutto move, pur pervadendo tutto, si manifesta con diversi gradi di attuazione, ovvero in una parte più e meno altrove.
Qualcuno potrebbe poi trovare inaccettabile l’assenza di un poeta francese. Possibile che la Francia, patria di una cultura così nobile e raffinata e liberale, non abbia prodotto un solo poeta degno di meritarsi un simile alloro? Tre poeti greci, tre sanscriti, uno latino, uno persiano, uno italiano, uno tedesco addirittura (nonostante l’asprezza della lingua teutonica), e per giunta due inglesi, e nemmeno uno francese! Parbleu, quel honte!
Scherzi a parte, e in tutta sincerità, anche noi avremmo preferito che un francese colmasse il posto di uno dei due inglesi. Senza considerare che lo stesso Sri Aurobindo amava la letteratura e la cultura francese più di quella inglese. Purtroppo, però, con tutta la buona volontà, non siamo riusciti a trovare un solo poeta francese che potesse assolvere meritoriamente l’alto compito ed essere posto sulle cime del Monte Elicona. Per quanto grandi, né Molière, né Mallarmé, né Villon, e neppure i già citati Corneille e Racine, possono essere presi in considerazione. L’unico che si sarebbe potuto avvicinare avrebbe potuto essere Hugo, ma il suo corto respiro poetico non gli ha permesso di raggiungere cime così elevate. Quando al grande letterato francese André Gide, Premio Nobel, venne chiesto chi fosse il più grande poeta francese, egli rispose laconicamente: «Hugo, hélas». Già, “purtroppo”.Victor Hugo possiede senza alcun dubbio una sorprendente e copiosissima capacità espressiva, ma i suoi voli poetici non possiedono basi sufficientemente profonde, e così, tutto si perde nell’astrattezza, talvolta addirittura nell’indistinto, e la sua poesia svapora spesso nell’eterea inconsistenza di un cielo piatto e incolore. Hugo, in poesia, non è stato capace di insufflare autentica vita a un solo personaggio veramente credibile e reale. Forse, se egli avesse avuto un’opinione di sé un po’ meno esagerata, nutrendo una più equilibrata misura di se stesso avrebbe potuto possedere l’umiltà di approfondire in modo appropriato le ricche doti artistiche di cui era indubbiamente fornito. Invece, purtroppo, la sua megalomania lo spinse in tutt’altra direzione; al punto da arrivare a rispondere, ad un giovane che gli confidò un giorno le sue assidue letture di Omero, Shakespeare e Goethe: «Mais à quoi bon? Je les résume tous»! Hugo, proprio come sarebbe capitato di lì a poco all’auto-compiaciuto D’Annunzio, non sa coniugare pazientemente i baratri alle altezze, non sa sposare l’alata radiosità con l’altrettanto necessaria sottigliezza psicologica. Insomma, entrambi si sono dimostrati pressoché deficienti quanto a capacità di autocritica e di sereno equilibrio. Il fuoco poetico che li pervadeva, passando attraverso un cuore e un cervello troppo infatuati di sé, veniva fatalmente soffocato, fermandosi purtroppo a metà strada in un parziale e fumoso compimento, pur nella generale grandezza delle loro rispettive opere.
E potremmo continuare ad infinitum con interrogativi simili: perché mai, per esempio, l’assenza di uno spagnolo — perché un Calderòn non dovrebbe meritare di entrare nel novero dei grandissimi? E i sublimi poeti russi, li vogliamo buttare tutti quanti giù dalla torre? E ai poeti cinesi e giapponesi deve essere negato tale privilegio solo perché hanno il supremo dono dell’estrema brevità? Ebbene, a questo punto, ognuno intervenga come meglio crede nel modificare o anche nel distruggere questa hit parade della poesia (non pretendiamo certo di essere gli esclusivi possessori delle chiavi del paradiso poetico!). Magari si discutesse più di queste cose che di prét-à-porter e di classifiche calcistiche! Ma, come lo humour anglosassone ci insegna, to each one his paradise — a ognuno il suo paradiso!
Maggio 2003