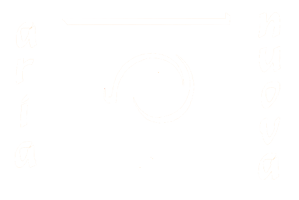L’origine del linguaggio
di Tommaso Iorco
(autore tutelato SIAE)
Nel corso del secondo decennio del XX secolo, Sri Aurobindo mise su carta vari appunti relativi a una nuova scienza che prenderà il nome di ‘linguistica’, incentrata sullo studio delle lingue nella loro storia, nelle loro strutture e nei loro rapporti con la storia della cultura e dell’evoluzione dei cicli sociali. Pur avendo dei precedenti nel X-XI secolo (quando fu riconosciuta l’unità delle lingue semitiche), nel XVI secolo (quando venne abbozzato un primitivo metodo comparativo delle lingue neolatine o romanze) e nel XVII secolo (quando si affermò il metodo comparativo, esteso ai rapporti tra latino e sanscrito), fu solo nella seconda metà del XX secolo che la linguistica iniziò a delinearsi come vera e propria scienza, essendo stata in gran parte respinta nel XIX secolo dal positivismo che tentò di dimostrare la sola validità di quella che oggi viene chiamata la ‘linguistica storica’, incentrata sullo studio dello sviluppo delle lingue attraverso il tempo, a detrimento di quella che è conosciuta con il nome di ‘linguistica generale’, che cerca di definire le leggi generali cui si possono ricondurre i fenomeni linguistici in genere. Sri Aurobindo si dimostra pertanto un pioniere anche in questo ambito, gettando le basi di una vera e propria scienza riguardante «le origini e le leggi di sviluppo dell’umano linguaggio» (da “Il segreto dei Veda”, aria nuova edizioni). La sua intenzione era di pubblicare un adeguato studio sull’argomento, teso a esporre le conclusioni alle quali giunse. Tuttavia, purtroppo, non trovò mai tempo per scrivere tale saggio, lasciandoci varie annotazioni e fogli sparsi che costituiscono un primo abbozzo di stesura del libro. Cerchiamo anzitutto di capire come nacque in lui questo interesse, dopodiché tenteremo di offrire una sintesi delle sue scoperte linguistiche.
Fu con lo studio della lingua tamil, iniziato verso il 1909, che si aprirono per Sri Aurobindo le porte di una nuova interpretazione dei Veda e, contemporaneamente, di nuove frontiere di questa neonata scienza del linguaggio. Prima di tale data, i suoi studi delle lingue furono motivati prevalentemente da fattori squisitamente letterarî. Conoscitore della lingua inglese fin dalla più tenera infanzia, egli studiò il francese e il latino ancor prima di entrare nella St. Paul School di Londra (nel 1883), dove ebbe modo di approfondire la propria conoscenza del latino e di imparare il greco antico in modo così approfondito da ricevere riconoscenze accademiche in occasione dell’esame preliminare che lo introdusse nel prestigioso King’s College di Cambridge (nel 1890), nel quale, oltre a perfezionare il greco e il latino, iniziò a studiare il sanscrito, il bengali e lo hindustani, e apprese anche il tedesco, l’italiano e lo spagnolo al punto da potersi permettere di leggere i maggiori classici di tali lingue nei rispettivi originali. Sicché, nel 1892 (all’età di vent’anni) Sri Aurobindo era un versatile “linguista”, nel senso in cui all’epoca si intendeva il termine, vale a dire un profondo poliglotta. Mentre le sue conoscenze di filologia (così era all’epoca conosciuta la moderna linguistica) erano piuttosto generiche.
Al suo ritorno in India, nel 1893, egli iniziò a dedicarsi in modo intensivo allo studio delle lingue e della letteratura indiane. Si concentrò principalmente sull’approfondimento del sanscrito e del bengali, senza tuttavia trascurare lo studio di altri pracrita (vernacoli indiani), quali il gujarati e il marathi (le due lingue parlate a Baroda, ove soggiornò per alcuni anni, come docente universitario e vice-rettore) e lo hindi. Appena raggiunse una buona padronanza del sanscrito, cominciò a tradurre in inglese passaggi dalle due principali epopee indiane — il Mahabharata e il Ramayana —, dalle opere di autori classici (in primis Kalidasa) e, qualche anno dopo, testi sapienziali quali le Upanishad e la Bhagavad Gita. Per quanto concerne il bengali, furono Bankim Chandra Chatterji e Madhusudhan Datt che catturarono maggiormente la sua attenzione, sebbene tradusse anche opere di poeti medioevali.
Ma fu solo nel 1910, volendo approfondire il sanscrito vedico, che Sri Aurobindo — oltre a scoprire il senso segreto dei testi vedici — iniziò a intravedere una vera e propria scienza delle origini del linguaggio umano, aiutato notevolmente, come si diceva, dallo studio del tamîl. «Poiché, esaminando i vocaboli della lingua tamil, in apparenza così lontani dal carattere e dalla forma sanscrita, mi trovai continuamente guidato da parole o da famiglie di parole considerate puro tamil a stabilire nuove relazioni tra il sanscrito e la sua distante sorella, il latino e, occasionalmente, anche tra greco e sanscrito. Talvolta il vocabolo tamil non solo suggeriva la connessione, ma forniva la prova del legame perduto all’interno di una famiglia di parole tra loro connesse. E fu proprio attraverso la lingua dravidica che giunsi a percepire quella che mi apparve come la vera legge, l’origine e, infine, l’embriologia delle lingue arie» (da “Il segreto dei Veda”, op. cit.).
Pertanto, lo studio del tamil non lo aiutò soltanto nel comprendere meglio il vero senso delle innodie vediche e di trovare in esse alcune conferme alle proprie esperienze spirituali; come egli stesso precisò, «fin dall’inizio del mio studio della lingua tamil, mi parve di cogliere una chiave delle vere origini a delle vere strutture dell’antica lingua sanscrita; e tale scoperta mi condusse talmente lontano che persi interesse per il mio iniziale soggetto di studio, ovvero la connessione tra il linguaggio arya e quello dravida, e mi immersi nell’ancora più affascinante ricerca delle origini e delle leggi di sviluppo del linguaggio umano stesso» (ibidem). A tal fine, Sri Aurobindo iniziò anche lo studio dell’ebraico, giacché anche le lingue semitiche presentarono ai suoi occhi connessioni sorprendentemente interessanti e, tuttavia, non ebbe mai tempo di approfondire sufficientemente tali legami (giungendo comunque a percepire che la divisione tra lingue semitiche e lingue indoeuropee era, secondo le sue stesse parole, «non scientifica», esattamente come la divisione tra le lingue arie e le lingue dravida). Quello che egli stesso più volte definisce il suo vero lavoro — come ben sanno gli appassionati — era altro ancora, e riguardava qualcosa di assai più cruciale e importante: accelerare la transizione evolutiva in atto, affrettare la discesa di un ‘nuovo’ potere di coscienza in grado di trasformare l’uomo e il pianeta in cui vive, collegandolo a quella divina gioia (Ananda) da cui tutto è scaturito.
In merito all’ebraico, qui ci limitiamo a ricordare che, per gli studiosi della Kabbalah, le ventidue lettere di cui è composto il suo alfabeto rappresentano i caratteri significativi, rappresentativi e conoscitivi dell’intero divenire. Basta compulsare un testo come il Sepher Yetzirah (tanto stringato quanto denso nel suo ricco ermetismo) — interamente dedicato alla simbologia esoterica delle lettere alfabetiche — per intuire fino a che punto tali segni siano visti quali fondamenti portanti della conoscenza del reale e, al tempo stesso, dell’atto creativo medesimo. L’energia racchiusa in ogni singolo carattere alfabetico è, per l’attento cabbalista, espressione di una specifica potenza divina, di un particolare attributo creativo. Tale energia funge pertanto da indispensabile legame vibratorio con il principio seminale da cui ha origine quel mistero che noi chiamiamo universo. In tal modo, davanti al neofita si dipana un metodo dinamico che gli permetterà di comprendere l’infinito flusso del divenire fenomenico e, a certe condizioni, perfino di incanalarlo. Visto in questa prospettiva, l’alfabeto (ricordiamo che la stessa etimologia del termine deriva dall’ebraico alef beit), ben lungi dal limitarsi a costituire il tessuto fondativo per la creazione dei fonemi (indispensabili per la prassi della comunicazione verbale fra esseri umani), viene a configurarsi come un mezzo di notevolissima eccellenza per arrivare a comprendere il reale substrato fenomenico e, in una certa misura, a interagire quali strumenti attivi di quella stessa Dynamis che ha messo in moto il cosmo intero.
Il Sepher Yetsirah erige inoltre un collegamento ben preciso tra le dieci Sephiroth e le ventidue lettere dell'alfabeto ebraico, associate ad altrettanti sentieri e, sommati tra loro, formato trentadue vie (per ovvie ragioni, rimandiamo allo studio diretto del testo ed evitiamo espressamente di addentrarci nel merito, lasciando tale compito ai più competenti rabbini studiosi di Kabbalah).
Molte altre culture della più remota antichità (ciascuna a proprio modo e con le peculiarità che la contraddistingue) possedevano una qualche consapevolezza del potere della parola, a prescindere dal significato razionale — e ben al di là di esso.
Nel sanscrito vedico, per esempio, sono chiaramente prefigurate quelle implicazioni mantriche riprese in seguito dalla mistica tantra. Analoghe funzioni ‘magiche’ (nell’accezione più alta del termine) rivestono le singole lettere alfabetiche presso altre tradizioni ancora, quali la caldea, la mesopotamica, l’egizia, la celtica, la germanica (basti pensare alle sacre rune), la greca, l’iraniana, l’araba e via proseguendo, fino a giungere a certe tendenze misteriche presenti nella tradizione latina.
In sintesi, possiamo affermare che la potenza racchiusa nella componente grafica e/o sonora delle lettere alfabetiche, era fortemente riconosciuta e praticata nell’antichità.
Talvolta, perfino, l’interpretazione esoterica delle lettere viene ulteriormente amplificata mediante la connessione con ben precisi valori numerici — e, anche in questo caso, la Kabbalah ne rappresenta una delle testimonianze più significative e minuziose.
Sri Aurobindo, dal canto suo, pervenne a interessanti approfondimenti, che — come accennato — possiamo desumere dagli oltre cento taccuini linguistici ritrovati postumi (quindici dei quali dedicati unicamente o primariamente a tale soggetto).
In questi taccuini, Sri Aurobindo deduce anzitutto che il fattore determinante nello sviluppo di un qualunque linguaggio umano fu l’associazione (operata nella mente nervosa dell’uomo primitivo) di taluni significati generali o, per meglio dire, di alcune utilità generali e di certi valori sensoriali in rapporto ai suoni articolati. Il processo di tale associazione si produsse in modo organico, per nulla artificiale, essendo governato da semplici e ben definite leggi psicologiche che Sri Aurobindo rintraccia. Le parole, egli annota, non nascono come prodotti artificiali, bensì come qualcosa di vivo che si sviluppa da suoni-seme; da questi, si diramano un modesto numero di suoni-radice con una immensa progenie, da cui prendono nascita successive generazioni che, a loro volta, proliferano e si raggruppano in famiglie, clan, tribù, gruppi e sottogruppi, aventi un ceppo comune e una comune storia psicologica.
Ai loro inizi, i suoni del linguaggio non vengono usati per esprimere ciò che noi oggi chiamiamo delle ‘idee’; sono, piuttosto, gli equivalenti fonici di certe sensazioni primarie. I nervi, non l’intelletto, hanno creato l’umano linguaggio. Le parole, che in origine erano estrinsecazioni vitali colme di una qualche potenzialità sensoriale, si sono in seguito evolute in simboli fissi, rivestendo precisi significati mentali. Pertanto, originariamente, le parole non erano strettamente legate a concetti rigidamente definiti. Possedevano, ognuna, un carattere generale, ovvero — traducendo il termine sanscrito “guna” — una ‘qualità’, suscettibili a prestarsi a un cospicuo numero di applicazioni e, di conseguenza, a una certa gamma di significati possibili. Dapprincipio, il suono determina il senso di una parola; alla fine del percorso dell’evoluzione del linguaggio, l’idea assume un’importanza predominante, mentre il suono diventa secondario.
Le prime parole di un qualunque linguaggio umano esprimono concezioni basilari, quali luce, freddo, caldo, contatto, movimento, sostanza, estensione, forza, velocità, azione, fame, eccetera. Quindi, interviene una crescita graduale (nel senso di una sempre maggiore varietà di vocaboli) e, con essa, una sempre maggiore precisione di significato. La progressione va dal generale al particolare, dal vago al definito, dal vitale al mentale, dal concreto all’astratto, dall’espressione di una ricca varietà di sensazioni all’espressione della differenza precisa tra i varî tipi di sensazione. E questa progressione segue leggi sostanzialmente analoghe nelle varie lingue, adattate ovviamente ai differenti fattori ambientali e alle diverse circostanze intercorrenti tra i gruppi di uomini che prendono a parlare una medesima lingua.
Le vocali pure — quali ad esempio ‘a’, ‘i’, ‘u’ — indicano il senso dell’essere, dell’esistere; mentre le rispettive forme lunghe (‘â’, ‘î’, ‘û’) conferiscono a tale senso maggiore enfasi. Per esempio, la vocale ‘a’ denota uno stato d’esistere esteso, illimitato, con un punto di partenza ma senza un preciso punto d’arrivo: è l’ens nella sua semplicità e fondamentale essenzialità, senza modificazioni né qualità. La forma lunga, ‘â’, assume la connotazione di uno stato diffuso e pervadente, generato dall’espansione di un puro stato d’essere. E dalla vocale ‘a’, derivano infatti — nell’antichissima lingua vedica — tutta una serie di suoni-seme in qualche modo connessi a tale concetto primario: ‘ap’, creare, trarre in esistenza, muovere; ‘amb’, produrre; ‘an’, sostanza sottile, esistenza espansa; ‘ag’, potere, forza primordiale, energia forte e luminosa; ‘aj’, procedere, seguire la propria strada, battersi; ‘ark’, ‘arc’, splendere; ‘as’, pervadere; ‘av’ crescere, diventare, gioire, prosperare; ‘ar’ energia dinamica, forza, valore; ‘anu’, perseguire con tenacia; ‘adh’, muoversi, estendersi, essere ampio e compatto.
Questa l’intuizione di partenza. Sarebbe facile ravvisare nella storia della mistica indiana i collegamenti che dai Veda e dalle prime Upanishad (si veda ad esempio la Mandukya), giunge al tantrico Abhinavagupta, per trovare nello studio dei singoli fonemi l’origine di tali studi e considerazioni.
Decisamente più sorprendente è invece il confronto con il poeta russo Chlebnikov che, nel 1920, scrisse una riflessione — nel suo Nâa osnova — che presenta notevoli punti di contatto con quel potere di significazione della parola che abbiamo cercato di estrapolare e sintetizzare dalle note di Sri Aurobindo. Ecco cosa scrisse il poeta russo, ragionando sulla propria lingua: «Se si prende una parola, per esempio caska (coppa), noi non sappiamo quale senso abbia ogni singolo suono per l’insieme della parola. Tuttavia, se si accostano le parole che cominciano con il suono c, ad esempio caska (coppa), cerep (cranio), can (tino), culok (calza), tutti gli altri si annullano reciprocamente, e il significato comune di queste parole è rappresentato dalla c. Confrontando le parole in cui figura il suono iniziale c, notiamo che tutte suggeriscono il rivestimento di un corpo da parte di un altro: c significa rivestimento.
Così, il linguaggio transmentale cessa di essere transmentale. Diventa un gioco con un alfabeto di cui abbiamo coscienza, una nuova arte alla cui soglia noi oggi ci troviamo. La lingua transmentale muove da due presupposti:
1) la consonante iniziale di una parola orienta l’intera parola, e si impone alle altre consonanti;
2) le parole che cominciano con la stessa consonante sono collegate da un concetto comune, come se da luoghi diversi spiccassero il volo per raggiungere il medesimo punto logico.
Se si prendono le parole caska (coppa) e cobot (stivali), si constata che il suono c orienta e condiziona le parole, perché se si accostano le parole che iniziano con il suono c, culok, coboty, cereviki, cuvjak, cuni, cupiki, e cechol, caskan, cara, can, celnok, cerep, cachotka, cucelo, notiamo che tutte si incontrano nel punto dell’immagine seguente: si tratti di calza (culok) o di coppa (caska), in ogni caso il volume di un corpo (dei piedi o dell’acqua) riempie il vuoto dell’altro corpo che funge da involucro. Di qui la parola ‘fascinazione’ (cara) come rivestimento magico che paralizza la volontà della persona fascinata — l’acqua rispetto al nappo; di qui ‘sperare’ (cajat’), cioè essere la coppa (caskan) che deve raccogliere le acque del futuro. In tal modo il suono c viene a essere non soltanto un suono, ma anche un nome, un corpo indivisibile della lingua» (op.cit.).
Vediamo ora come Sri Aurobindo coglie collegamenti analoghi. Riflettendo sull’origine della parola sanscrita agni, scrive intorno al 1912: «la radice ag è una formazione secondaria della primitiva radice a, che significa essenzialmente essere o, al transitivo, avere. ‘A’ esprime l’essere nel suo più vasto e diretto senso senza alcuna idea di sostanza o di attributo. Il suono g suggerisce applicazione, contatto, oppure gentile pressione o insistenza. Combinato con a offre il senso dell’essere o del possedere con una applicazione di forza verso l’azione, verso gli uomini, verso le cose, e acquista facilmente il significato di forza, potere, eccellenza, preminenza, brillantezza da una parte, e di gentile contatto, amore, possesso dall’altra. Suoi derivati sono il latino e il greco ago, agô, condurre, guidare, agire; tendere; muovere; agathos, eccellente, buono; sanscrito agra, capofila, frontale; greco akros, sommità; akmê, punta estrema; aktê, limite ultimo, frontiera, crinale; agan, eccessivamente (antico ariano agâm); aganôs, brillante, grazioso, gentile (che pare a sua volta essere un sinonimo del sanscrito angirah, amabile); aglaos, amo, prediligo; ager, possedimento, campo… La parola agni significa dunque forte, luminoso, potente, e può anche suggerire, al tempo stesso, il suo significato determinato dall’utilizzo, un’allusione al suo ulteriore senso possibile di “amante” o “adorabile”, che troviamo nel greco agapê, amore. In seguito, è stato confinato al significato di fuoco, latino ignis» (Sri Aurobindo, The First Hymn of the Rig Veda).
È in questo modo che Sri Aurobindo getta le basi di una scienza ancora tutta da creare, che potrebbe portare a scoperte piuttosto importanti e sconvolgenti circa la diffusione planetaria della conoscenza. Limitiamoci ad accennare, in conclusione, al fatto che taluni studiosi iniziano a ravvisare importanti collegamenti non solo tra sanscrito, tamîl, greco e latino, ormai accertati senza possibilità di dubbio, ma anche con le lingue semitiche, celtiche, quichua (Incas), kafiri (Afghanistan settentrionale) e oltre ancora. Insomma, le frontiere della conoscenza iniziano solo ora a dischiudersi ai nostri orecchi, non ancora del tutto pronti a udire le autentiche meraviglie del suono mantrico.
© Settembre 2003