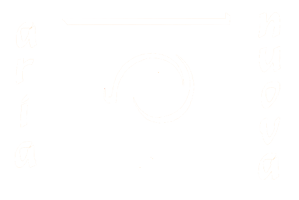SRI AUROBINDO
S A V I T R I
Canto I
L’AURORA SIMBOLO
Mancava un’ora al sorger degli Dei.
Contro il sentiero del divino Evento,
d’ampia fronte presaga, Notte, sola
nel buio tempio suo d’eternità
giaceva immota al bordo del Silenzio.
Quasi recava, opaco, impenetrabile,
in cieco simbolo, senz’occhi assorta,
dell’Infinito senza corpo il baratro;
zero insondabile occupava il mondo.
Forza del sé caduto e illimitato
destatasi fra un primo Niente e l’ultimo,
sapendo il grembo oscuro da cui sorse,
via dal mistero natale insolubile
e dal lento procedere ferale,
d’estinguersi sperava in vacuo Nulla.
Come in un buio inizio d’ogni cosa,
muta indistinta parvenza d’ignoto,
sempre un inconscio agire ripetendo,
cieco volere sempre prolungando,
cullò l’ignara Forza in sonno cosmico
che accende i soli in creativo sopore
e attrae le nostre vite nei suoi incubi.
Nella trance dello spazio, vana, enorme,
stupore informe senza mete o vita,
ombra errante in un vuoto privo d’anima
respinta ancora in sogni incongruenti,
la Terra abbandonata in cavi abissi
obliava il suo spirito e il suo fato.
Calmi, neutri, vacanti erano i cieli.
Qualcosa allora s’agitò in quel buio:
un moto ignoto, un’Idea non pensata,
insistente, mai pago, senza meta,
ch’esser voleva a non sapeva come,
trasse il Non-conscio a destare Ignoranza.
Un turbo giunse e lasciò un fremito,
fece spazio a un vecchio stanco anelito
nella subconscia grotta illune inerte
e trasalì per quella luce assente,
stropicciandosi gli occhi smemorati
pari a chi, ricercando un sé passato,
del suo desìo trova solo il cadavere.
Come se pure in questo fondo Nulla,
pure in quest’ultima dissoluzione,
si nascondesse un’entità immemore
frutto d’un morto e sepolto passato,
costretta a riesumare sforzo e pena
per ridestarsi in un mondo frustrato.
Una coscienza informe bramò luce
e un vacuo mantico un remoto cambio.
Come il dito d’un bimbo sulla gota
a rammentare il bisogno infinito
alla Madre dei mondi trasognata,
brama infante si strinse al cupo Vasto.
Una breccia invisibile si aprì:
incerta e solitaria lunga linea,
quel sorriso in un cuore disertato,
turbò la riva del sonno di vita.
Giunto dall’altra parte dell’illimite
l’occhio d’un dio scrutò i muti baratri;
perlustrando, solare messaggero
pareva in quella greve pausa cosmica,
nel torpore d’un mondo stanco e infermo,
in cerca d’uno spirito solingo
troppo in fallo per l’estasi perduta.
Evocando in un cosmo senza mente
— messaggio udito in caparbio tacere
— l’avventura di gioia e di coscienza,
sul petto affranto di Natura ottenne
nuovo consenso a vedere e sentire.
Un pensiero attecchì nel vuoto immane,
un senso nacque al fondo delle tenebre,
pulsò un ricordo nel cuore del tempo
come un defunto antico rianimato:
ma l’oblio susseguente la caduta
erose i fitti steli del passato
e da rifare era ciò ch’è distrutto
e l’esperienza occorreva ripetere.
Tutto può farsi col tocco divino.
Una fragile speme osava appena
nell’aspra indifferenza della Notte.
Come sollecitata in mondo alieno,
timido ardire di grazia istintiva,
orfana abbandonata e senza tregua,
raminga meraviglia senz’asilo,
in un remoto cantuccio di cielo
giunse un flebile accenno di prodigio.
Il tocco d’un vibrato che trasmuta,
l’inerte oscuro quietismo persuase
e la beltà stupì le sacre lande.
Mano errante d’incanto di bagliore
lucente al bordo d’un attimo breve,
d’aurea parete e cardine d’opale
porta di sogni schiuse sul mistero.
Una breccia lucente sull’arcano
forzò l’immensità cieca a vedere.
La veste d’ombra scivolando cadde
come dal corpo di un dio reclinante.
E al fragile aprirsi d’un albore,
stille appena di sole a un imperlare
si riversò rivelazione e fiamma.
Breve perpetuo segno accorse in cielo.
Malia di trascendenze mai raggiunte
iridata di glorie dell’Arcano,
messaggio d’immortale luce ignota
ardente sulla soglia del creato,
un’aura portentosa eresse l’alba
e di grandezza inseminò le ore.
Brillò per un istante la deità:
la visione s’accese per un poco
e giunse a coronar l’assorta terra.
Con una gioia e una beltà recondite
in cromatica mistica di glifi,
scrisse i versi d’un mito rilevante
narrando onuste aurore spirituali,
radioso codice iscritto nei cieli.
Quel giorno parve epifania svelare
cui sogni e spemi nostri sono tracce;
splendore arcano da imprecisa meta
si gettò quasi entro l’opaco Inane.
Un nuovo passo infransi i vacui Vasti;
centro d’infinità, un Volto ardente
dischiuse a paradiso eterne palpebre;
Forma di beatitudini giungeva.
Ambasciatrice fra l’eterno e il cambio,
scese la Dea onnisciente dalle altezze
che avvolgono il ruotare delle stelle
e spazi vide aperti al suo cammino.
Si girò appena al suo sole velato
per poi condursi all’opera immortale.
La terra sentì giungere l’Eterna:
udì i suoi passi l’attenta Natura,
la vastità la contemplava illimite
e lei sparse il suo riso sugli abissi:
nei muti mondi arse fuoco di gioia.
Tutto fu un rito e un atto consacrato.
L’aria vibrò fra terra e cielo, unendoli;
l’inno ampio-alato di un vento ieratico
s’alzò e svanì sull’altare dei colli;
l’azzurro accese alti rami in preghiera.
Qui, dove l’ignoranza sfiora abissi
sul muto seno dell’ambigua terra,
dove il passo seguente è sconosciuto
e il Vero siede in groppa al dubbio oscuro,
incerto e amaro campo di fatica
eretto su una vasta indifferenza,
di gioia e pena testimone equo,
sul suolo prono s’irradiò il risveglio.
Qui la visione e il profetico lume
forme ordinarie infiammò di portento;
poi l’afflato divino recedette,
non accolto dall’orbita mortale.
Sulle sue tracce indugiò un sacro anelito,
culto di una presenza e di un potere
troppo perfetti per cuori mortali,
presentimento di sublime nascita.
Breve permane in noi luce divina:
la beltà spirituale offre la vista
e di passione abbiglia la Materia
e in un attimo scioglie eternità.
Qual anima alle soglie della nascita
che unisce il mortal tempo al Senzatempo,
scintilla di deità celata in zolla,
svanire in piani inconsci del suo lustro,
tal transitorio ardor di fuoco magico
si dissolse nel chiaro d’ogni giorno.
Cessò il messaggio e svanì messaggera.
L’uno richiamo, il solingo potere,
trasse in qualche remoto mondo arcano
tinta e prodigio del raggio superno:
gli occhi distolse lei dal perituro.
La sua natura, oltremisura bella,
non poté avvincere gli occhi del tempo;
di realtà troppo mistica allo spazio,
il cielo espulse il suo corpo di gloria:
incanto e rarità oltre non vissero.
Era la luce ordinaria del giorno.
Da tregua alla fatica svincolato,
di nuovo il rombo del ritmo di vita
riprese il ciclo del cercare cieco.
Tutti correvano ai propri atti fissi;
le miriadi fra i rami e nella gleba
seguirono l’impulso dell’istante
e, guida qui con la sua mente incerta,
l’unico a sceverare l’avvenire,
l’uomo prese il fardello del suo fato.
Savitri pure si svegliò fra quanti
all’appello brillante s’affrettavano
e, presi al laccio di mere apparenze,
un’effimera gioia reclamavano.
Pari all’eternità da cui giungeva,
mai l’adescarono tali lusinghe;
potenza estranea nel terreno umano,
non rispondeva l’Ospite incarnato.
Il richiamo che desta l’intelletto
al suo avido moto variegato
tingendo l’illusione della brama,
vibrò in cuor suo qual dolce nota aliena.
Non la irretiva il messaggio del tempo.
In lei era l’angoscia degli dèi
nella nostra umana forma effimera,
l’immortale avvinto al perituro.
La sua gioia d’un tempo, oltrenatura,
l’oro celeste non poté serbare
né una base su questa terra labile.
Nel temporale abisso segregata,
l’angusta vita rinnegò il potere,
quel fiero e conscio espandersi e la gioia
da lei portati nella forma umana,
gioia di un’anima che sposa tutte,
chiave di porte fiammanti dell’estasi.
Linfa di brama e pianto chiede il suolo
che nega il dono d’immortale ebbrezza:
alla figlia dell’infinito offrì
fior-di-passione d’amore e condanna.
Vano luceva ormai il sacrificio.
Prodiga della sua ricca deità
si donò all’uomo in essenza e natura,
per radicarvi il suo più vasto sé
e nella loro vita acclimatarlo,
trapianto d’infinito nel mortale.
Restìa al cambio è la terrea natura;
mal sopporta, il mortale, eternità:
teme l’alta divina intolleranza
di quell’assalto d’etere e di fuoco.
Protesta contro la gioia perfetta,
quasi con odio respinge la luce;
trema alla nuda potenza del Vero
e al dolce nerbo del tono assoluto.
Legge d’abisso infliggendo alle cime,
inzacchera i celesti messaggeri:
le sue infime spine pone a scudo
del salvifico tocco della Grazia;
paga i figli di Dio con morte e pena.
Quali lampi di gloria sulla terra,
nell’ignoranza i loro lumi scemano,
traditi, il loro bene volto in male,
la croce in dono a chi offrì la corona,
di loro resta solo un Nome splendido.
Un fuoco giunse, toccò i cuori e stinse;
pochi han colto la fiamma per evolversi.
Troppo altra dal mondo per salvare,
la sua mole non regge un petto ignaro
il cui baratro erutta un diro fiotto,
sua parte di caduta, lotta, strazio.
Vivere in pena, affrontare la morte,
mortale fato l’Immortale assunse.
Ghermita nei grovigli del destino,
in attesa dell’ora del suo scontro,
bandita dalla propria innata gioia,
vestita a lutto di terrestre vita,
celandosi perfino a quanti amava,
la sua deità fu più grande da umana.
Un cupo presagire la estraniava
da quanti lei fece base e stella:
magnanima, taceva rischio e pena,
in sé serbando il dolore a venire.
Simile a chi, assistendo dei ciechi,
porta il fardello d’una specie ignara,
nutrendo il suo nemico col suo cuore,
ignoti l’atto e il fatto che affrontava,
senz’aiuto paventa, freme, osa.
L’alba prevista e fatale era giunta,
in un giorno che parve uguali agli altri.
La Natura procede nel suo viaggio
incurante di vite e anime infrante;
si lascia dietro i caduti e procede:
l’uomo e Dio sono i soli a percepirlo.
Perfino in questo istante di afflizione,
tragico incontro con morte e terrore,
non un grido o un lamento le sortì;
a nessuno svelò il proprio strazio:
calmo il suo volto, muto di coraggio.
Solo il suo sé esterno soffre e lotta;
semidivina la sua parte umana:
spirito aperto allo Spirito in tutto,
natura volta all’intera Natura.
Sola, in se stessa, reggeva ogni cosa;
dentro di sé portava il mondo intero:
dal cosmico tormento il suo tormento,
dalla cosmica forza la sua forza;
suo della Madre universa l’amore.
Contro il male alla vita abbarbicato,
calamità suo distintivo segno,
mistica spada le sue pene rese.
Con mente solitaria e cuore immenso
si diresse al lavoro dell’Eterno.
Prima la vita non le urlava in petto,
nel grembo del torpore della terra,
inerte, nell’oblio abbandonata,
la vita riposava prona, inconscia,
tranquilla e ottusa come stella o pietra.
In faglia di silenzio fra due regni,
lei riposava lontana da affanni,
immemore del duolo di quaggiù.
Poi, vago, lento, un ricordo si mosse,
con un sospiro e la mano sul petto
lei riconobbe il dolore protratto,
profondo, quieto, antico, familiare,
senza sapere come o donde giunse.
Ancora spento rimase il pensiero:
stanchi, svogliati, i sensi della vita
quali operai senza paga di gioia;
la torcia sensoriale non ardeva;
non trovò, il cervello, il suo passato.
Solo terrestrità serbava il calco.
Ma infine si destò, col peso cosmico.
Alla muta chiamata del suo corpo
l’alato forte spirito virò,
virò al giogo d’ignoranza e fato,
virò all’opre e all’affanno dei giorni,
rischiarando un sentiero fra quei sogni
nel rifluire dei mari del sonno.
La sua dimora percepì un influsso
e i vani della vita si riaccesero,
sul ricordo si aprirono le imposte
e s’accosto il pensiero alle sue porte.
Tutto tornò: Amore, Terra, Fato
la circondarono, antichi avversari,
colossi nell’arena della notte:
le deità nate dal tetro Incosciente
giunsero al duello e al tormento divino
e, fra le ombre del suo cuore in fiamme,
al centro cupo del conflitto atroce,
guardiano dell’abisso sconsolato,
della lunga agonia del globo erede,
il volto in pietra del dio-di-Dolore
fissò lo spazio coi suoi occhi vuoti
scorgendo immensa pena, mai l’intento.
Della propria deità spietata afflitto,
legata al trono, attendeva deluso
quel pianto-offerta che lei mai versò.
Tornò l’intero problema delle ore.
Il sacrificio di dolore e brama
offerto dalla Terra all’Immortale
ricominciò sotto la Mano eterna.
Desta, la marcia d’istanti lei resse
e osservò il mondo dal verde sorriso
e udì il grido ignorante dei viventi.
Fra i rumori consueti, in quella scena,
l’anima sua s’oppose a Tempo e Fato.
Immota in sé, raccoglieva le forze.
Quel giorno Satyavan sarebbe morto.
[libera traduzione in endecasillabi
realizzata da Tommaso Iorco]