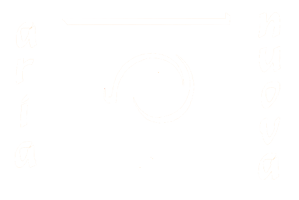Tradurre Sri Aurobindo
(a cura del team di traduttori
aria nuova edizioni)

Tradurre i libri di Sri Aurobindo non è un’impresa facile; e, avendo in programma un paio di collane — una dedicata alla sua poesia, una alla sua prosa — qualche chiarimento preliminare ci pare opportuno e doveroso.
In merito alle traduzioni dei testi poetici di Sri Aurobindo (comprendenti la poesia lirica, drammatica, ed epica) noi ci ripromettiamo di tradurre in poesia italiana, nonché di apporre sempre il TESTO ORIGINALE A FRONTE. Due particolari, questi, che consideriamo di particolare importanza. L’ideale, per noi, consisterà nel cercare di trasfondere nella traduzione l’originale alito di vita, riaccendervi l’ispirazione da cui è scaturita, conferirle quella forma che è parte essenziale d’ogni opera d’arte — in una parola, ricrearla. Con la costante possibilità, da parte del lettore, di confrontarla con l’originale.
Sul problema della traduzione, già Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) si pronunciò. Respingendo la possibilità di studiare e comprendere a fondo una lingua straniera sulla base di traduzioni in quanto, scrive, si perderebbe «il nocciolo della loro forza, il colorito, lo splendore della schiettezza, il loro sonante ritmo», trovò la risposta nella necessità di leggere nella lingua originale ogni spirito che in quella lingua si sia espresso: «Così mi sollevo a lui e dò alla mia anima la vastità di ogni clima». Per Herder, l’anima umana è «un individuo nel regno degli spiriti, che sente secondo la sua costituzione singolare», è una «particolarità viva» che si manifesta «dall’intero fondo oscuro della nostra anima, nella cui imperscrutabile profondità dormono forze ignote», cosicché si può dire che «noi non conosciamo nemmeno noi stessi e solo a istanti, come in sogno, cogliamo qualche tratto della nostra vita profonda». Chi studiasse una personalità dovrà allora «spiare gli istanti in cui l’anima si spoglia e si offre».
Qualcosa di analogo avviene per la poesia che, nei suoi momenti più genuini e ispirati, è la voce stessa dell’essere psichico o dell’essere centrale (nell’eccezione conferita da Sri Aurobindo, corrispondente ai termini sanscriti antarâtman ejivâtman).
La traduzione si colloca in questa prospettiva come un tentativo — sempre approssimativo — di trasferire in altra lingua qualche riflesso della bellezza dell’originale. E siccome in poesia la funzione della parola è quella di trasmettere una rivelazione, o una visione della realtà altrimenti inesprimibile, risulta chiaro che, pur di ottenere immagini equivalenti (ossia ugualmente efficaci a stimolare percezioni maggiormente intuitive che riconducano a tale rivelazione), talvolta potrà rivelarsi necessario variare alcune parole, rispetto alla presunta “traduzione letterale”, e ciò proprio al fine di seguire per quanto possibile il flusso dell’ispirazione originaria. Ma ciò non significa in alcun modo stravolgere il testo originale, anzi, tutt’altro. Manomettere qua e là, modificare certe gradazioni di tinte con toni ora più delicati ora più accesi, sbiadire o colorare eccessivamente le immagini, sfigura e guasta lo spirito del dettato poetico. Perciò saremo guidati, sempre e innanzitutto, da un atteggiamento di estremo rispetto e fedeltà nei confronti dell’originale. Ma è una fedeltà interiore, organica, vasta e fluida, quella che noi cerchiamo, e non una superficiale e meccanica pervicacia procedente su rigidi schemi fissi. Volendo fornire un esempio quasi paradossale, è così che Vincenzo Monti ci ha consegnato la sua bella traduzione in endecasillabi dell’Iliade, che è sopravvissuta a ben più rigorose traduzioni realizzate da insigni grecisti (d’altra parte, come faceva notare Gabriel Germain nel suo bel saggio su Omero, le traduzioni omeriche contemporanee, realizzate da studiosi anziché da poeti, rappresentano un percorso da non seguire nel futuro, giacché conduce a una traduzione del tutto priva d’ampiezza, per nulla fluida, deficiente nel ritmo). Esempio quasi paradossale, dicevamo, per il fatto che Vincenzo Monti non conosceva il greco, e quindi non poté gustare direttamente la mirabile vibrazione del verbo omerico — a ciò supplendo con la propria immaginazione creativa, unita all’alta qualità poetica raggiunta dalla sua abilità di traduttore.
Una traduzione degna di tale nome, dovrebbe creare nella propria lingua i valori intrinseci che l’Autore ha inteso esprimere. In pratica il traduttore diventa egli stesso autore, perché compie il “miracolo linguistico” di fornire quasi la stessa visione scrivendo — nella fattispecie — in un italiano che esalti, senza mai tradire, lo spirito che emana dagli scritti di Sri Aurobindo.
La prosa richiede poi un discorso ancora più articolato. In primo luogo, Sri Aurobindo, anche quando scrive in prosa, è sempre animato dal soffio della poesia, perciò leggerlo in originale è un vero godimento estetico e insieme intellettuale; il rischio, per un traduttore poco incline alla poesia, è quello di trasformare i fluenti, mirabili, ampi periodi di Sri Aurobindo, dove ogni parola pare indispensabile e apre alla meraviglia, in tediose trattazioni ipercerebrali, passi monotoni e inutilmente tortuosi — mentre in realtà, al contrario, tutto venne scritto nel più completo silenzio mentale, ricevendo l’ispirazione dall’alto e riversandola direttamente nella coscienza materiale, evitando così ogni deformazione.
Oltretutto, Sri Aurobindo apporta alcune importanti innovazioni nella lingua inglese. Il suo stile personalissimo è riscontrabile fin nella struttura sintattica, magicamente libera dai limiti e le pesantezze dell’idioma anglosassone. È un inglese straordinariamente fluido e scorrevole, quello di Sri Aurobindo, con un ritmo ampio e vigoroso (di fronte al quale non si può che restare in un silenzio ammirato, sbigottiti e deliziati), e al tempo stesso estremamente preciso e intellettualmente raffinato. Merito certamente, in larga parte, la sua profonda conoscenza del greco e del latino, ma anche del francese — tutte lingue che conosceva profondamente (come dimostrano i premi ottenuti a Cambridge, durante gli anni giovanili di formazione) — e del tedesco. Non a caso alcuni estimatori — la poetessa cilena Gabriela Mistral (premio Nobel per la letteratura), per fare un esempio — ponevano gli scritti in prosa di Sri Aurobindo in relazione (quanto a precisione e consequenzialità delle argomentazioni trattate) ai più grandi filosofi greci e tedeschi, o ai più acuti intellettuali francesi.
Per la prosa, in sintesi, sarà nostra massima cura cercare sempre di mantenere, per quanto sarà possibile, l’afflato poetico presente nell’originale, unitamente alla mirabile consequenzialità — illuminante giacché sovrarazionale — delle varie trattazioni.
Sri Aurobindo, fra le altre cose, è stato indubbiamente un genio letterario e poetico, e sapeva certamente quando fosse il caso di coniare termini nuovi per descrivere luoghi ed esperienze appartenenti a un continente ignoto, ancora tutto da esplorare.
Innumerevoli i fraintendimenti che possono ingenerarsi attraverso traduzioni ingenue e maldestre. C’è perfino chi non ha provato scrupolo alcuno nel tradurre pedestremente l’inglese race nel corrispondente italiano ‘razza’, creando un certo comprensibile imbarazzo tra i lettori. Mère, in francese, parlava di espèce, ed è in tal senso che va inteso il vocabolo inglese, assolutamente disgiunto, in Sri Aurobindo, da qualsivoglia aberrazione di stampo razziale o, peggio ancora, razzista (egli stesso precisa più volte l’accezione del termine e pone i necessari distinguo). Quindi, in italiano, tradurremo, senza alcun dubbio, con ‘specie’ o, a seconda dei casi, con ‘etnia’ (a meno che non si parli di the human race, ‘la razza umana’, il cui aggettivo in questo caso diventa plausibile, riferendosi all’intera specie, e non a qualche particolare gruppo morfologico umano).
Ma Sri Aurobindo ha pure coniato una cospicua serie di neologismi, per indicare alcuni livelli di coscienza e di esperienza spirituale che sono perlopiù insoliti nella cultura inglese (e, più in generale, nell’intera cultura europea post-celtica) — diversamente dal sanscrito che offre invece una ricca varietà di espressioni per indicare i numerosi dominî del sovrasensibile, pur nei suoi limiti.
Per colmare tale lacuna, Sri Aurobindo ha avuto dalla sua parte la struttura della lingua inglese che permette la creazione di parole composte, purtroppo difficilmente traducibili in italiano. Ma in questo ambito alcuni poeti italiani del Novecento ci vengono in aiuto, avendo coniato anch’essi un certo numero di parole composte (basti ricordare l’ “òccupa-cieli” di Arturo Onofri, o il “frondadargento” di Mario Novaro), dandoci in tal modo il coraggio di osare (cum grano salis, evidentemente).
Mère e Sri Aurobindo coniano ad esempio l’aggettivo supramental. In italiano possiamo tradurre in modo efficace e fedele con ‘sopramentale’, sebbene qualcuno si ostini a utilizzare l’orribile ‘supermentale’, che ci pare decisamente inadeguato, dato che può dare adito a innumerevoli fraintendimenti (oltre a non possedere la giusta shakti, la giusta forza verbale). Quando, per fare un esempio, nella lingua italiana si vuole identificare una strada che passa al di sopra di un’altra, parliamo di sopraelevata, e non di superelevata. Mentre, d’altra parte, se vogliamo designare una strada molto grande, parliamo giustamente di superstrada. Così, quando diciamo che un individuo è ‘superintelligente’, non intendiamo significare che si è elevato al di sopra dell’umana intelligenza, ma che ne ha raggiunto un apice. ‘Supermente’ fa pensare, per libera associazione, a una ‘mente super’, mentre il sostantivo the Supermind utilizzato da Sri Aurobindo intende designare un potere di coscienza ben al di sopra della mente. È il Potere della Coscienza-di-Verità creatrice della stessa mente, ma — proprio in virtù della sua intrinseca capacità creatrice — ALTRA COSA da essa. L'italiano, per nostra fortuna, ci permette di bandire ogni possibile dubbio ricorrendo al sostantivo “la sopramente”, chiaro e diretto, inequivocabile.
Il suffisso “super” può ingenerare fraintendimenti, ma in italiano il problema può essere facilmente risolto, a differenza di quanto accade in inglese. Per citare lo stesso Sri Aurobindo, in The Life Divine (I.XIV): «we have called this state of consciousness the Supermind; but the word is ambiguous since it may be taken in the sense of mind itself supereminent and lifted above ordinary mentality but not radically changed, or on the contrary it may bear the sense of all that is beyond mind and therefore assume a too extensive comprehensiveness which would bring in even the Ineffable itself».
Una delle più efficaci (e più semplici, al tempo stesso) spiegazioni del termine sopramentale, ci viene da Satprem: «Sri Aurobindo diceva “sopra-mentale”… ma bisognerebbe prendere il termine in modo del tutto fisico, proprio come il sole è sopra-acquatico» (Carnets d’une Apocalypse, 16.4.1985). Il sole, pur scaldando l’acqua con i suoi raggi, è di gran lunga al di sopra dell’acqua. La medesima relazione, per analogia, la si può ravvisare fra il sopramentale e la mente. Nel 2002, in quello splendido testo intitolato La philosophie de l’amour (che sarà l’ultimo suo scritto pubblicato in vita), Satprem scrive: «il “Sopramentale” non è una super-mente. Il Sopramentale è quanto risiede nel cuore stesso della cellula».
Talvolta, il sopramentale viene definito da Sri Aurobindo con il termine Gnosi (inglese Gnosis), vocabolo di derivazione greca significante letteralmente ‘conoscenza’ (e collegato perlopiù alla conoscenza mistica), proveniente dalla medesima radice da cui è sorto il termine sanscrito vijñâna che identifica per l’appunto il piano di coscienza sopramentale. È bene comunque tenere presente che l’utilizzo che ne fa Sri Aurobindo non presenta alcuna correlazione con i movimenti gnostici sorti in Europa. Ma lo stesso vijñâna viene usato nel sanscrito classico con valenze assai più ristrette rispetto alle accezioni vediche e upanishadiche: Shamkara e alcune linee di pensiero buddhista, infatti, lo utilizzano perlopiù come sinonimo di intelletto.
Più difficile risulta poi la traduzione di termini quali Overmind (e il suo aggettivo sostantivato Overmental), Overhead, Overman, Superman, Oversoul, surrender e altri ancora. Per la maggior parte di essi, siamo facilitati dai corrispondenti che Mère aveva scelto in francese, che possono aiutarci a trovare le migliori soluzioni anche in italiano. Così, Overmind — termine che designa la più alta coscienza mentale possibile, margine ultimo prima di sboccare oltre, nella coscienza sopramentale — viene reso da Mère surmental, e in italiano traduciamo ‘surmentale’ (forse un po’ forzato, ma non privo di fascinazione, sulla linea di termini italiani quali surclassare, surriscaldare, surrene, surgelare, surplus, surreale — inoltre, essendo un neologismo di per sé difficile da connotare in modo rigido, scoraggia i lettori ad associarvi meccanicamente idee preconcette); è comunque da aggiungere che il suffisso “sur” è entrato da parecchio tempo nella lingua italiana: già il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani alla voce SUR diceva: «lo stesso che Su, e la R è aggiunta sol per togliere la cacofonia dinanzi a vocale».
Superman e supramental being, francese être supramental, italiano ‘essere sopramentale’ o, in alternativa, ‘oltreuomo’ (i vecchi traduttori si ostinano a tradurre ‘superuomo’, termine che ha assunto connotazioni talmente fuorvianti e terribili che perfino gli ultimi traduttori di Nietzsche oggi hanno una decisa e comprensibile reticenza a utilizzare). Overman, francese surhomme, italiano ‘dopouomo’, designa il passaggio di transizione tra l’uomo e l’essere sopramentale. Esiste infatti una differenza essenziale fra ciò che è ‘transumano’, ovvero un umano di transizione, e il ‘postumano’, il quale è un essere completamente nuovo, che non ha più nulla di umano e che appartiene a una nuova specie.
Surrender, francese don de soi, italiano ‘dono-di-sé’, indicante quel moto di assoluto e fiducioso abbandono, per nulla inerte ma vivo e consenziente — è la resa totale e incondizionata del sé più basso al vero e più alto Sé. Overhead, a quel che ci risulta, non capitò mai a Mère di tradurre, e noi abbiamo deciso di adottare ‘ispirato dall’alto’ (in relazione al fatto che lo si usa per designare la poesia di origine ispirata, o rivelata — Overhead poetry, ‘poesia ispirata dall’alto’ — overhead, letteralmente, sarebbe ciò che sta ‘al di sopra della testa’, ovvero in quello spazio libero e radioso sede dell’intuizione, di cui si parla nella tradizione tantrica come del sahasrâra, il mitico ‘loto dai mille petali’). Anche Oversoul non sappiamo come Mère lo tradusse, comunque in italiano viene reso assai agevolmente con ‘Superanima’, a indicare il Sé cosmico che sostiene e guida il gioco universale, riflesso del Divino Artista, contenente in sé ogni anima individuata.
Vi sono poi termini quali Inconscient, Nescient, Subconscient, Subliminal, Superconscient, che poco hanno a che fare con le associazioni date dalla moderna psicanalisi, pertanto meritano anch’essi una breve disamina.
Incoscient lo traduciamo con ‘l’Incosciente’ (anche per distinguerlo dall’inconscio freudiano, con il quale ha ben poco a che fare); generalmente ‘incosciente’ viene usato come equivalente di tutto ciò che non è conscio, mentre per Sri Aurobindo designa uno stato di coscienza (l’articolo the infatti, negli scritti di Sri Aurobindo, precede sempre il termine Inconscient) assorto in sé in una sorta di trance o di oblio (non necessariamente volontario).
Subconscient, ovvero ‘il subcosciente’, rappresenta quella zona sommersa del nostro essere, del tutto priva di pensiero coerente o cosciente, nella quale vengono immagazzinate alla rinfusa tutte le impressioni (sensoriali o d’altra natura) che la nostra coscienza di veglia riceve dall’esterno.
Subliminal, ‘il subliminale’, è una zona che non si trova propriamente al di sotto, come il subcosciente, ma — per così dire — dietro la coscienza di veglia, e possiede capacità assai più ampie rispetto alla mente, al vitale e al corpo fisico di superficie. È, dunque, una coscienza più sviluppata e più vasta rispetto al nostro ordinario stato di coscienza.
Superconscient, ‘la sopracoscienza’, racchiude i piani superiori del nostro essere, attualmente al di sopra della coscienza umana ordinaria.
Nescient, ‘il nesciente’, generalmente rappresenta uno stato di ignoranza totale o, meglio, di non-conoscenza, derivando dal latino ne-, ‘non’, e scire, ‘conoscere’. Ma il Nesciente rappresenta anche, per Sri Aurobindo, uno stato in cui l’Essere si è completamente occultato o velato, involuto alla base dell’intera manifestazione cosmica.
Nature, la Natura, è — nella visione di Sri Aurobindo — una Forza universale e universalmente cosciente, una vera e propria emanazione della Grande Madre di tutto e al di là di tutto. Pertanto, è quasi sempre indicata con la maiuscola.
Infine, vi sono un certo numero di termini presi direttamente dal sanscrito, che ormai sono entrati nel novero dei vocaboli delle lingue europee: karma, avatara, mantra, yoga, prana, e simili, tutte parole che i dizionari italiani più recenti hanno ormai inglobato.
[Ci sarebbe poi da discutere sull’evoluzione stessa della terminologia all’interno degli scritti di Sri Aurobindo (in connessione, ad esempio, con l’utilizzo della parola ‘psichico’, oppure nel designare i vari gradi della coscienza sopramentale), tuttavia, per fare ciò, dovremmo entrare in una discussione molto tecnica che allo stato attuale delle cose ci pare oziosa. Al momento opportuno vi ritorneremo certamente con un articolo specifico.]
Questi dunque i criteri di massima che abbiamo seguito, al fine di dare una struttura il più possibile unitaria, viva e fedele alle traduzioni di Sri Aurobindo che ci proponiamo di pubblicare nel corso dei prossimi anni. Qualche nota a margine, laddove necessaria, aiuterà a chiarire, unitamente a un dizionarietto di termini sanscriti. Infine, la possibilità di comunicare direttamente con i lettori, tramite uno strumento rapido ed efficace quale quello offerto da internet, ci permette di confrontarci con quanti vorranno inviarci suggerimenti o consigli, dando forse in tal modo un più appropriato utilizzo alle abusate reti informatiche (benché ci paia comunque giusta la totale libertà — offerta pressoché a chiunque — di pubblicarvi qualunque cosa).
Le regole pratiche, i chiarimenti preliminari, in vista di una traduzione molto impegnativa come quella di un libro di Sri Aurobindo, sono sicuramente indispensabili, convenienti, fondamentali. Bisogna tuttavia aspirare anche a qualcosa che chiameremmo ‘ispirazione’ più sottile. Convinti che non solo i poeti ne abbiamo bisogno (Cantami o Diva…) ma anche, in certa misura, i traduttori. Per questo può tornare utile — oltre che sicuramente interessante — ripercorrere alcune rivelazioni, che possiamo anche raccogliere in forma di consigli o suggerimenti, di una straordinaria traduttrice che dell’Autore è la coscienza gemella – se così si può dire. Ci riferiamo, per chi non lo sapesse, a Mère. È peraltro ovvio che, traducendo Sri Aurobindo in italiano dall’originale inglese, terremo in massimo conto le eventuali traduzioni realizzate da Mère, in particolar modo laddove alcuni passaggi dovessero mostrarsi controversi e di difficile trasposizione.
In una conversazione con Satprem dell’8 ottobre 1960 (Agenda, vol. I, pag. 450) Mère parla della difficoltà di tradurre i libri di Sri Aurobindo: si riferiva, in particolare, alla disposizione delle parole. «Sento con grande chiarezza — diceva — che Sri Aurobindo ha messo la tal parola a tal posto perché non poteva essere altro che così — sta qui tutta la difficoltà del tradurre».
Mère traduceva dall’inglese al francese e si rendeva bene conto di come cambiasse fra le due lingue la disposizione delle parole. Se in entrambe il posto dell’avverbio, per esempio, è di un’importanza fondamentale per la precisione del senso dell’intera frase, in genere il posto non è lo stesso. Sarebbe facile se fosse l’esatto contrario; ma non è il contrario esatto. Ancora, per quanto riguarda una serie di aggettivi qualificativi o di un’enumerazione: in inglese, generalmente, viene prima la parola più importante; in francese succede generalmente il contrario; ma non è sempre così.
Anche gli esempi presi in considerazione confermano, dunque, che «il genio di una lingua non è uguale a quello di nessun’altra». E nel passare da una lingua a un’altra, c’è sempre «qualcosa che sfugge». Non accadrebbe se disponessimo di una lingua più perfetta, in grado di esprimere le ‘rivelazioni’ più alte, o più sottili, quelle che Sri Aurobindo chiamava, appunto, rivelazioni. Mère dice che queste le arrivavano «ora in una lingua, ora in un’altra»; ciò non dipendeva dallo stato di coscienza in cui si trovava, ma «da quello che bisogna dire».
«La nostra lingua è povera». Lo diceva non a proposito di questa o quella lingua in particolare, ma riferendosi alla lingua umana. Il sanscrito — dice ancora Mère — era molto meglio: è una lingua molto più completa e molto più sottile. Le lingue moderne invece sono artificiali, superficiali, intellettuali: «spezzettano tutto e tolgono alle parole la luce che c’è dentro».
«Il sanscrito era una lingua molto più fluida, uno strumento migliore per far passare una luce più… globale, più comprensiva, con più cose dentro. Invece nelle lingue moderne è come se tutto venisse passato al setaccio e ridotto a pezzetti». Così diventa inevitabile cercare di rimettere insieme i pezzettini. Anche se «una gran parte va sprecata».
Mère dubitava anche che «lo spirito moderno così com’è oggi» fosse in grado di «afferrare l’integrità del sanscrito». L’abitudine a spezzettare tutto rischia di frantumare anche la lingua sanscrita.
«Ci vorrebbe una nuova lingua» — diceva perciò Mère. Non un esperanto qualsiasi, ma una lingua capace di esprimere «i suoni che sgorgano di lassù».
«Bisogna captare IL suono. Ci dev’essere un suono all’origine di tutte le lingue… Poterlo cogliere e proiettare… Farlo vibrare: infatti, mica vibra allo stesso modo lassù e quaggiù.
Sarebbe un lavoro interessante.
Dare un potere alle parole — un potere di espressione. Sì, le parole dovrebbero avere un senso in se stesse!».
Alla fine di una lunga conversazione datata 31 gennaio 1961 (Agenda, vol. II, pag. 69) Mère parla della sua traduzione della Sintesi degli Yoga e di un’esperienza avuta in proposito. Dopo un certo periodo di pausa, aveva ripreso la traduzione qualche giorno prima: «Di colpo, mi sono accorta che vedevo le cose in modo completamente diverso!». Era cambiata «la posizione del mio lavoro di traduzione nei confronti del testo». Aveva ripreso l’ultima frase tradotta e la frase corrispondente del testo originale e, d’impulso, ma con la massima naturalezza, aveva corretto tutto. Si era detta: “ma certo, è così”. Intuendo che «la posizione era completamente un’altra».
Rileggendola, per quanto ritenesse che la traduzione non fosse ancora perfetta, aveva avuto la certezza di aver superato lo stadio precedente, quello «in cui uno cerca di trovare una corrispondenza con quello che sta traducendo», vale a dire un’espressione appropriata che sia abbastanza fedele all’originale. Non era più così. «Adesso è come se la traduzione venisse da sola». Il testo originale inglese e il testo tradotto in francese le appaiono, dal punto di vista della lingua, «completamente diversi» e tuttavia, a volte, molto simili. Come spiegare alla mente razionale di un altro traduttore la cosa che Mère trovava «piuttosto interessante»?
Mère ricorda che a Sri Aurobindo piaceva moltissimo la struttura del francese e diceva che rendeva l’inglese «molto migliore, molto più chiaro e potente di quello basato sulla costruzione sassone»; per questo, scrivendo in inglese, ricorreva spesso, spontaneamente, alla struttura francese. In questo caso «la traduzione trova la propria strada da sola, con naturalezza». Come se fosse un testo scritto direttamente nella lingua di traduzione (il francese). Nel caso invece di un testo inglese basato sulla costruzione sassone, sembrava possibile solo trovare un equivalente. Così era prima. Adesso, il cambiamento fa dire a Mère che è «come se qualcosa pensasse al di sopra e dicesse: “così è inglese, mentre in francese è così!”».
Per lei era «tutto lì, chiaro».
Può un traduttore — in perfetta buona fede, convinto di voler lavorare onestamente per Sri Aurobindo e Mère — tradurre mettendo da parte la mente? Cioè senza cercare di capire in modo mentale? Intravediamo una sola possibilità: che il libro stesso sia un tramite. Si tratta di considerare il libro da tradurre (dato che qui si parla di libri scritti da Sri Aurobindo) come una voce o una testimonianza della coscienza sopramentale stessa, che riflette nella mente umana la sua luce. Occorre disporre la mente come uno specchio.
Il 30 gennaio 1963 (Agenda, vol. IV, pag. 43) Mère comunica a Satprem di aver concluso la traduzione della Sintesi degli Yoga e di aver cominciato a tradurre Savitri: «Come mi aspettavo, è un’esperienza piuttosto interessante». Aveva già notato, quando leggeva, che c’era una sorta di «comprensione assoluta», senza ombra di dubbio a proposito di un significato o un altro: «È così. Viene e s’impone». Si era perciò detta che quando lo avrebbe tradotto sarebbe venuto allo stesso modo. «Ed è stato proprio così. Prendo il testo riga per riga, verso per verso, con la decisione (impersonale) di tradurre verso dopo verso, senza la minima preoccupazione letteraria, ma dando al testo l’espressione più chiara possibile di quel che intende Sri Aurobindo». E la cosa veniva in modo assoluto e positivo. Proprio perché metteva da parte «quella benedetta mente sempre esitante», che sembra quasi procedere per dubbi, o per catene inconcludenti di dubbi.
Nella stessa conversazione Mère parlava della «confusione fra presente e futuro» che si pone alla ragione esteriore. Anch’essa una cosa voluta. «Sembra che ogni cosa si svolga in un altro modo». C’erano inoltre cose che non le era facile sapere: la letteratura moderna, le regole spiegate dallo stesso Sri Aurobindo, la pronuncia inglese purissima, la possibilità di trasferire la regola a un’altra lingua. E un’affermazione preziosa, detta en passant: «per me tutto sta nel ritmo e nel suono».
«A meno che le lingue non diventino più fluide a mano a mano che il corpo e la mente si fanno più plastici».
Tornando su quella «sensazione di assoluto» cercava di entrare nella mentalità dei letterati, chiedendosi «che cosa proporrebbero, loro?». Fa un esempio di quell’assoluto citando il verso The clamours of human plane (‘il chiasso del piano umano’). C’era stato un divieto assoluto riguardo alla possibilità di tradurre con ‘clamori’. “Non è clamore, è chiasso”. «E non era un’opposizione fra una parola e l’altra, non si trattava delle parole, era il PENSIERO delle parole, il SENSO delle parole».
Mère non escludeva che potesse essere il caso di consultare un buon dizionario. Ma con la paura che non si trovi niente in nessun dizionario. Dato che i dizionari «sono pessimi…creano un’atmosfera di grande oscurità, intorbidano l’atmosfera». Anche la memoria (l’armadio) delle parole le sembra inaffidabile: «la parola non viene… non le trovo… sento che ci dev’essere una parola, ma vengono un sacco di sostituti che non valgono niente».
Non resta che tentare di raggiungere «quell’altra sensazione» dove sparisce «quella specie di movimento che facciamo sempre con tutto, con tutte le parole che vengono»: cercare e — se si riesce — afferrare qualcosa. La sensazione della SOLA COSA che esiste al mondo, rispetto alla quale «tutto il resto è rumore e basta».
Un altro filone di ricerca che può risultare utilissimo nel rintracciare preziosi consigli che possano esserci d’aiuto nell’affrontare i vari problemi del tradurre, è lo stesso Sri Aurobindo a fornircelo, attraverso gli scambi epistolari con alcuni traduttori (citiamo anche un lungo articolo, che egli scrisse nel 1903, intitolato On Translating Kalidasa, anch’esso di indubbia utilità). Di particolare interesse in questo ambito (ma non solo in questo ambito, beninteso!), appare il carteggio privato con Dilip Kumar Roy (intitolato Letters to Dilip, tre volumi in corso di pubblicazione a cura di Sujata Nahar e del Mira Aditi Centre), un affermato musicista, all’epoca conosciuto in India e nel mondo intero come uno dei più sensibili e raffinati cantanti e compositori indiani, il quale si distinse — in un secondo tempo, grazie all’aiuto e alla guida di Mère e Sri Aurobindo — anche nella poesia e nella saggistica. Profondo conoscitore di diverse lingue, ricevette da Sri Aurobindo elogi assai lusinghieri (unitamente a consigli pratici) per le sue traduzioni in bengali dall’inglese, dal francese, dal tedesco, come pure dal bengali all’inglese.
Alla data 27 novembre 1931, troviamo una lettera che Sri Aurobindo scrive a Dilip, nella quale gli spiega che tradurre in modo «letterale, o comunque pedestremente testuale nei confronti dell’originale, impedisce di trovare la corrispondenza e l’espressione poetica complete». Che è quanto noi stessi abbiamo cercato di indicare all’inizio di questo nostro articolo: trasporre parola per parola, alla lettera, può essere fatale nei confronti del testo tradotto, giacché lo spirito viene quasi inevitabilmente perduto, o peggio ancora tradito, e perfino la forma non riesce a riflettere nulla dell’originale. La sola via percorribile, che ci permetta di ottenere risultati soddisfacenti, consiste perciò nel cercare di cogliere la corrispondenza interiore con lo spirito del testo che ci accingiamo a tradurre. E questo è stato il grande merito che Sri Aurobindo riconobbe al caro Dilip. Quando questi gli mostrò la traduzione in bengali di una sua poesia, la risposta fu oltremodo chiara; Dilip tradusse in modo molto fluido e, anziché limitarsi a trovare dei corrispondenti letterali delle varie parole inglesi utilizzate da Sri Aurobindo nella propria poesia, cercò di dare il senso dei versi e di ogni singola parola attraverso un geniale utilizzo del bengali (ma, per scrupolo, indicò pure, in calce alla propria traduzione, alcuni vocaboli bengali più letterali). Il giudizio di Sri Aurobindo è per noi utilissimo e prezioso: «La sua traduzione è ammirevole. Mi piace molto e apprezzo pienamente la bellezza della frase che lei ha saputo trovare nel tradurre la mia — è di gran lunga migliore e più vicina alla forza e allo spirito dell’originale delle varianti puramente letterali da lei citate» (lettera del 1932 priva di una data precisa). Questa è dunque, per noi, la strada da percorrere.
Certo, si può legittimamente obiettare che, traducendo in questo modo, si può correre il grave rischio di fraintendere o deformare lo spirito originario del testo, tuttavia tale errore — a ben vedere — può avvenire comunque, e il traduttore deve avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, anziché lavarsi ipocritamente le mani col pretesto di avere pedissequamente fornito per ogni vocabolo della lingua tradotta il suo esatto corrispondente nella lingua della traduzione.
Tradurre in modo fedele, in definitiva, significa trasporre con infinita arguzia e con estrema passione — intelligenza impersonale da un lato, coinvolgimento personale e creativo dall’altro, come le due ali per un volo equilibrato e sicuro nel firmamento della traduzione. Inoltre, noi riteniamo che non si possano tradurre adeguatamente (vale a dire con la giusta sensibilità e proprietà di linguaggio) gli scritti di Sri Aurobindo se non ci si sente coinvolti nel vivo del Lavoro suo e di Mère. Impersonalità, infatti, non significa affatto freddezza e negativo distacco (o, peggio ancora, presunta superiorità). Per citare ancora un commento di Sri Aurobindo a Dilip: «lei ha saputo cogliere il senso riversandolo nella corrispondente forma poetica bengali con quella sua usuale combinazione di fedeltà e di felicità. Davvero molto ben fatto!» (30.12.1932).
Una cosa assolutamente da evitarsi, affrontando una qualsivoglia traduzione che possa definirsi ONESTA, è invece la nefasta attitudine (talora subconscia, e quindi assai più ardua da individuare e da correggere) di far corrispondere il testo da tradurre alle proprie idee, opinioni, idiosincrasie. La cosiddetta “traduzione libera” (espressione che volutamente noi non abbiamo voluto fin qui nemmeno prendere in considerazione) ci sembra una pura contraddizione in termini, tesa ad attribuire all’autore le nostre proprie convinzioni o il nostro personale gusto estetico, oppure ancora il nostro peculiare stile espressivo. L’obiettivo, per contro, dovrebbe essere quello di cercare di raggiungere un risultato che sia il più possibile vicino a quanto l’autore stesso avrebbe realizzato se si fosse espresso nella lingua in cui si intende tradurre. Affermazione enorme, sulla quale solo l’autore potrebbe pronunciarsi a suffragio della traduzione realizzata — come talvolta avvenne per l’appunto nel caso di Sri Aurobindo verso il suo traduttore in bengali Dilip. Noi non abbiamo certo la pretesa di considerare le nostre traduzioni perfette — lungi da noi dal ritenerci sterili o levigati manovali della tecnica traduttiva —, tuttavia ci sembra giusto mostrare la direzione verso la quale cerchiamo di muoverci. Volendo citare ancora dal carteggio privato di Dilip, a Sri Aurobindo, nel 1933, vennero mostrate due differenti traduzioni in bengali di un suo componimento lirico in inglese (scritto intorno agli anni 1905-1906), intitolata The Vedantin’s Prayer, una realizzata dallo stesso Dilip, l’altra da Khitish Sen (alias Udayshankar, celebratissimo danzatore e coreografo indiano dell’epoca). Ecco cosa Sri Aurobindo scrive in proposito in due differenti lettere: «La traduzione di Khitish Sen […] è resa in modo magnifico. Egli ha saputo rendere perfettamente il tono dell’originale, la sua austerità e l’elevatezza del pensiero e del sentimento, la severa sobrietà dell’espressione con tuttavia una certa massiva potenza — tutte cose che, per lo meno, io stesso ho cercato di evocare quando scrissi tale poesia, e sono tutti elementi indubbiamente e nobilmente presenti nella traduzione… Noto inoltre che egli ha saputo cogliere perfino l’esatta corrispondenza del movimento del verso… La traduzione di Khitish Sen è davvero un’eccellente traduzione poetica — e l’aspetto più significativo è che è riuscito a trasporla, eccezion fatta per uno o due passi, con estrema fedeltà». Passando poi a parlare della traduzione effettuata da Dilip, osserva: «Quella realizzata da lei è una bella traduzione poetica, ma concordo con quanto lei stesso dice sul fatto che l’altra [quella di Khitish] è ad un tempo poetica nel suo massimo grado e capace di rendere in modo più fedele il suo carattere peculiare». Insomma, quello che ci proponiamo non è un compito facile. Ma è, in ogni caso, una sfida oltremodo entusiasmante!
I meravigliosi dialoghi socratici trascritti da Platone sono, per comune parere degli studiosi, quanto di più fedele esista nel fornire un esempio di pressoché totale assenza di intromissione da parte della coscienza ricevente. Esempio tanto più lodevole quanto più in relazione a uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi (e, a ben vedere, proprio per ciò completamente disinteressato a mescolare le proprie personali considerazioni o interpretazioni). Certo, Platone non tradusse, bensì trascrisse, ma il suo esempio ci aiuta a individuare un altro elemento di fondamentale importanza per un traduttore ideale: l’impersonalità, ovvero la capacità di elevarsi al di sopra delle proprie idiosincrasie intellettuali, dei propri limiti personali.
Concludiamo facendo notare quanto una traduzione ben riuscita (vale a dire, ispirata e ben cesellata nella forma) possa essere considerata anch’essa — sia pur in forma minore — una creazione artistica. Come faceva notare lo stesso Sri Aurobindo, «la Bibbia inglese è una traduzione, eppure figura tra le più raffinate opere letterarie del mondo» (27.2.1936).
Pertanto, con i vostri gentili suggerimenti e i vostri preziosi consigli, ci auguriamo di riuscire — almeno in parte — nella difficile impresa che ci siamo decisi di intraprendere. Ci pare che il panorama editoriale italiano, ancora troppo chiuso in un miope provincialismo, ne abbia oltremodo bisogno. Senza peraltro dimenticare che, a differenza delle tradizionali case editrici, operanti a fini di lucro, noi offriamo l’intero nostro lavoro a livello di volontariato: dalle traduzioni, all’impaginazione grafica, alla revisione delle bozze, alla pubblicazione dei libri, tutto quanto viene svolto nel più genuino spirito di servizio, gratuitamente e a nostre spese. I proventi ottenuti dalla vendita dei nostri libri serviranno a permetterci di pubblicare successive edizioni. In questo modo, siamo persuasi che la qualità stessa della vibrazione dei libri realizzati sarà per forza di cose speciale.
Dicembre 2003