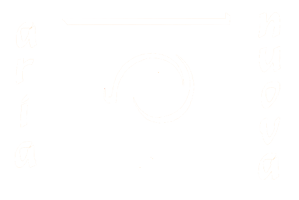L’endecasillabo
a cura del centro studi arya
Diciamo anzitutto che, senza alcun dubbio, l’endecasillabo è il verso più importante della tradizione poetica italiana.
È un endecasillabo un qualsiasi verso che abbia come ultima sillaba tonica (cioè accentata) la decima. Conterà quindi undici sillabe se l’uscita è piana (cioè, se alla sillaba accentata ne segue un’altra senza accento, come nella maggior parte delle parole italiane). Gli endecasillabi italiani sono quasi sempre “canonici”, hanno cioè accentata, oltre alla decima, almeno anche la 4° sillaba (in questo caso si parla di endecasillabo a minore) o la 6° (endecasillabo a maiore). Gli endecasillabi di Dante sono quasi tutti canonici, quelli di Petrarca sono tutti canonici.
Tra i versi della poesia italiana, l’endecasillabo è inoltre quello in cui le sedi degli accenti sono più varie. Per questa sua duttilità l’endecasillabo è il verso prediletto dei poeti italiani, nonché il più utilizzato. È il metro principe della nostra poesia e si trova in tutte le formazioni più importanti, come la ballata, la canzone, il sonetto, l’ottava, fin ad arrivare all’epica, come nel caso della traduzione di Ilion.
Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dal nome, è bene chiarire subito che la nota distintiva dell’endecasillabo non è il numero effettivo di sillabe, bensì il fatto che l’accento dell’ultima parola del verso cada sulla decima sillaba.
È errore comune dunque pensare che tutti gli endecasillabi debbano avere sempre e comunque undici sillabe. Ciò, se pure nella maggior parte dei casi è vero, non costituisce una regola. L’avere undici sillabe non è altro che la diretta conseguenza del fatto che la lingua italiana sia formata prevalentemente da parole piane, cioè che hanno l’accento sulla penultima sillaba.
Come già detto, nella sua più comune uscita piana esso è costituito da undici sillabe metriche:
«Mi ritrovái per una sélva oscúra»
(Dante, Inferno, I.2)
Nella sua uscita tronca sarà però formato da dieci sillabe metriche:
«Ciò che ’n grembo a Benáco star non può»
(Dante, Inferno, XX 74)
In quella sdrucciola invece da dodici:
«Ergasto mio, perché solingo e tácito»
(Sannazaro, Arcadia, 1).
Occorre inoltre considerare che, nel contare le sillabe di un verso, bisogna tener conto di alcuni fenomeni che interessano particolarmente il metro poetico e che si chiamano perciò ‘figure metriche’. Esse sono: l’elisione (o sinalefe), la dialefe, la sineresi.
L’elisione è la contrazione fra la vocale finale di una parola e l’iniziale della parola che segue. Due sillabe vengono così a formarne una sola.
La dialefe è invece il fenomeno contrario all’elisione e corrisponde in fonetica allo iato. Si verifica quando la vocale finale di una parola e l’iniziale dell’altra non si fondono (il più delle volte questo fenomeno è prodotto dalla presenza di un forte accento su una delle due vocali).
La sineresi consiste nella contrazione, cioè nella pronuncia in un’unica sillaba di due o più vocali consecutive appartenenti alla stessa parola ma a sillabe diverse).
La dieresi è il fenomeno contrario e consiste nella pronuncia distinta delle due vocali di un dittongo (può essere segnalata graficamente da un segno, costituito da una coppia di puntini — Dïana — oppure no — aere).
Non è escluso, come già ipotizzava Bembo, che all’origine dell’endecasillabo ci siano influenze provenzali e, come trova il critico Francesco D’Ovidio esistono «affinità con il décasyllabe, una derivazione dall’endecasillabo saffico attraverso la poesia mediolatina con la mediazione del trimetro giambico».
Per motivi legati alla sua genesi (l’endecasillabo nasce infatti dalla fusione di un quinario e di un settenario) e formalizzati già da Pietro Bembo, l’endecasillabo canonico prevede un accento secondario sulla quarta o sulla sesta sede; nel primo caso l’endecasillabo si definisce a minore (e il primo emistichio equivale a un quinario), nel secondo caso si definisce a maiore (e il primo emistichio equivale a un settenario).
La definizione degli accenti di un verso è spesso un concetto soggettivo; un verso può anche avere più accentazioni diverse a seconda della lettura che si vuol dare; di regola si tende a considerare atone le particelle più piccole come i pronomi, preposizioni, articoli e congiunzioni, quando non siano in posizione evidentemente marcata.
L’endecasillabo a maiore è generalmente considerato più solenne:
«Nel mezzo del cammin di nostra vita»
(Dante, Inferno, I.1)
Mentre l’endecasillabo a minore è più calmo pacato e intimista:
«Mi ritrovai per una selva oscura»
(Dante, Inferno, I.2)
Molto più raro il caso in cui non ci siano accenti rilevanti prima della sesta sillaba come in questo caso:
«de la trasfigurata mia persona.»
(Petrarca, Canzoniere, XXIII, 42)
Più raro ancora il caso in cui da un accento sulla prima si va subito all’accento sulla sesta:
«Sgombrimisi del petto ogni altra voglia.»
(Bembo, Asolani, 3 VIII.4)
Come in una composizione musicale il ritmo è una delle componenti fondamentali da cui deriva l’armonia musicale che caratterizza il verso. Data la ricchezza ritmica non esiste una classificazione universalmente riconosciuta che riesca a categorizzare tutti i tipi di ritmi che si possono dare ad un endecasillabo, tuttavia prendendo a prestito una terminologia proveniente dalla metrica classica, è possibile evidenziare alcuni tipi di versi a seconda del loro attacco definendoli giambici, dattilici e anapestici.
Si definiscono dal ritmo giambico quegli endecasillabi con accento sulla II, IV e VI sede:
«Al cór gentíl rempáira sempre amóre»
(Guido Guinizzelli)
Un endecasillabo così costruito ha entrambe le sedi principali toniche, anche per questo motivo è il ritmo più semplice e più comune nella poesia italiana. L’andamento giambico (àtona-tònica-àtona-tònica...) fornisce al verso un ritmo cantilenante e monotono. Questo ritmo era particolarmente adatto a componimenti che dovevano essere accompagnati da musica.
Tra i versi a minore si riconoscono quelli dal ritmo dattilico con accento sulla I IV VII X:
«fátta di gióco in figúra d’amóre»
(Guido Cavalcanti, Rime, XXX)
I poeti delle origini utilizzavano questo ritmo lento e discendente (tònica-àtona-àtona-tònica...) per dare al lettore una sensazione di solennità.
Tra i versi a maiore è possibile identificare quelli dal ritmo anapestico, con accento su III VI X:
«Se Mercé fosse amíca a’ miei disíri»
(Guido Cavalcanti, Rime, XV)
Il ritmo anapestico (àtona-àtona-tònica...) è ascendente e da un senso di maggiore scorrevolezza e velocità al verso.
Volendo trovare una regola generale potremmo dire che il ritmo del verso si fa più incalzante quanto più sono numerosi e ravvicinati e gli accenti fra loro; lo sfruttare abilmente gli accenti di un verso è parte fondamentale della sensibilità artistica di un autore.
Il punto che separa i due emistichi si definisce cesura. Se la cesura è particolarmente forte spezza il verso in due parti, ma mai una parola a metà.
Tutti gli endecasillabi hanno una cesura, che può venire o meno sottolineata durante la declamazione del verso.
Esistono vari tipi di cesura:
Si ha una “cesura maschile” quando cade dopo un verso tronco:
«Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori»
(Ariosto, Orlando Furioso, I.I.1)
Secondo la metrica canonica infatti (ma non è una regola ferrea), l’incontro di due accenti consecutivi (cavalièr àrme) è infatti possibile soltanto nel punto in cui il verso presenta una cesura, poiché l’incontro di due accenti rende obbligatoria una breve pausa per una corretta lettura.
La “cesura femminile” (o ‘italiana’) si verifica nel caso in cui l’accento cada su una parola piana. Dato che la cesura non tronca mai una parola, viene spostata alla fine della parola stessa:
«fu stabilita per lo loco santo»
(Dante, Inferno, II.22)
Tuttavia in italiano la cesura non è una regola matematica. È però buona norma sottolineare tale pausa metrica quando è in corrispondenza delle pause sintattiche (identificate dai segni di interpunzione), e quando è utilizzata volutamente ad hoc per creare un qualche tipo di effetto metrico.
Esistono una serie di endecasillabi “insoliti” che sono considerati canonici pur essendone al limite.
Un tipo di cesura molto particolare è la cesura epica reintrodotta da Giovanni Pascoli per i suoi endecasillabi epici sul calco del decasillabo francese (egli la reintrodusse per la sua traduzione della Chanson de Roland).
Tale verso, benché rientri in questa categoria, non è propriamente un endecasillabo. La sua forte cesura non permette in nessun caso la sinalefe, ed è caratterizzato da una forte pausa tra il primo e secondo emistichio.
Contrariamente a quanto succede nell’endecasillabo canonico, le ultime sillabe atone del primo emistichio non si contano nel computo del secondo indipendentemente se sia tronco, piano o addirittura sdrucciolo.
Esempio:
«ché pur a retro sempre il guida il suo remo»
(Monte Andrea, VI.96)
Di fatto perciò l’endecasillabo epico equivale alla semplice giustapposizione di un quinario e un settenario.
Un ultimo tipo di endecasillabo a metà fra il canonico e il non canonico è quello detto “crescente”. Grazie a questo espediente il verso riesce in qualche modo a rientrare nella categoria dei canonici pur essendone al limite. Un altro caso è quello in cui la sillaba atona del verso precedente va a colmare la sillaba mancante nel verso ipometro seguente: questa tecnica è stata ripresa dai crepuscolari, e poi anche da Eugenio Montale.
Esistono poi una serie di endecasillabi considerati “imperfetti” dai teorici. Non sono ammessi nella poesia classica tutti quei tipi di versi dove non è possibile riconoscere i due emistichi principali del quinario e del settenario; che abbiano cioè sia la quarta che la sesta sede atone. Gli endecasillabi di Dante sono quasi tutti canonici. Quelli di Petrarca e dei petrarchisti lo sono tutti. Endecasillabi non canonici si possono trovare nei primi esperimenti di poesia italiana (più di un caso nella Divina Commedia) e in alcuni poeti successivi (Pietro Aretino ad esempio).
Un esempio di endecasillabo con la quarta e la sesta atone, accentato sulla seconda e sull’ottava:
«la vipera che Melanesi accampa,»
(Dante, Purgatorio VIII.80)
Tra gli endecasillabi non canonici, i più comuni sono i cosiddetti “endecasillabi di quinta”, che presentano appunto la quinta sillaba tonica e sia la quarta che la sesta atone. Ecco un esempio di endecasillabo di quinta in Dante:
«vestito di novo d’un drappo nero»
(Dante, Rime, XXV.9)
Nel Settecento Paolo Rolli tentò di traspondere l'endecasillabo falecio dalla metrica classica. Ne uscì un quinario doppio, con uscita sdrucciola nel primo emistichio, e piana nel secondo:
«E ella, veggendolo cotanto saggio.»
(Anonimo, Il Bel Gherardino - Cantare, II.157)
Questo tipo di endecasillabo non è considerato canonico, ed è detto endecasillabo rolliano.