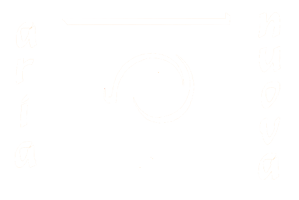Intervento di Tommaso Iorco
Ringrazio il prof. Solinas e il prof. Cognetti per questa loro introduzione, che costituisce la base di partenza ideale per entrare nel vivo dell’argomento.
Nel presentare il saggio rigvedico di Sri Aurobindo, vorrei partire da un interrogativo fondamentale, che poi è il medesimo che l’Autore stesso pone in apertura di questo testo: la tradizione rigvedica è realmente misterica, oppure allude a rituali meramente esteriori? Per dirla in altre parole, i rishi vedici erano dei veggenti ispirati, compositori di poesia mistica, attestante cioè esperienze spirituali, oppure erano dei semplici barbari adoratori di poteri personificati della natura quali il sole, il fuoco, il cielo, la terra, la pioggia, l’aurora, eccetera?
Solitamente, si tende a creare un abisso inconciliabile fra i Veda e le scritture a essi successive, le Upanishad, dette anche Vedanta o ‘parte conclusiva dei Veda’. I Veda vengono infatti considerati “karma-kânda”, trattazioni rituali, mentre le Upanishad sono considerate “jñâna-kânda”, trattazioni sapienziali, rappresentanti il primo sviluppo (o fra i primi sviluppi) dell’intelletto filosofico, speculativo. Tuttavia, questo non è l’atteggiamento degli stessi autori upanishadici, i quali accordavano anzi il più alto rispetto per il grado di realizzazione raggiunto dai loro predecessori vedici, citando spesso i Veda come autorità indiscussa in ambito spirituale. Il rishi vedico infatti era considerato il veggente — drashtâ — di una verità eterna. Verità occultata però da un fitto simbolismo, ancora chiaro (sia pure soltanto in parte) per i compositori delle Upanishad, oscuro e impenetrabile per i posteri. Ebbene, questo è esattamente il punto di partenza dal quale Sri Aurobindo ha preso le mosse in quella che è la sua maggiore opera di esegesi rigvedica (quantunque mai riveduta), scritta nei primi anni Dieci (quindi all’incirca un secolo fa), cercando di svelare il vero senso di tali misteri. Questo, dunque, cercheremo oggi di sintetizzare per sommi capi: il segreto dei Veda — o, meglio, il segreto dei Rg Veda che, come tutti sappiamo, è il più antico dei quattro Veda. Anticipo subito che non ci soffermeremo — né il prof. Bua né il sottoscritto — sul problema legato alla antichità dei Veda, vale a dire alla loro datazione. Nessuno ancora ha potuto stabilire con certezza la data di composizione di queste innodie; l’unica cosa di cui possiamo prendere atto, è che gli studiosi si trovano costretti, ogni qualvolta si trovano a effettuare approfondimenti in materia, a arretrare (talvolta anche sensibilmente) l’epoca di composizione del Rgveda, la cui datazione sembra perdersi davvero nella notte dei tempi.
Quello che invece possiamo affermare con certezza, è che verso il 500 avanti Cristo il celebre lessicografo Yâska, in quella sorta di enorme dizionario etimologico che porta il nome di Nirukta, parla di un triplice significato degli inni vedici — quasi come fossero tre strati geologici sovrapposti. Il livello più superficiale è rappresentato dal significato ritualistico, adhiyajña, legato alla celebrazione del sacrificio vedico; vi è poi un significato legato alla invocazione delle divinità vediche invocate, adhidaiva; e infine, il livello più profondo è costituito da un significato prettamente spirituale, adhiyâtma, il quale determina il vero valore dei Veda, a detta dello stesso Yâska (anche se poi questi non se ne occupa); i primi due significati sono dunque del tutto subordinati a questo terzo e più profondo livello di interpretazione. Ma, come si diceva, il senso spirituale è occultato da un fitto simbolismo che, per noi, uomini di tutt’altra epoca, risulta oltremodo difficile da decifrare anche solo nelle sue linee essenziali. Gli stesso veggenti rigvedici d’altronde parlano esplicitamente di «parole segrete, saggezze di veggenti che solo al veggente rivelano il loro senso»: ninyâ vacamsi kavyâni kavaye nivacanâ. Solo chi riceve esperienze analoghe a quelle descritte nei Veda può, per una sorta di affinità per l’appunto esperienziale, comprendere le folgoranti rivelazioni contenute nei suoi versi poetici. Ci troviamo pertanto di fronte a uno dei più grandi capolavori di poesia mistica dell’umanità, teso a attuare nell’uomo il risveglio della coscienza alla immortalità — amrtasya cetanam.
In questa ottica, essendo i tre significati cui allude Yâska strettamente interrelati, le stesse divinità invocate negli inni vedici presentano funzioni psicologiche e spirituali più o meno evidenti, la cui disamina può aiutarci nel compito intrapreso. Anche in questo specifico ambito credo sia meglio tralasciare la questione legata a un luogo comune che tende a etichettare le credenze vediche come politeiste; mi limito a ricordare che per i rishi vedici le varie divinità invocate sono aspetti e manifestazioni della Divinità unica — ekam sad —, come si può leggere in varie occasioni nel Rgveda: “l’Essere è UNO, i saggi ne parlano con vari nomi”, lo chiamano Indra, Vayu, Mâtarishvan, eccetera — ekam sad, viprâ bahudha vadanti.
Possiamo perciò partire da Agni, il dio del Fuoco, al quale sono indirizzati il maggior numero di inni rigvedici, e che vedremo presto essere il dio del Fuoco mistico. Egli infatti viene più volte indicato come marteshu amrta, “l’Immortale nei mortali”, ovvero il divino in noi, l’inviato (dûta), il messaggero che funge da ponte fra l’umano e il divino, collegando il mortale con l’Immortale; egli è “il guardiano luminoso della verità”, gopâm rtasya dîdivim; utilizzando un linguaggio più moderno potremmo definirlo l’Immanente, la coscienza divina involuta nella propria manifestazione, che risveglia l’incoscienza materiale a una sempre maggiore coscienza, permettendo al divenire cosmico di esprimere in modo progressivo le infinite potenzialità dell’Infinito, dell’Assoluto. Mi viene alla memoria una esortazione rigvedica di straordinaria forza, che va in questo stesso senso, dove il veggente indica all’umanità quel percorso di compimento e di superamento di sé in due distinte tappe, per così dire: innanzi tutto, occorre diventare degli esseri umani compiuti, manur bhava janayâ, integrando in sé quelle forze che compongono la nostra complessa personalità; successivamente, occorre andare oltre se stessi, superare l’umano e creare quella che viene definita una vera e propria ‘specie divina’, daivam janam. “Diventate l’essere umano, create la specie divina» — manur bhava janayâ, daivam janam.
Similmente, possiamo trovare negli inni rivolti al dio Indra, considerato la deità vedica più importante, alcune suggestioni psicologiche assai profonde. Indra, alla luce dell’interpretazione di Sri Aurobindo, è il dio della Mente divina, che trafigge con la sua folgore le tenebre dell’ignoranza, e i veggenti rigvedici lo paragonano a una montagna dalle molteplici balze, che il ricercatore della verità, lo scopritore della parola mistica, deve scalare in una ascesa progressiva fino a giungere alla sua sommità: brahmana tvâ shatakrata ud vamshamiva yemire. In un verso particolarmente pregnante — per la precisione si tratta di un emistichio — si dice addirittura che, cito letteralmente, “a mano a mano che si procede nella scalata, diventa chiaro il molto che resta ancora da raggiungere” in questa ascesa verso la verità ultima: yat sânoh sanum âruhat bhuri aspasta kartvam. Lo stesso sacrificio vedico viene sovente descritto come un viaggio: adhvara yajña, rtasya pantah, satyadharmânam adhvare.
Ma, se questa chiave interpretativa che Sri Aurobindo offre (ovviamente in modo ben più documentato e preciso di quanto sto facendo io) di Agni e di Indra non dovesse ancora convincerci, ebbene, possiamo prendere in esame una divinità — citata dal prof. Solinas nella sua introduzione — cui il veggente rigvedico indirizza parole difficilmente suscettibili di fraintendimenti: la dea Sarasvatî. Prendiamo come esempio un verso contenuto in uno dei primissimi sûkta (inni) del I Mandala del Rgveda, nel quale il rishi dice: maho arnah sarasvatî pra cetayati ketuna | dhiyo vishvâ virâjati — ebbene, qui non c’è nulla da interpretare, poiché il senso letterale del verso ci mostra in maniera chiara e inequivocabile la funzione psicologica della dea Sarasvatî. Tradotto nel modo più letterale possibile il verso dice: “Sarasvatî risveglia in noi il grande flusso per mezzo dei raggi, lei che illumina tutti i nostri pensieri”. Ovviamente, qui, il grande flusso (o il grande oceano, come talvolta è tradotto) non può essere l’acqua fisica, né i raggi possono essere raggi fisici, dato che il primo (il grande flusso) risveglia LA COSCIENZA — pracetayati — mentre i secondi (i raggi) illuminano tutti i nostri pensieri: dhiyo vishvâ virâjati. Solo i raggi dell’intuizione possono illuminare il pensiero. Riguardo poi al ‘grande flusso’ (maho arnah) o al ‘grande oceano’ che dir si voglia, il discorso si espande e si fa ancora più interessante. Si tratta infatti di una espressione assai ricorrente nel Rgveda, il quale distingue due grandi oceani: un oceano che sta in alto, l’oceano superiore dell’esistenza, maho arnah, per l’appunto, e un oceano che sta in basso, l’oceano inferiore, salilam apraketam. E quando le acque divine (âpo vicetasah) che, badate, sono ‘acque che sanno’, giacché i veggenti rigvedici dicono letteralmente che queste acque sono “conoscitrici della verità”, rtajña, ebbene, dicevo, quando queste acque divine vengono liberate, si dice che “scalano la mente (mano ruhânâh — espressione che peraltro ribadisce il simbolismo della montagna) e mostrano al ricercatore il cammino verso l’oceano in alto, upari samudra, ovvero l’oceano sovracosciente dell’esistenza. Per dirla in altri termini, sempre di estrazione rigvedica, l’intero esistente viene considerato una sfera unitaria, costituente un tutt’uno armonico, al cui interno esistono tuttavia alcune distinzioni pratiche. Innanzitutto, i rishi vedici distinguono due emisferi complementari: un emisfero superiore, parârdha, e un emisfero inferiore, aparârdha. Da notare anzitutto che il termine utilizzato per designare l’emisfero superiore è una parola composta formata da para e ardha, che significa sia meta suprema, sia metà superiore — potenza dei doppi sensi cui peraltro il sanscrito vedico abbonda, e che nel sanscrito classico diventerà una figura grammaticale ben definita che porta il nome di slesha. E questo emisfero superiore contiene in sé tre ‘mondi’, tre ‘dimore’ o, come diremmo noi oggi, tre piani di coscienza, cui non vengono dati nomi specifici, ma che corrispondono in tutto e per tutto a quanto nelle Upanishad viene definito sat-cit-ânanda: pura esistenza, pura coscienza, pura beatitudine assolute. Se ne parla anche nei Purâna, con altri nomi ancora: satya, tapah e janah. Anche l’emisfero inferiore ha tre distinti ‘mondi’, raggruppati nella celebre formula mistica bhûr bhuvar svar: bhûh è il piano materiale vero e proprio (corrispondente allo annakosha upanishadico), bhuvar e il piano vitale, rajas (il pranakosha vedantico), svar è il piano mentale (il manakosha delle Upanishad). Esiste inoltre, fra questi due emisferi, un ulteriore piano di coscienza che funge da collegamento fra quelli che in linguaggio moderno chiamiamo l’Essere e il Divenire, la realtà essenziale e la realtà fenomenica. Questo piano di coscienza nel simbolismo rigvedico è rappresentato dal dio Sûrya, il dio del sole mistico, sede della Luce divina che risiede ben al di sopra della mente (ed è per questo motivo che Sri Aurobindo conia il termine “sopramentale” per designare tale piano di coscienza, per ribadire fin dal nome che si tratta di un piano del tutto al di sopra della mente — talvolta egli parla anche di Gnosi, ma non nel senso assunto nello gnosticismo, bensì per una affinità linguistica fra il greco gnosis e il sanscrito vijñâna). Il dio Sûrya viene invocato nel Rgveda in una molteplicità di aspetti: è per esempio Pûshan, “l’accrescitore”, oppure Savitar, “l’illuminatore”… e proprio in questo aspetto di supremo illuminatore viene invocato in quello che è certamente il gâyatrî mantra più celebre: om tat savitur varenyam bhargo devasya dîmahi / dhiyo yo nah pracodayat, affinché illumini la mente e apporti quaggiù gli splendori della coscienza divina, risvegliando quello stesso sole che dimora involuto nella roccia dell’incosciente materiale — nei Veda infatti si parla di un “sole nero” (martanda), di un “sole nascosto nell’oscurità”:sûryam viveda tamasi kshiyantam. “Perfino nel sasso sei presente”, adrau cit asmâ, dice il cantore vedico riferendosi a Agni, il fuoco mistico, che ha propria dimora (sve dame) per l’appunto nel sole della divina gnosi sopramentale. E qui mi ricollego all’interessante accenno che il prof. Cognetti faceva a proposito della dicotomia fra Materia e Spirito che ha caratterizzato la nostra cultura per lungo tempo. Ci sono state, è vero, voci isolate, come Giordano Bruno, il quale è stato bruciato sul rogo dalla chiesa cattolica nel Seicento perché sosteneva (fra le altre cose) che anche la materia è Dio — annam brahma eva, per dirla con le Upanishad. In epoca più recente, Teilhard de Chardin parla della divinità della materia, nel suo Le milieu divin e altrove. Ebbene, per i veggenti vedici il fine della vita non era una trascendenza esclusivista, negatrice della vita stessa, ma al contrario un’ampia realizzazione progressiva poggiante sulla materia. Nessuna dicotomia fra Materia e Spirito, dunque, fra Essere e Divenire, fra aldilà e aldiquà, ma — al contrario — una vasta conciliazione di questi apparenti opposti. Ed è proprio questa conciliazione degli opposti che Sri Aurobindo porta alle sue estreme conseguenze, non solo da un punto di vista strettamente filosofico ma anche e soprattutto sul piano pratico, dando ad essa una attuazione del tutto concreta, attraverso il Lavoro di trasformazione suo e di Mère, la sua compagna, la sua Shakti. Devo dire a questo proposito che sono rimasto molto piacevolmente colpito dal fatto che il mondo accademico inizi a comprendere la portata di questi due Pionieri e che il prof. Cognetti in apertura abbia espresso un chiaro elogio alla figura di Mère e a quello straordinario documento di evoluzione sperimentale qual è l’Agenda di Mère.
Avviandomi in chiusura di questo mio intervento, vorrei ricordare che il rishi vedico distingue una serie di ‘nascite’ per l’essere umano. E questo ci ricollega a una delle prime citazioni che vi ho proposto oggi, dove il veggente rigvedico ammoniva tutti noi a diventare l’essere umano e a creare la specie divina: manur bhava janayâ, daivam janam. Ebbene, per diventare un essere umano compiuto occorre attraversare una serie di nascite. Innanzitutto, una prima nascita avviene in prthvî, vale a dire nella materia, quando assumiamo un corpo fisico. Vi è poi una seconda nascita nella ‘terra-di-mezzo’, antariksha rajas, costituita dal piano vitale: questa nascita ha inizio nell’età dell’infanzia, dell’adolescenza e poi della pubertà, quando iniziamo a prendere coscienza della complessiva delle pulsioni emotive e vitali dentro di noi, il nostro dinamismo volitivo, e giunge a compimento quando abbiamo effettuato una integrazione armonica con l’intera energia-di-vita che circola in noi. Viene quindi una terza nascita, purtroppo ancora poco comune nell’umanità nel suo insieme, nonostante la crescita della scolarizzazione: la nascita nella mente, dyauh, intesa in primo luogo come scoperta delle nostre capacità speculative di fronte ai grandi problemi dell’esistenza. Ma — e questa è la cosa meravigliosa — i Veda non considerano concluso qui il viaggio umano. Anche qualora l’essere umano riuscisse a giungere all’apice delle possibilità mentali, aprendosi ai raggi dell’intuizione divina, ebbene, c’è una ulteriore nascita: la nascita in quello che viene chiamato “un certo quarto”, turyam svid, che corrisponde all’entrata nel sole della coscienza-di-verità sopramentale, oltrepassando “le porte del sole”, sûryasya dvare. Ed è proprio questa entrata nel sole-di-verità che il mistico upanishadico esprime in quel mirabile verso contenuto nella Ishopanishad, che è una delle Upanishad più antiche, contenuta nel corpus vedico (nel Krishnayajurveda, per l’esattezza), dove viene descritta la visione di quella che è la forma più bella del sole, kalyânatamam, attestante il raggiungimento dell’unità con tutto l’esistente. Vorrei concludere proprio citandovi questo verso nell’originale, perché è veramente di una bellezza e di una precisione incomparabili, proclamando alla fine una delle grandi affermazioni (mahâkakya) delle Upanishad: so’ham, “io sono Lui”, attestando in questo modo l’unione mistica con il Divino: “quel Purusha che è qui e dappertutto, io sono” —pûshannekarshe yama sûrya prâjâpatya vyûha rasmîn samuha | tejo yat te rûpam kalyânatamam tat te pasyâmi yo’sâvasau purushah so’hamasmi ||