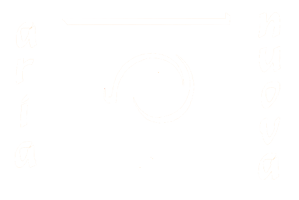LA VITA DIVINA
Impressioni e riflessioni personali
(Tommaso Iorco)
Tommaso Iorco è il curatore del libro La vita divina, traduzione italiana del testo di Sri Aurobindo The Life Divine, che l’Autore stesso considerava la sua più importante opera in prosa. Il volume, edito da Samizdat, è stato pubblicato il 24 aprile 2024.
Vi sono testi di Mère e di Sri Aurobindo che ho letto e riletto diverse volte nel corso degli ultimi quarant’anni — in merito ad alcuni, in particolare, non saprei nemmeno dire quante volte li ho compulsati. The Life Divine figura tra questi ultimi. A ogni successiva rilettura, ho compreso qualcosa in più e ho trovato nuove fonti d’ispirazione.
Quando poi ci si accinge a tradurre un’opera di tale magnificenza, una sorta di timore reverenziale assale il traduttore coscienzioso. “Riuscirò a trasporre almeno in parte lo straordinario potere della parola dell’Autore?” – questo il primo quesito. Infatti, non è tanto una questione di significato, quanto – ancor prima – di energia creativa, di forza in azione, di potenza vibratoria.
Tradurre la poesia di Sri Aurobindo fu per me un’operazione altrettanto delicata ma decisamente più spontanea; pur avvertendo il medesimo timore (non soltanto reverenziale), mi trovai decisamente in un campo a me più congeniale. La prosa filosofica è tutt’altro dominio, lo sappiamo. Non che mi possa considerare sprovvisto in tal senso: ritengo di essermi confrontato con tutti i più importanti testi filosofici della tradizione euroasiatica (difficilmente è sfuggito qualcosa alla sete di indagine della mia giovinezza). Piuttosto, è la forma mentis a fare la differenza.
Mi occorse parecchio tempo prima di decidermi di avventurarmi nella traduzione di The Life Divine. A dire il vero, non è mai stato nelle mie intenzioni cimentarmi nell’impresa – alcune circostanze mi hanno spinto ad accettare la sfida e devo ringraziare gli eventi della vita per avermici indotto: traducendo, ho avuto modo di penetrare il testo come mai mi era capitato in tutte le puntuali riletture dell’originale, scoprendovi tesori che mi erano stati finora preclusi e che non immaginavo mi sarebbero mostrati grazie al lavoro di traduzione.
Quando giunsi al termine di tale impresa, mentre ero impegnato nell’ultima rilettura delle bozze, ricevetti una missiva da parte di Beppe Picaro (a cui avevo proposto di controllare la mia traduzione e di segnalarmi eventuali carenze) in cui, bontà sua, lodò il mio lavoro e mi propose di mettermi a scrivere un articolo di approfondimento. Queste le sue testuali parole:
«La tua traduzione è, senza dubbio, eccellente. Sai cosa sarebbe interessante? Una prefazione, una postfazione, commentario, intervista o autointervista. Perché tradurre Sri Aurobindo? Cosa significa per te? Ci sono delle parti che ti hanno colpito durante la traduzione? Un modo per rompere la barriera del testo scritto e introdurre il linguaggio immediato della conversazione.» (3 gennaio 2024).
Mi proverò, quindi, a rispondere alle suddette domande, una per una.
— “Perché tradurre Sri Aurobindo?”
La risposta più immediata e, come si suol dire, “di pancia”, per me sarebbe: per amore. Amo Mère e Sri Aurobindo e tradurre equivale ad accostarmi il più possibile alla loro vibrazione, alla loro Forza. In apertura de “La vita divina”, nelle pagine dedicate all’indice dei capitoli, ho voluto riportare la seguente citazione di Mère:
Gli scritti di Sri Aurobindo dovrebbero essere letti in inglese,
e i miei in francese.
Sri Aurobindo should be read in English,
And I should be read in French.
(da Education, 4.3.1966).
Lo confesso: con scarsa indulgenza nei confronti di quanti non conoscono l’inglese e il francese, quando qualche italiano mi chiedeva di tradurre The Life Divine, mi limitavo puntualmente a invitarlo a studiare l’inglese!
Alla fine, però, ho ceduto alla tentazione. Spero di avere reso un buon servigio. Sono comunque consapevole che (come spiegato poc’anzi) tale lavoro si è rivelato anzitutto utile per me, ai fini di un sempre maggiore approfondimento del testo.
Tradurre è per me un impegno per nulla inferiore allo scrivere libri miei. E, come cennavo, la responsabilità è di gran lunga maggiore. Sta agli altri giudicarne la qualità, ovviamente, non certo a me; quello che unicamente posso dire, in linea generale, è che mi sono esercitato per lunghi anni, prima di decidere di pubblicare qualche traduzione. Quando si intende offrire i frutti del proprio lavoro, sono assolutamente persuaso che occorra innanzitutto imparare a fondo il mestiere, e solo quando ci si sente sufficientemente esperti ci si può avventurare nel proporre ai potenziali lettori il risultato delle proprie fatiche. Un atteggiamento superficiale, purtroppo, va per la maggiore e contraddistingue quanti credono di poter imparare sul campo, senza essersi prima forniti del necessario bagaglio esperienziale. Ho conosciuto troppi sedicenti traduttori che intraprendevano tale compito unicamente per sé stessi (operazione più che legittima e, anzi, alquanto lodevole), in quanto non conoscevano sufficientemente l’inglese e, per cercare di meglio comprendere il testo, tentavano di tradurlo; il guaio interviene quando si considera buona quella traduzione dilettantesca, al punto da pretendere di pubblicarla (e, in aggiunta, quando le case editrici non hanno scrupolo alcuno a pubblicare, indisposti – non di rado addirittura incapaci – a coglierne i gravi difetti). Non intendo soffermarmi su questo punto. Qualche esempio, tuttavia, non lo reputo fuori luogo. Un paio di versi poetici di Sri Aurobindo si prestano bene allo scopo. Il primo verso che voglio prendere in considerazione è tratto da Savitri (epopea incommensurabile, al punto da considerarla personalmente la più fulgida stella del firmamento poetico mondiale):
And never lose the white spiritual touch,
(III.X.III.534).
L’eccellente traduzione di Mère in francese suona così:
Sans jamais perdre le blanc contact de l’esprit,
(Agenda, vol. VI - 8.05.1965).
Come si può notare, non si tratta di una traduzione letterale: in pratica, constatiamo l’omissione della congiunzione inziale presente nell’originale; la resa di touch con contact (in luogo del più letterale toucher); la modifica di spiritual con l’esprit (in luogo di spirituel). Come ho già avuto modo di precisare (proprio nell’introduzione alla mia traduzione di Savitri) nel passare da una lingua a un’altra, occorre saper trovare le giuste correlazioni, non necessariamente corrispondenti a una traduzione pedissequa e meccanica, parola per parola. La stessa Mère non di rado si sofferma sulla necessità di tradurre cercando di cogliere il genio della lingua, in luogo del modo pedestremente letterale.
Per il secondo esempio che intendo offrire, mi avvalgo di un verso tratto dal poemetto Urvasie –
The hero self-discrowned, Pururavus,
(canto IV)
Ebbene, una pessima traduzione (pretesa “letterale”, in cui si ravvisa tutta l’imperizia del traduttore autoschediasta) si presenterebbe in questo modo:
l’eroe che si è tolto la corona da solo, Pururavus,
La forza e la grazia poetica si sono volatilizzate del tutto, lasciando sul foglio un corpo privo di vita e di musicalità, peraltro alquanto sciatto. Ma è esattamente quello che fanno i traduttori letterali!
Una traduzione decisamente più accettabile, seppure ancora troppo prosaica, sarebbe la seguente:
l’eroe che si è detronizzato, Pururavas
L’inglese discrowned (letteralmente: “toglier la corona”) è stato reso con quanto di più affine esiste in italiano in merito all’atto compiuto (e non alla traduzione letterale, ridondante e ridicola, in italiano); però ancora non ci siamo del tutto: la traduzione manca di ritmo.
Arriviamo dunque a quella che possiamo considerare un’ottima traduzione, tramite l’utilizzo di un endecasillabo sdrucciolo a maiore:
l’eroe detronizzatosi, Purūravas,
Per inciso, notiamo come la prima traduzione, quella letterale, riporta il nome del personaggio esattamente come Sri Aurobindo (per giusti e fondatissimi motivi) lo anglicizza dal sanscrito, in modo da renderlo correttamente leggibile al lettore inglese e che, in italiano, ne deformerebbe invece il suono reale (la traduzione che ho definito “prosaica” lo italianizza, mentre quella in versi tiene a riportare la corretta traslitterazione: in quest’ultimo modo soltanto, infatti, chi non conosce il sanscrito può capire dove si trova la vocale lunga che permetta di porre il giusto accento nella decima sede dell’endecasillabo).
— “Cosa significa per te?”
Anche in questo caso, la risposta spontanea che sorge in me è la seguente: il Divino è sceso sulla terra e ha voluto farci la grazia di sussurrare alle nostre orecchie il senso e il perché della manifestazione fenomenica. I soloni sorrideranno di fronte a una risposta così imbarazzante (per loro, non certo per me!) e la cosa non può che lasciarmi del tutto indifferente (a dirla tutta, infastidirli, o perlomeno spingerli a sottovalutarmi e a tenersi il più possibile lontani da me, mi procura un inestimabile sollievo!).
Nel mondo accademico si blatera tanto di “metodo epagogico” contrapposto al “metodo epistematico” e via enfatizzando (quanto si gongolano quando pronunciano simili paroloni!), mentre in realtà chiunque abbia avuto la disgrazia di frequentare gli ambienti universitari, in particolare negli ultimi due o tre decenni, si è potuto ampiamente accorgere di quanto prevalga ormai quasi dovunque il “principio di autorità” – ovvero, si ritiene valida una determinata affermazione (storica, letteraria, linguistica, non di rado perfino medica o scientifica, come la covidiozia ha ampiamente mostrato) quando viene pronunziata da un personaggio considerato autorevole in materia, senza curarsi granché di verificarla (interessante sarebbe, peraltro, indagare su tale stima di autorevolezza, su come sia stata acquistata). Viceversa, se un ricercatore che non gode di una qualche reputazione presso il mondo accademico (in quanto non facente parte della sua cerchia – un Heinrich Schliemann qualunque, tanto per limitarci a un esempio tra milioni) effettua una qualche scoperta, essa non viene minimamente presa in considerazione (quando addirittura non viene attaccata a priori e sbeffeggiata con tracotante protervia), persino qualora presentasse prove schiaccianti: dovrà battersi a lungo e, se dimostrerà di avere sufficiente tenacia, dopo parecchi anni (o decenni) il mondo accademico recepirà la scoperta e la farà propria (non di rado, se possibile, cercando di attribuirsi la paternità o quantomeno qualche merito, apportando un più o meno trascurabile correttivo).
Questo è lo stato in cui “il mondo della Qultura” attualmente si trova. Ma passiamo oltre e torniamo a occuparci di vita divina! Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
La scienza ha scoperto che tutti gli oggetti cosiddetti inanimati (un sasso, un minerale, un tavolo, una conchiglia…), sebbene appaiano immobili, sono in realtà in continuo movimento: gli atomi di cui sono composti vibrano e interagiscono senza posa.
La spiritualità ha scoperto che tutto ciò che si muove (animali umani e non umani, come pure gli stessi atomi) è in realtà sorretto da uno Spirito perfettamente immobile: ogni moto procede dal Silenzio antecosmico.
Mère e Sri Aurobindo hanno reso operativa una terza posizione, che comprende in sé e supera le scoperte della scienza fisica e della spiritualità. Non basta, infatti, percepire la suprema Realtà contenente in sé l’eterna Stasi e l’eterna Dinamo, come qualche rilevante mistico ha fatto nel passato (primum movens immobile, πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον): occorre vivere una simile percezione per identità, arrivando a renderla attiva, al punto da incarnarla – il corpo fisico, la sostanza materica con cui ogni singola monade si riveste, deve poter adeguatamente esprimere l’Essere atempore nel Divenire spaziotemporale. Questa l’essenza di una effettiva VITA DIVINA. Questa la sfida lanciata da Mère e Sri Aurobindo. La coscienza-forza sopramentale è l’anello di congiunzione fra spirito e materia, fra cielo e terra, fra essere e divenire. Ma non si tratta di una facoltà apicale della mente: è qualcosa di radicalmente altro (quantunque la sua alterità non neghi affatto la realtà della mente né, tantomeno, della materia) – «Supermind is not mind at all; it is something different.» (Sri Aurobindo, Letters, vol. XXX): “La sopramente non è affatto la mente: è qualcosa d’altro”.
— “Ci sono delle parti che ti hanno colpito durante la traduzione?”
Nuovamente, mi lascio andare a una prima riflessione istintuale: tutto quanto mi ha colpito – ogni singola frase, direi addirittura ogni singola parola e perfino l’utilizzo della punteggiatura. L’architettura complessiva dell’opera è a dir poco magistrale, di una eccellente perfezione. Qualunque dettaglio, dalla scelta linguistica di ciascun termine al modo in cui è stata congegnata la sequenza delle varie argomentazioni e la stessa costruzione di ciascun periodo, è superlativo. In apertura del presente articolo ho accennato al mio impegno come lettore di testi filosofici, e alla convinzione di essermi intrattenuto con tutti i più importanti testi di filosofia mondiale (alcuni letti con sincera ammirazione e con diletto). Ebbene, non un solo scritto di costoro ritengo degno di stare al fianco di The Life Divine (altra affermazione che farebbe inorridire qualunque professorale occupante – meritatamente o per vile raccomandazione – una qualunque cattedra di filosofia); l’unico neo che attenua un poco questa mia convinzione è la consapevolezza di non aver letto tutti i più grandi filosofi nel loro idioma nativo: non di rado mi sono avvalso di traduzioni. Ho ammirato (senza tuttavia condividere in toto) la limpida chiarezza di alcuni filosofi e, certo non per caso, mi sono sentito maggiormente attratto da quanti fra loro ho percepito dotati di un sia pur vago spirito poetico; mi riferisco, in particolare, a Platone, a Giordano Bruno, a Nietzsche, che pongo in cima alle mie preferenze. Il giovane Platone amava scrivere poesia (è stato forse il primo slancio espressivo scaturito direttamente dalla sua anima), distrugge ogni suo componimento lirico quando venne accettato in qualità di discepolo da Socrate (che, a malgrado della sua indiscutibile grandezza, non comprese lo spirito autentico della poesia, e solo nei suoi ultimi giorni di vita, segregato in carcere in attesa della cicuta, avvertì in sé qualcosa di sbagliato in un simile atteggiamento e tentò sia pur tardivamente e in modo maldestro di porvi rimedio); è un fatto che la sua prosa sia una delle più raffinate della letteratura greca (forse la più bella in assoluto). Quanto a Nietzsche e a Giordano Bruno, i loro scritti vengono non di rado fatti precedere da composizioni poetiche e nella loro stessa prosa non di rado si coglie un sia pur distante fruscio delle ali delle Muse.
Nel grado più basso della scala delle mie preferenze, si trovano poi quei filosofi che, pur essendo dannatamente pedanti e noiosi (non di rado insopportabilmente faziosi e umanamente alquanto mediocri), offrono qualche stimolo: Descartes (alias Cartesio o, come Vico lo chiamava ironicamente, Delle Carte), l’insopportabilmente razzista Hume e pochi altri. Nel mezzo, fra questi due opposti poli, si trovano parecchi nomi di rilievo: Aristotele, Avicenna (Ibn Sīnā), Kant, Leibniz, Spinoza, Hegel, Schopenhauer e altri ancora. Fra gli asiatici, un posto speciale occupa certamente l’indiano Śaṃkara (pure lui, peraltro, redigeva sovente i suoi trattati filosofici facendo ricorso alla metrica poetica), uomo dall’intelletto preciso, tagliente, affilato come la lama di un coltello, la cui punta è riuscita a trafiggere il cielo – e il sangue che ne è colato ha afflitto le successive generazioni del popolo indiano con una visione marcatamente pessimista della vita. Vi sono poi filosofi sgrammaticati ma pregni di contenuti, con Plotino in testa (i cui scritti sono talmente sovrabbondanti di sostanza, che non si può non ammirarli). Decisamente al di fuori delle mie preferenze, stanno invece i filosofastri e quei cattedratici sedicenti filosofi: individui boriosi, saccenti, repellenti – solo quanti occupano le cattedre di indologia li superano (e abbondantemente) nel loro apparirmi ributtanti. Tra i più noti filosofi da strapazzo, mi limito a citare due esempi fra tutti, particolarmente sopravvalutati: Heidegger e Adorno. L’onanismo intellettuale di Theodor è francamente insopportabile, ma l’altro è assai peggio. Thomas Bernhard fu colui che seppe ritrarlo meglio (la seguente citazione è un mio assemblaggio fra vari suoi scritti – mi si scusi per la lunga divagazione, ma da troppo tempo cercavo l’occasione giusta per dare libero sfogo al mio disgusto per l’autore dei Quaderni neri e per le innumeri orde dei suoi epigoni):
«Heidegger – quel ridicolo filisteo nazista coi pantaloni alla zuava – se lo sono pappato tutti a grandi cucchiaiate, con una fame da lupi, per decenni. Se vi capita di recarvi a un ricevimento della media borghesia o anche solo della piccola borghesia semi-aristocratica, è alquanto probabile che Heidegger vi venga servito già prima dell’antipasto: non vi siete ancora tolti il soprabito e già vi viene offerta una fettina di Heidegger, non avete neppure fatto in tempo ad accomodarvi e già la padrona di casa è entrata servendovi Heidegger insieme allo sherry su un vassoio d’argento. Heidegger è un budino di letture, insapore ma facilmente digeribile. Ho sempre avuto la sensazione che Heidegger fosse un ciarlatano, il quale per tutta la vita non ha fatto altro che sfruttare tutto quanto gli stava intorno, e spolpando a destra e a manca si abbronzava sulla sua panchina di Todtnauberg; è sempre stato un semplice cabarettista, piccolo borghese e spaventosamente megalomane: un imbecille delle Prealpi, insomma. Heidegger aveva un volto ordinario, non un volto dal quale trapelasse l’ingegno (di cui era completamente sprovvisto); egli era infatti del tutto privo di fantasia, assolutamente incapace di sensibilità – una mente inzuppata di kitsch, che pascolava sui prati della filosofia tedesca e che per decenni ha lasciato cadere il suo lezioso sterco nella Foresta Nera. Se già i wagneriani sono insopportabili, figurarsi gli heideggeriani» (T. Bernard).
Vi sono poi filosofi considerati “minori” che talvolta fanno luce su alcuni aspetti collaterali (ma non per questo meno degni di nota) rispetto alle grandi questioni esistenziali, dotati di una particolare dota intuitiva; fra questi, Günther Andersè certamente quello che maggiormente ho trovato stimolante nel fotografare (non di rado in anticipo sui tempi) l’attuale assetto sociale. Anche lui, peraltro, ha messo in luce le ambiguità di Heidegger (di cui per alcuni anni fu allievo all’università, quindi ebbe la sventura di conoscerlo personalmente), con uno stile e con modalità ancora più precise e circostanziate rispetto alle invettive mordaci e geniali di Thomas Bernard. Ecco cosa scrive in proposito: «Chi, come Heidegger, prende sul serio le domande “che cosa è l’uomo?” e, rispettivamente, “chi è l’uomo?”, con ciò dimostra già di avere risposto affermativamente, solo per arroganza nei confronti dei milioni di specie esistenti nell’universo, all’altra domanda, fondamentale, se sia giustificato concedere all’uomo una particolare posizione metafisica o teologica. E Heidegger questo lo ha fatto, chiamando per esempio gli uomini “pastori dell’essere”, proprio allo stesso modo degli “antropologi filosofici” da lui schermiti come gente alla moda, dei quali tuttavia egli non aveva alcun diritto di prendere le distanze in modo tanto altezzoso». E con questa citazione liquidiamo definitivamente il guascone nazista!
Profondo vaticinatore, Anders possedeva un intuito sopraffino, un fiuto pressoché infallibile, una visione cristallina e ‘prognostica’: tutte caratteristiche rare nei filosofi e del tutto assenti nei filosofi a noi contemporanei (quasi sempre sedicenti filosofi, autonominatisi tali solo in virtù di un misero pezzo di carta ottenuto all’università o in quanto detentori di una cattedra vanagloriosa). Non a caso, già nel lontano 1979 Anders ingiunse a tutti noi, senza mezzi termini, che «dobbiamo imparare ciò che i vati dell’antichità facevano o erano convinti di fare: prevedere il futuro. Le viscere che dobbiamo imparare a leggere in modo prognostico non sono quelle degli animali sacrificali, bensì quelle delle apparecchiature, delle macchine. Sono queste che ci rivelano il mondo di domani e di che tipo saranno i figli dei nostri figli, finché ce ne saranno ancora». Questa e la precedente citazione provengono dal secondo volume della sua opera “L’uomo è antiquato” (titolo alquanto esplicito!), mentre dal primo volume (di qualche decennio precedente) ricaviamo quanto segue: «Dobbiamo cogliere gli avvenimenti più lontani nel tempo, quelli venturi, e sincronizzarli con un punto nel tempo, quello presente, come se accadessero ora. Infatti, avvengono adesso, perché dipendono dal momento presente; e dato che succedono adesso, riguardano tutti noi, poiché diamo loro inizio fin da ora con ciò che stiamo facendo in questo momento. È innegabile che, così facendo, postuliamo un rapporto con il tempo del tutto insolito. Il futuro non deve più estendersi davanti a noi, ma deve venire captato da noi, deve essere appresso a noi, esserci presente. Non si potrà certo apprendere questo nuovo rapporto con il tempo da un giorno all’altro. Speriamo resti il tempo per potersi esercitare in questo nuovo rapporto con il tempo.» (1956). Irreligioso e razionalista, Anders perviene spesso al cuore di un esoterismo genuino: «Chi viene proiettato su una terra incognita non può incominciare subito a misurarla e a farne una rivelazione cartografica. Inizialmente dovrà affidarsi al caso, dovrà procedere vagando qui e là. In un primo tempo, si dirigerà verso ciò che subito lo colpisce: un albero, una vetta. Ma è assai poco probabile che raggiunga la sua meta per la via più corta – anzi, si smarrirà nel suo procedere oltre e sarà costretto a cambiare direzione; in un altro si troverà addirittura costretto a tornare indietro; e, seppure nel frattempo non dimentica la sua meta, la perderà sicuramente di vista. Tuttavia, questo andare vagando non sarà inutile: solo così si può imparare a conoscere il paese in tutti i particolari; solo così gli verrà offerta la possibilità di giungere improvvisamente in un luogo da cui si apre per la prima volta una panoramica d’insieme. Senza dubbio avrebbe potuto raggiungere questo luogo per un percorso più diretto. Se ci fosse stato un percorso. Ma il percorso potrà essere tracciato proprio soltanto in base a questo girovagare». Concludiamo le citazioni di questo libero ricercatore con una riflessione particolarmente attuale, quasi una radiografia della pandemenza consumatasi di recente, dalla quale l’umanità nel suo insieme è ben lungi dall’essersi risvegliata: «Quanto più totale è un potere, tanto più muto il suo comando. Quanto più muto il suo comando, tanto più naturale la nostra obbedienza. Quanto più naturale la nostra obbedienza, tanto più assicurata la nostra illusione di libertà. Quanto più assicurata la nostra illusione di libertà, tanto più totale il potere. Questo il processo circolare, o a spirale, che la società conformista mantiene e che, quando si è messo in moto, continua automaticamente a perfezionare» (1962). Tristemente vero!
Nell’ambito della ricerca filosofica, inoltre, non sono certo da trascurare le donne, che l’universo maschile ha cercato di tenere il più possibile lontane dalla cultura; qui mi limito a ricordare Hannah Arendt e Maria Zambrano (le mie preferite), ma ho l’impressione che anche in tale ambito le donne avranno molto da dire e da dare: nell’investigare le grandi tematiche dell’esistenza, riusciranno certamente a evidenziare verità che ai filosofi maschietti sono finora bellamente sfuggite.
Philosophies that strip all problems bare
But nothing ever have solved since earth began,
Savitri, III.X.IV.133-134.
Le filosofie che a nudo mettono tutti i problemi
senza aver nulla risolto dall’inizio della terra [.]
Ben al di sopra di ogni filosofia, si elevano infine i sofi: coloro, cioè, che non cercano la saggezza (come invece fanno i φιλόσοφοι), ma la detengono spontaneamente: Sri Aurobindo (che, per sua stessa ammissione, non è mai stato un filosofo e si è solo limitato a scrivere filosofia) era un Sofo, un Ṛṣi, insieme a Eraclito (che i docenti universitari abbassano al rango di filosofo, dato che hanno malamente frainteso il senso dei frammenti a noi pervenuti – già i suoi contemporanei lo definivano “oscuro”, nel senso di impenetrabile, skoteinós) e ai compositori del Ṛgveda, delle Upaniṣad, della Bhagavadgītā e a tutti i più grandi poeti mistici della storia dell’umanità. I cattedratici di cui sopra continuano a parlare a sproposito dei “filosofi upanishadici”, mentre in realtà di tratta di sublimi poeti-veggenti, il che è tutt’altra cosa… Anche per questo ne travisano (talvolta nel modo più grottesco) il sublime contenuto sapienziale, trattandolo alla stregua di un prodotto della mente concettuale (commettendo uno sproposito badiale!), in luogo di un puro dettato poetico di eccelsa levatura. Non diversamente da quanto accade nei confronti dello stesso Sri Aurobindo... Più volte ho avuto modo di soffermarmi sui grandi travisamenti (in buona o mala fede) relativi all’operazione fuorviante consistente nel ridicolo tentativo di appiccicargli etichette di ogni sorta: induista, filosofo, spiritualista e via delirando. Riflettendo sugli accademici dei nostri tempi, mi vengono puntualmente alla memoria tre versi di Sri Aurobindo:
la filosofia si eleva al pensiero fra le nubi
e la scienza forze occulte della natura carpisce:
enormi ginn al servizio d’agi angusti d’un pigmeo
Savitri, III.X.III.213-215
In definitiva, questo mio impegno traduttivo mi ha permesso di cogliere appieno quanto Mère dice in un passo dell’Agenda:
quand on veut vraiment comprendre un livre,
il faut le traduire.
(8.08.1964)
[«Quando si intende comprendere un libro per davvero, occorre tradurlo»].
Nel dominio della prosa, le traduzioni cui mi sono dedicato non avevano mai esercitato un simile effetto su di me… Forse perché si trattava di testi meno voluminosi (Sri Aurobindo, scherzosamente, paragonava The Life Divine a “un elefante adiposo” – a flat elephant) e meno pregnanti; sta di fatto che mai prima d’ora avevo potuto constatare la verità della suddetta affermazione. Tradurre questo capolavoro mi ha spalancato le porte verso una nuova e più ampia comprensione… Non pretendo certo di averne colto appieno il significato in tutte le sue innumerevoli sfaccettature, ma qualcosa di fondamentale ha fatto breccia e mi ha permesso di penetrare il testo da dentro, per così dire; mai prima d’ora mi era stato dato di sondarne così dettagliatamente la sua profondità, la sua ampiezza, la sua elevatezza impareggiabili. Senza parlare della bellezza del suo dettato, cesellato con una perfezione e una grazia sopraffine.
Non ho certo la pretesa di avere realizzato la migliore traduzione possibile (pur se questo era nei miei intenti: lo ammetto spudoratamente!), ma spero almeno di avere reso un servizio degno.
Prima di chiudere, tengo a ringraziare sentitamente quanti hanno avuto la pazienza di leggere le bozze della traduzione, offrendomi preziosi suggerimenti tesi a migliorarne la resa (augurandomi di aver saputo trarre il massimo profitto dalle loro segnalazioni). In particolare, ringrazio Simonetta, il cui apporto reputo determinante nel dipanare e rendere piani i passaggi più ostici da trasporre in italiano. E ringrazio pure quanti hanno avvertito (e concretato!) la spinta a sostenere le spese di stampa del volume: senza di loro, questa mia opera di traduzione sarebbe rimasta nel cassetto (le case editrici italiane sono troppo impegnate nel cercare di arraffare soldi pubblici e, quindi, non hanno più tempo da dedicare a quello che sarebbe il loro compito principale e fondamentale: cercare testi di valore e autori di pregio da pubblicare e mettere a disposizione dei lettori).
Ecco. Spero vivamente di NON essere riuscito nell’intento di parlare di The Life Divine! Lietissimo di aver deluso chi si attendeva di leggere chiacchiere erudite sulla Weltanschauung escatologica di Sri Aurobindo. Lascio a ciascuno la gioia di immergersi direttamente e fare le proprie personali scoperte, limitandomi qui a riportare una sintetica riflessione di Giuseppe Mazzini: «Ogni periodo dev’esser preparazione all’altro, ogni sviluppo temporario deve giovare allo sviluppo continuo ascendente della vita immortale che Dio trasfuse in ciascuno di noi».
Tommaso Iorco
God shall grow up while the wise men talk and sleep;
For man shall not know the coming till its hour
And belief shall be not till the work is done.
SRI AUROBINDO, Savitri, I.I.IV.339-341.